|
Cosa Resterà del Blues italiano? (di Amedeo
Zittano)
Sbarcato nella nostra penisola durante la seconda guerra mondiale, il Blues è
entrato a far parte del nostro patrimonio culturale musicale. Nel 1945 il primo
concerto Blues in Italia (dedicato ai soldati americani) fu a Torino dove si
esibì Big Bill Broonzy, da allora ad oggi una lunga serie di bluesman americani
e inglesi saliranno sui palchi d’Italia.
Negli anni sessanta nacquero le prime blues band italiane sia sulla scia dei
musicisti del dopoguerra (prevalentemente nelle cittadine frequentate da
militari americani e inglesi), sia dall’ascolto del materiale discografico (in
genere erano favorite le grandi città). Gran parte delle discografie Blues
importate in Italia erano quelle britanniche dei nomi più famosi americani. Lo
spirito del Blues, forse perché rispecchiava lo stato d’animo popolare
finalmente “libero” dopo lunghi anni di dittatura e guerre, si rilevò da subito
una realtà attuale e fresca. Molti se ne innamorarono tanto da divulgarlo con
passione; la maggior parte erano musicisti poco famosi e amanti della musica in
generale che diedero fermento ad un nuovo movimento. Non era raro ascoltare
blues live nei pub o nelle manifestazioni di piazza ed anni dopo, durante l’era
Beat, nacquero le prime produzioni editoriali, discografiche (*), radiofoniche e
televisive. Nel 1975 a Milano la Red Records finì di stampare il primo disco
italiano interamente Blues prodotto da una casa discografica, dal titolo “Treves
Blues Band”; a ruota vennero Guido Toffoletti (Straight Ahead 1978 Sono Beat) e
Roberto Ciotti (Super Gasolina Blues 1978 Cramps). Ovviamente il Blues non lo ha
fatto solo chi ha avuto opportunità discografiche; in Italia ogni regione ha le
sue blues band.
Attualmente musicisti blues italiani, curiosamente più noti all’estero che nel
nostro paese, alimentano con le loro attività una scuola che fino a oggi vede
partecipi centinaia di band in tutto il territorio. Purtroppo però, ogni
conquista culturale ha un prezzo da pagare e, se in Italia vivere di musica è
difficile, vivere di Blues è quasi impossibile. Ciò penalizza gravemente il
blues italiano in quanto la necessità di dover trovare un primo lavoro di
"sostegno" significa non poter considerare il Blues una professione.
Le cause e le responsabilità, per quanto se ne possa dibattere, sono tipici dei
processi evolutivi. Questa è l’era del consumismo e del condizionamento di
massa: in buona sostanza, sono “tempi duri per il Blues”. Certo, continuare
sulla nostra strada con ostinazione è già un notevole contributo ma questo
potrebbe non bastare… se il sistema dal business di massa, non alimenta anche i
circuiti culturali di nicchia, prima o poi queste cesseranno di esistere.
Ovviamente, la strada da intraprendere è la stessa che ha consentito la nascita
dello Spaghetti Blues e cioè, la divulgazione mediante tutti gli strumenti
promozionali e strategici. In primis la condivisione delle informazioni tra i
musicisti, gli addetti ai lavori ed il pubblico. Questo è un ottimo lubrificante
che contribuisce fortemente all’unione delle risorse moltiplicandone i
risultati.
Le difficoltà maggiori che ha un movimento spontaneo a reagire a tale
situazione, è il coordinamento degli individui nel cooperare tra loro, ma per
fortuna la tecnologia odierna ci viene incontro (una volta tanto!) e con un
personal computer si possono superare le distanze e ottimizzare di molto i
tempi.
Qualcuno potrà pensare: “tra il dire ed il fare...”; io ritengo però che questa
differenza, come in tutti i processi evolutivi della razza umana, contribuiamo a
farla anche noi che, nonostante tutto, continuiamo a camminare sulla strada.
(*) in quegli anni molti artisti (come Battisti, Mina e altri)
proposero nei loro lavori discografici brani blues In seguito Edoardo Bennato e
Pino Daniele furono quelli che contribuirono maggiormente alla diffusione della
Musica del Diavolo.
C'era una volta il Torano blues festival (di
Paolo Valente)
C'era una volta, in un piccolo e sperduto paesino della provincia di Cosenza, in
Calabria, un piccolo Festival portato avanti con dedizione e sacrificio da un
gruppo di appassionati della musica del Diavolo. Il tutto è cominciato nel 1995,
quando ci siamo detti: perché non provare ad organizzare, anche se in piccolo,
una rassegna che riguardi il Blues ? Così dopo un giro di telefonate, anche per
renderci conto della fattibilità della cosa e pur
 sapendo
già che non sarebbe stato facile reperire i fondi necessari, ci siamo buttati a
capofitto in questa splendida avventura. Naturalmente non è stato facile far
partire l’iniziativa, circondati come eravamo da tanti dubbi e perplessità,
però… sapendo
già che non sarebbe stato facile reperire i fondi necessari, ci siamo buttati a
capofitto in questa splendida avventura. Naturalmente non è stato facile far
partire l’iniziativa, circondati come eravamo da tanti dubbi e perplessità,
però…
Col passare del tempo ci si rendeva sempre più conto che lavorando bene e con
serietà si potevano comunque ottenere buoni risultati, anche senza avere grandi
disponibilità finanziarie. Certo le difficoltà c’erano, eccome, però
l’entusiasmo ci dava la forza per continuare caparbiamente. Ricordiamo solo
alcuni dei nomi che hanno partecipato alle 4 edizioni del festival, da Michael
Coleman a Maurice John Vaughn, da Deitra Farr a Vas-Tie Jackson, Jimmy D. Lane,
John Primer e così di seguito, nonché alcune delle band italiane emergenti più
interessanti del panorama Blues Italiano.
Nonostante i buoni risultati di pubblico e la continua crescita del festival,
questo splendido sogno si è interrotto nel 1998, con l’ultima edizione. Ora,
stare qui a spiegare tutti i motivi dell’accaduto non mi sembra opportuno, ma
lascio alla vostra fervida immaginazione intuire cosa può essere successo. Non
siamo i primi e non saremo gli ultimi a subire scelte che il più delle volte
esulano da qualsiasi ragionevolezza, per cui…
Questo articolo, anche se a distanza di 5 anni, ha come obiettivo quello - in
primis - di esprimere tutto il nostro disappunto per essere stati abbandonati a
noi stessi, un po’ da tutti, ma nello stesso tempo vuole essere da stimolo per
tutti gli appassionati che operano in realtà piccole come Torano Castello. Come
dicevo prima, la passione, la serietà, il lavorare con dedizione, fa si che
anche in piccole realtà si possano raggiungere dei traguardi interessanti. Certo
bisogna lottare a denti stretti, visto soprattutto i tempi di ristrettezze degli
ultimi periodi.
Io posso comunque dire che, anche se per soli 4 anni, abbiamo vissuto un sogno
incredibile, per il quale ne è valsa la pena, a prescindere da come sia finita.
Il mio messaggio è questo: anche solo per un giorno non privatevi della
possibilità di vivere un’emozione indescrivibile, come quella di organizzare un
Blues festival.
A questo punto vi chiederete: ma Torano Blues ritornerà? Chi lo sa, posso solo
dire che al momento non ci sono le condizioni ideali per riprendere, magari un
giorno… si vedrà.
Radio: un
triste ritorno al passato (di Michele
Lotta)
L’argomento che mi appresto ad affrontare, ben lungi
dal voler rappresentare una retorica esaltazione del passato, è il racconto di
un sogno che si è avverato. Per i più giovani questa è la testimonianza di un
periodo irripetibile vissuto in prima persona.
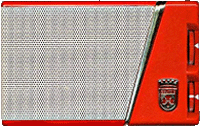 La
mia generazione è cresciuta bella e tosta, sostenuta da psichedeliche visioni e
magico entusiasmo, ma stenta a sopravvivere nel terzo millennio (un po’ come
accade per la foca monaca…). Quelli che hanno anteposto i sogni alla
concretezza, spendendo gli anni migliori senza mezze misure (ricevendo sovente
in cambio niente di più di un sano appagamento spirituale), si schiantano
inesorabilmente contro un solido muro costruito da materiali tanto resistenti
quanto poco nobili come: denaro, fama, potere. Filosofando si potrebbe dire che
per ogni muro abbattuto altre decine ne vengano eretti, ma se fino a ieri era
sufficiente assestare delle robuste picconate per demolirli, oggi non si
saprebbe che strumenti usare. Anche i pilastri portanti della società
contemporanea sembrano affondare definitivamente le speranze di una felicità
scevra da subdole convenzioni. Si, le "convenzioni" ovvero tutte quelle regole
che costruiscono il linguaggio per comunicare in un mondo sempre più omologato
ed appiattito su di esse. E’ ormai appurato che i mass media siano gli strumenti
di diffusione del “verbo universale”. Televisioni, radio e giornali, arrivano
ovunque informando e, al tempo stesso, condizionando. La
mia generazione è cresciuta bella e tosta, sostenuta da psichedeliche visioni e
magico entusiasmo, ma stenta a sopravvivere nel terzo millennio (un po’ come
accade per la foca monaca…). Quelli che hanno anteposto i sogni alla
concretezza, spendendo gli anni migliori senza mezze misure (ricevendo sovente
in cambio niente di più di un sano appagamento spirituale), si schiantano
inesorabilmente contro un solido muro costruito da materiali tanto resistenti
quanto poco nobili come: denaro, fama, potere. Filosofando si potrebbe dire che
per ogni muro abbattuto altre decine ne vengano eretti, ma se fino a ieri era
sufficiente assestare delle robuste picconate per demolirli, oggi non si
saprebbe che strumenti usare. Anche i pilastri portanti della società
contemporanea sembrano affondare definitivamente le speranze di una felicità
scevra da subdole convenzioni. Si, le "convenzioni" ovvero tutte quelle regole
che costruiscono il linguaggio per comunicare in un mondo sempre più omologato
ed appiattito su di esse. E’ ormai appurato che i mass media siano gli strumenti
di diffusione del “verbo universale”. Televisioni, radio e giornali, arrivano
ovunque informando e, al tempo stesso, condizionando.
Senza voler qui trattare l’argomento nella sua generalità (per la quale è
comunque possibile applicare dei semplici parallelismi), mi limiterò a
focalizzare l’attenzione sul rapporto tra radio, televisione e musica.
Io sono stato allevato dalla radio e dalla TV in bianco e nero, prima con
l’unico, poi con due, quindi (cosa entusiasmante per i tempi) con i tre canali
della RAI. Era l’epoca in cui la televisione entrava, pian piano, nelle case di
quegli italiani cresciuti con la radio. Ma, nonostante l’impatto che il tubo
catodico avrebbe avuto negli anni seguenti, la radio è sopravvissuta
parallelamente, mantenendo (anche in momenti meno favorevoli) la propria
specificità. Ricordo le serate passate ad ascoltare dalla radiolina a transitor
i pochi programmi musicali che mi aprirono gli orizzonti sul rock e che
trovavano unica corrispondenza nelle pochissime riviste italiane di settore.
Rimarranno ben impressi nella mia mente i "viaggi a luci spente” sulle note di
Rolling Stones, Springsteen, Dylan, Pink Floyd. Iniziava a farsi strada in me il
seme che, germogliando, avrebbe segnato inesorabilmente gli anni a venire. La
data fatidica della svolta fu quel mitico 1976, anno in cui entrò in vigore la
legge che liberalizzò il grande fenomeno (nato in maniera del tutto clandestina
qualche anno prima) della radio libera. Fui tra i primi a cimentarmi con il
microfono: finalmente ciò che avevo sognato per anni diventava realtà. Il
pionierismo dei primi tempi portava con se una poesia ben disegnata da Luciano
Ligabue nel suo film Radio Freccia. Ricordo le luci soffuse sul mixer nelle
notti in cui si annullavano le distanze tra chi stava da una parte
dell’apparecchio e chi ascoltava dall’altra. Ho ancora in mente quella
particolare sensazione determinata dalla musica che viaggia nell’etere
mischiandosi ad esso, passando attraverso porte e finestre chiuse, fino a
raggiungere altre anime sintonizzate, nello stesso momento, con la tua.
La televisione non aveva nella musica il suo argomento principale, il businnes
discografico era agli albori ed il suo punto di riferimento storico era la
radio. L’impatto che generò la radio libera si riflesse in breve ed in maniera
tangibile nelle vendite di dischi che, prima di quel momento, venivano
acquistati d’importazione ed a caro prezzo, cosa che non tutti i ragazzi
potevano permettersi. Gli scaffali dei negozi cominciarono a riempirsi con
quelle copertine che avrebbero consacrato leggende come Hendrix, Morrison,
Marley, R. Johnson, … Era sensazionale accendere la radio alle 10 del mattino ed
ascoltare un programma di blues, piuttosto che jazz o rock. Si andava
rigorosamente in diretta ed i dj’s si alternavano portandosi da casa i dischi
che avrebbero costituito la scaletta del programma. L’entusiasmo era tale che
alcuni di noi sostenevano parecchie ore di trasmissioni. Una sera iniziai alle
20 ed andai in onda sino alle 8 del mattino successivo. Tra decine di caffè ed
altrettante sigarette trascorsi una notte indimenticabile ricevendo una quantità
enorme di telefonate, a tutte le ore, da parte di persone tanto diverse tra
loro: la ragazzina in vena di romanticismo ed il benzinaio del turno di notte,
personale di ospedali e fornai al lavoro. Il popolo della notte trovò nella
buona musica una compagnia che non aveva ancora conosciuto. Pensate quanto fosse
gratificante sentirsi richiedere da voci senza volto - eppure così vicine - quei
brani che avevi fatto conoscere proprio tu!
All’inizio degli anni ottanta la diffusione del 33 giri in Italia raggiunse i
livelli più alti. L’interesse per la musica straniera, sino ad allora
appannaggio di pochi, dilagò a macchia d’olio così come i concerti nei teatri e
nei primi clubs. Un decennio, 1975-85, davvero aureo che segnò un’evoluzione
culturale in tutti gli ambiti sociali. Anche le riviste musicali cominciarono a
moltiplicarsi dividendosi per generi. In quel periodo le canzonette italiane
vennero messe al bando e molti artisti (tra di loro anche personaggi di primo
livello) furono sacrificati sull’altare della cosiddetta esterofilia, il
neologismo che caratterizzerà un’epoca di estremi. Anche i nostri cantautori si
allinearono su temi e musiche d’oltre oceano. L'esterofilia fu il primo segnale
della globalizzazione (allora non si adoperava questo termine) e della volontà
di conoscere e mischiarsi con il mondo. Leggevamo avidamente Kerouac e fummo
folgorati dal mito della "strada". Una generazione cresciuta sull’onda delle
rivolte popolari che si svolgevano in America contro la guerra del Vietnam. Si
creò uno scollamento dalla mentalità dei genitori che rese i giovani (nella
grande generalità dei casi) tanti “rivoluzionari” disposti ad abbattere i cliché
del perbenismo borghese. Un sogno, come dicevo prima, che durò più o meno dieci
anni e che cominciò a sgretolarsi con l’apparizione sulla scena dei networks
radiofonici prima e delle televisioni private da li a poco.
L’escalation fu rapida e sancì la chiusura di un canale importante per la musica
di qualità in favore della musichetta “mordi e fuggi” e dei tormentoni che tanti
soldini hanno fatto guadagnare a chi con la musica ha sempre avuto un rapporto
di puro commercio. Gli stessi giganti della discografia mondiale organizzano
quotidianamente i palinsesti delle radio in funzione dei prodotti che intendono
vendere. Piatti e mixer sono ormai scomparsi ed il dj si trova una scaletta
gestita dal computer, con tot secondi a disposizione per parlare e non perdere
il ritmo segnato da voce-musica-pubblicità in un “continuum” ossessionante.
La differenza che c'è tra i pionieri del microfono di ieri ed i professionisti
di oggi si può sintetizzare nella stessa differenza esistente tra chi proponeva
un tempo, con pochi mezzi e tanta fantasia, delle alternative, e chi oggi si
guarderebbe bene dal farlo (pur avendo maggiori possibilità), pena il calo
dell'audience.
Ancora una volta i sogni e la cultura sono stati spazzati via dai poteri forti
con il conseguente, mortificante, ritorno ad un passato in bianco e nero.
Questo rapido escursus sul rapporto radio-musica ha lo scopo di evidenziare una
delle principali cause dell'asfittico mercato discografico e della assoluta
mancanza di promozione dei generi musicali non di massa, tra i quali il nostro
amato Blues.
Solo una questione di pelle ? (Introduzione
e traduzione a cura di Max Pieri)
Sulle pagine di Spaghetti & Blues si è parlato spesso
con grande trasporto di blues e musica nera. Uno degli aspetti che più colpisce
degli articoli, delle interviste e dei forum è il ragionevole controllo sulle
tentazioni di auto celebrazione che viene rappresentato. Non è comune percepire
altrettanta tensione in altri siti e nelle diverse pagine web dei musicisti. E’
come se, specchiandosi in Spaghetti & Blues, ci trovassimo di fronte ad un
imbuto attraverso cui passare per acquisire maggiore consapevolezza di ciò che
andiamo facendo, come musicisti e interpreti di blues. L’analisi di questa
cultura nuda e primitiva e del nostro tentativo di trasfigurarci in essa – pur
appartenendoci fino ad un certo punto – è indubbiamente un esercizio
“metafisico”. Per coloro i quali hanno già stabilito punti fermi nella propria
esperienza di “attraversamento del Mississippi” potrebbe apparire addirittura
autolesionistico, come camminare su vetri rotti in una dimensione lontana da
noi, nel tempo e nello spazio.
In coerenza con una linea editoriale nata così spontaneamente, senza ricette
predefinite, e per alimentare il dubbio, il confronto e la discussione fra tutti
gli “spaghettari blues” è stato tradotto un articolo di Paul Garon, giornalista
e scrittore americano, esperto di musica blues. Garon ha lasciato più di una
traccia incendiaria sull’argomento. L’articolo in questione - pubblicato sulla
rivista Race Traitor (n° 4, 1995) - come in altre occasioni, va giù duro
sull’opportunità di estendere il diritto a scrivere nuove pagine di blues “oltre
certi confini”. Speriamo solo di contribuire a sollecitare la sensibilità su una
questione con cui resta imprescindibile il confronto diretto. Un semplice
articolo non può certo chiudere l’argomento ma ci aiuta a proseguire la nostra
esperienza lungo le strade del blues, limitando i danni e chiarendo gli equivoci
in cui frequentemente si cade.
Buona lettura!
WHITE BLUES (di Paul Garon)
L’articolo di Phil Rubio intitolato “Crossover Dreams…” (Race Traitor n° 2,
1993) suggerisce un interessante piano di confronto fra artisti bianchi e forme
d’arte Afro-Americana. In molti casi - egli scrive - i musicisti bianchi sono
influenzati dall’ammirazione e invidia per quelli di colore che essi tendono ad
emulare. E continua, assistiamo all’uso “della cultura Afro-Americana da parte
dei bianchi per trovare lo spirito, e quindi l’umanità, ch’essi sentono d’aver
perduto”. Io vorrei porre l’accento su una prospettiva totalmente diversa
dell’argomento. Mostrerò che, ai sostenitori e studiosi della cultura
Afro-Americana, il blues proposto dai bianchi appare vacuo e profondamente
impoverito. Inoltre, troppo spesso rappresenta un’appropriazione culturale
indebita e tristemente familiare, per questo gli artisti neri finiscono per
essere danneggiati anche economicamente attraverso la perdita d’opportunità
lavorative e d’attenzione da parte della critica musicale.
I bianchi hanno suonato la musica nera per decenni ed il proposito di una
costante opportunità di confronto e interscambio potrebbe non essere più quello
degli inizi. Tuttavia il fenomeno della proliferazione dei bluesman bianchi è
una manifestazione abbastanza recente che, certamente, trova il suo fondamento
fra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60. Non facciamo alcuno sforzo per
individuare i primi imitatori e interpreti di blues bianco e una delle prime
obiezioni a questo fenomeno fu sollevata già nel 1965 da Charles Radcliffe sulla
rivista inglese Anarchy (“The Blues in Archway Road”, Anarchy n° 5, 1965. pp.
129-133).
Molte pubblicazioni di blues si trovarono presto coinvolte nel commentare la
crescente questione. Io stesso fui spinto nella mischia all’inizio degli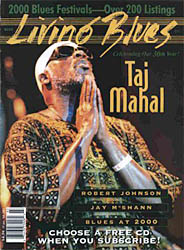 anni ’70, quando Living Blues (una rivista che aiutai a fondare insieme a Jim O’Neal,
Amy Van Singel, Bruce Inglauer, Diane Allmen, André Souffront e Tim Zorn) fu
accusata di politiche razziste per il fatto di ignorare i musicisti bianchi. La
cronista jazz Harriet Choice contestò le nostre posizioni sul Chicago Tribune ed
io fui quello che articolò la replica. La nostra posizione fu chiarita tanto in
due editoriali di Living Blues, quanto nell’introduzione alla sezione speciale
“Surrealism & Blues” (Living Blues n° 25, 1976).
anni ’70, quando Living Blues (una rivista che aiutai a fondare insieme a Jim O’Neal,
Amy Van Singel, Bruce Inglauer, Diane Allmen, André Souffront e Tim Zorn) fu
accusata di politiche razziste per il fatto di ignorare i musicisti bianchi. La
cronista jazz Harriet Choice contestò le nostre posizioni sul Chicago Tribune ed
io fui quello che articolò la replica. La nostra posizione fu chiarita tanto in
due editoriali di Living Blues, quanto nell’introduzione alla sezione speciale
“Surrealism & Blues” (Living Blues n° 25, 1976).
Quando il mio libro “Blues and the Poetic Spirit” fu pubblicato nel 1975,
dedicai una lunga sezione di esso “alla relazione psicologica fra neri e bianchi
ed a quale effetto ciò ha comportato sull’evoluzione del blues” (p. 53). Ho
anche analizzato le influenze dei partners bianchi sugli artisti di colore e
suggerito che ciò determinava, usualmente, forme di diluizione del blues. Nei
successivi quindici anni ho scritto poco sull’argomento. La controversia stava,
tuttavia, continuando a crescere (sollecitando appena la mia attenzione) e
presto esplose sulle pagine della rivista Guitar Player (agosto 1990) in un
editoriale di Lawrence Hoffman, insegnante, compositore e critico blues bianco.
Questi ha rilevato com’è “assurdo pensare che il… lifeblood of blues… potesse
estendersi a coloro che, in sostanza, niente di più avrebbero potuto essere se
non convincenti, espressivi imitatori” (p. 18). La sua posizione – per cui i
musicisti bianchi sarebbero scarsamente autentici nelle performance blues pur
occupando spazi destinati ai neri – scatenò una valanga di vigorose proteste da
parte dei lettori di Guitar Player, molti dei quali presero una delle seguenti
quattro posizioni.
1) Un’opinione come quella di Hoffman è razzista.
2) La sofferenza è universale ed anche i bianchi soffrono. Dan Forte, fondatore
e editore della rivista, scrisse: potrebbe il bianco Eric Clapton aver sofferto
di più del nero Robert Cray? Altri rappresentarono l’esperienza dei progenitori,
morti nei campi di concentramento o Nativi Americani, che ebbero ugualmente
ricevuto la loro razione di sofferenza.
3) Il virtuosismo va oltre le barriere razziali. Molti artisti bianchi, come
Stevie Ray Vaughan, sono grandi musicisti.
4) La storia culturale parla secondo moduli definiti dagli artisti bianchi. Il
blues era un’espressione della vita culturale nera, ora è l’espressione del
feeling tanto dei bianchi quanto dei neri. Questo concetto è stato espresso in
maniera forte da un difensore della causa bianca, evidentemente specialista nel
ridimensionare il diritto dei neri sulle loro tradizioni culturali, non appena i
bianchi “decidano di esserne partecipi”. Senza dubbio egli è rimasto entusiasta
quando la giuria - pressoché integralmente bianca - dei Grammy Awards ha
designato artisti bianchi quali vincitori in entrambe le categorie del blues
tradizionale e moderno.
Inutile dire che Hoffman ebbe i suoi sostenitori (Paul Oliver, Jim O’Neal ed io
stesso fra gli altri), ed alcuni, come Karima Wicks and Michael Hill,
pubblicarono repliche a Guitar Player, puntualizzando, fra le altre opinioni, la
terribile lacuna nel background culturale di molti corrispondenti che indusse a
valutare il ruolo dei bianchi pressoché identico a quello dei neri
nell’evoluzione del blues. Com’è poi accaduto, alcuni dei più giovani fan del
blues non avevano alcuna idea del fatto che i neri avessero “creato” il blues.
Molto indicativa è, in ogni caso, la considerazione che le opinioni erano per
circa il 95% contro Hoffman e per il 5% a suo favore.
 Poiché
non si poteva ulteriormente reggere la controversia senza repliche, nel 1993
Living Blues mi chiese di riarticolare la posizione della rivista in uno
speciale editoriale inaugurato nel numero di Maggio/Giugno. In quell’articolo
resi evidente che la politica della rivista era semplicemente la manifestazione
dei suoi propositi: analizzare, registrare, recensire e celebrare la cultura
musicale Afro-Amercana negli Stati Uniti. Da questa prospettiva, rilevai che la
copertura operata dalla rivista a favore d’artisti R&B come Ruth Brown o LaVern
Baker era molto più naturale che non quella verso artisti “blues” come Stevie
Ray Vaughan. Mentre ritenevo ciò sommamente chiaro e naturale, una gran parte
dei lettori non la pensava così. Ancora una volta seguirono valanghe di lettere,
molte delle quali contro la politica editoriale ed il mio articolo. Numerosi
abbonamenti furono cancellati. “E’ la musica, stupido” scrisse un lettore di
vecchia data. Torneremo su questa frase più avanti, fatemi provare, ancora una
volta, ad analizzare la questione che ha innescato la controversia. Poiché
non si poteva ulteriormente reggere la controversia senza repliche, nel 1993
Living Blues mi chiese di riarticolare la posizione della rivista in uno
speciale editoriale inaugurato nel numero di Maggio/Giugno. In quell’articolo
resi evidente che la politica della rivista era semplicemente la manifestazione
dei suoi propositi: analizzare, registrare, recensire e celebrare la cultura
musicale Afro-Amercana negli Stati Uniti. Da questa prospettiva, rilevai che la
copertura operata dalla rivista a favore d’artisti R&B come Ruth Brown o LaVern
Baker era molto più naturale che non quella verso artisti “blues” come Stevie
Ray Vaughan. Mentre ritenevo ciò sommamente chiaro e naturale, una gran parte
dei lettori non la pensava così. Ancora una volta seguirono valanghe di lettere,
molte delle quali contro la politica editoriale ed il mio articolo. Numerosi
abbonamenti furono cancellati. “E’ la musica, stupido” scrisse un lettore di
vecchia data. Torneremo su questa frase più avanti, fatemi provare, ancora una
volta, ad analizzare la questione che ha innescato la controversia.
Forse siamo arrivati troppo lontani per non sollevare i due falsi argomenti
della sofferenza e della perizia tecnica. Il dolore e la sofferenza non sono
francamente rappresentati in maniera diretta nel blues e non sono essenziali per
la competenza tecnica. In verità, anche gli aspetti non tecnici (metafisici?)
della performance trovano difficoltà ad essere inseriti in qualsiasi equazione
che coinvolge la sofferenza, sebbene per alcuni è sempre stata una regola
soffrire per poter suonare o cantare il blues. La nostra conoscenza ed
esperienza di tecnica, tuttavia, suggerisce altro. Alcuni bianchi evidentemente
abbastanza privilegiati hanno dimostrato di suonare la chitarra così come altri
meno privilegiati. Dal punto di vista degli anni '90, ciò sembra difficilmente
degno di essere contestato. In sostanza – a parte la sofferenza - sembra
evidente che, a qualsiasi razza o ceto si appartenga, è possibile suonare il
blues da un punto di vista strettamente tecnico. Né il patrimonio genetico né le differenti
esperienze di razza sembrano incidere sulla capacità di formare certi accordi,
suonare certe melodie o progressioni (tenete conto che ammettere per i bianchi
la possibilità di suonare, fisicamente, il blues significa anche inserire la
"sofferenza" come sua parte integrante o lasciarla in una dimensione
metafisica).
punto di vista strettamente tecnico. Né il patrimonio genetico né le differenti
esperienze di razza sembrano incidere sulla capacità di formare certi accordi,
suonare certe melodie o progressioni (tenete conto che ammettere per i bianchi
la possibilità di suonare, fisicamente, il blues significa anche inserire la
"sofferenza" come sua parte integrante o lasciarla in una dimensione
metafisica).
Se uno debba aver sofferto o meno per cantare il blues resta argomento
metafisico - sebbene abbastanza interessante - e intercetta sostenitori da
entrambi i lati della controversia. Molti artisti blues di colore pensano che la
sofferenza sia una parte essenziale per cantare il blues. I sostenitori del
blues bianco ritengono che molti suoi interpreti abbiano sofferto abbastanza da
qualificarsi “bluesman”. D'altra parte, Muddy Waters - spesso citato come gran
sostenitore del blues bianco - ha osservato che i bianchi possono suonare ma non
cantare il blues. Tali opinioni sono così soggettive che sfuggono a qualsiasi
analisi. Per citare l’opinione di discografici come Dixon e Godrich, se cantare
in uno "stile vocale nero" o essere capaci di prestazioni "negroidi" rappresenta
un requisito, si può dire che solo i neri possono cantare il blues. Se uno
considera il canto in stile vocale nero come parte integrante della performance
blues, raramente si sente tale canto espresso dai bianchi, eccetto qualche
imbarazzante imitazione.
 L’intera
questione è spostata sul feeling con cui si canta o s’interpreta la musica.
Prendiamo in considerazione l’opinione di J. B. Lenoir secondo cui non si
potrebbe cantare il blues a meno che uno non sia “blued”. Mentre l’idea in sè
sembra condivisa dalla maggior parte dei commentatori, resta un fatto complesso
accordarsi su come quantificare o misurare il livello in cui un musicista sia “blued”.
L’assioma secondo il quale "se dovete domandare, non saprete mai", non consente
scappatoie, poiché ognuno è disposto a concedere le qualità “soulful” e
“feeling” solo a quegli interpreti L’intera
questione è spostata sul feeling con cui si canta o s’interpreta la musica.
Prendiamo in considerazione l’opinione di J. B. Lenoir secondo cui non si
potrebbe cantare il blues a meno che uno non sia “blued”. Mentre l’idea in sè
sembra condivisa dalla maggior parte dei commentatori, resta un fatto complesso
accordarsi su come quantificare o misurare il livello in cui un musicista sia “blued”.
L’assioma secondo il quale "se dovete domandare, non saprete mai", non consente
scappatoie, poiché ognuno è disposto a concedere le qualità “soulful” e
“feeling” solo a quegli interpreti che più apprezza, indipendentemente dalla razza, dall’esperienza e – pur
acquisita la verità - indipendentemente dal feeling (qualunque cosa si comunichi
all'ascoltatore).
che più apprezza, indipendentemente dalla razza, dall’esperienza e – pur
acquisita la verità - indipendentemente dal feeling (qualunque cosa si comunichi
all'ascoltatore).
Sono rimasto sbalordito nel sentire un accanito fan giudicare un brano di
piano-cocktail particolarmente virtuoso ma assolutamente superficiale, suonato
"con tale notevole feeling". Un commento del genere rivela nient’altro che
frustrazione nell’invocare un criterio di valutazione vago come il "feeling".
Naturalmente, molte persone non pensano che il canto in stile vocale nero
costituisca parte integrante della performance blues. Tra questi, molti
ritengono che i bianchi che hanno sofferto - come Hank Williams - cantano nel
loro modo sofferente e soffuso, in uno stile caratteristicamente non-nero.
Pensare che i musicisti country and western abbiano il loro modo di cantare il
blues, mi sembra assolutamente legittimo. Si tratta d’artisti sempre esistiti,
sin da quando si è cominciato a registrare la musica. Questa è, tuttavia,
un’altro questione.
Mentre tali posizioni sembrano chiare, i detrattori dei musicisti bianchi sono
accusati spesso di mantenere la posizione per cui i bianchi "non hanno diritto"
a suonare il blues. Il diritto di suonare e cantare il blues non è in
discussione! E’ invece importante il fatto che gli esecutori bianchi abbiano
maggiore visibilità presso la stampa, facendo registrare più elevati livelli di
vendite rispetto ai neri, tanto che la loro convinzione d’essere vittime di
discriminazione per la mancata copertura da parte della rivista Living Blues è
alquanto risibile. Come se Bonnie Raitt o Stevie Ray Vaughan fossero stati
tenuti nell'oscurità a causa della politica “razzista” di Living Blues! La
realtà è che per gli esecutori bianchi, l'opinione di Living Blues è una goccia
nel secchio, paragonata all'establishment critico-musicale che si occupa di
loro, li promuove, li premia
 con
i Grammy Awards e decide dei loro destini (per quanto sia possibile fare ciò).
In definitiva questo è un problema dell'establishment critico-musicale ed il
fatto che esso sia costituito da bianchi è molto importante. I critici musicali
di colore hanno altra carne da cuocere, preferendo concentrarsi sul rap e su
artisti maggiormente popolari. Tuttavia varrebbe la pena sapere le loro
posizioni su questi argomenti, non possiamo dare per scontato il fatto che
critici e musicisti blues neri abbiano le stesse opinioni. Infatti, i motivi per
cui gli artisti blues di colore non obiettano agli esecutori bianchi è questione
lontana dalla tolleranza. Per gli artisti blues neri, l'esistenza d’esecutori
bianchi li conduce spesso a più cospicui successi di vendite. Come Phil Rubio
stesso ha notato, Aretha Franklin deve alla partecipazione al film “The Blues
Brothers” la rivitalizzazione della sua carriera. Con effetti anche da un punto
di vista commerciale. Contestiamo le condizioni razziste che hanno reso
possibile ciò, ma non il suo verificarsi. Altrettanto sintomatico è il caso di
Bonnie Raitt, che ha reso John Lee Hooker un fantastico fenomeno da hit parade,
e non vice versa (sebbene al tempo della loro joint venture, Hooker fosse già
incredibilmente popolare per un artista blues). con
i Grammy Awards e decide dei loro destini (per quanto sia possibile fare ciò).
In definitiva questo è un problema dell'establishment critico-musicale ed il
fatto che esso sia costituito da bianchi è molto importante. I critici musicali
di colore hanno altra carne da cuocere, preferendo concentrarsi sul rap e su
artisti maggiormente popolari. Tuttavia varrebbe la pena sapere le loro
posizioni su questi argomenti, non possiamo dare per scontato il fatto che
critici e musicisti blues neri abbiano le stesse opinioni. Infatti, i motivi per
cui gli artisti blues di colore non obiettano agli esecutori bianchi è questione
lontana dalla tolleranza. Per gli artisti blues neri, l'esistenza d’esecutori
bianchi li conduce spesso a più cospicui successi di vendite. Come Phil Rubio
stesso ha notato, Aretha Franklin deve alla partecipazione al film “The Blues
Brothers” la rivitalizzazione della sua carriera. Con effetti anche da un punto
di vista commerciale. Contestiamo le condizioni razziste che hanno reso
possibile ciò, ma non il suo verificarsi. Altrettanto sintomatico è il caso di
Bonnie Raitt, che ha reso John Lee Hooker un fantastico fenomeno da hit parade,
e non vice versa (sebbene al tempo della loro joint venture, Hooker fosse già
incredibilmente popolare per un artista blues).
Ma l'argomento che riguarda le star musicali e la "critica giornalistica" ha una
dimensione interessante. Quello che sta accadendo è che molti critici delle
riviste a larga copertura ed i loro complici vorrebbero trovare spazi su Living
Blues, principalmente perché si tratta di una rivista pioniera ed autorevole per
occuparsi d’artisti neri, vale a dire di “veri" artisti blues. Essi sanno,
tuttavia, di non poter pretendere palesemente ciò, senza rivelare un’opinione di
manifesta inferiorità del blues bianco. In verità, gli artisti bianchi ricevono
spazi considerevoli su Blues Access, Blues Revue Quarterly e altre riviste, ma
tali testate non garantiscono la “certificazione di conformità” che Living Blues
sembra rilasciare, per ragioni rigorosamente razziali. E’ come se gli
appassionati bianchi di blues “color-blinded" dichiarati fossero, in realtà,
l’esatto contrario. Ma prima di discutere questa color-blindness, avviciniamoci
alla questione da un'altra prospettiva.
Il Blues Revue Quarterly si è valso della già menzionata frase "E’ la musica,
stupido". L'editore della testata ha scritto di averne fatto un manifesto che ha
appeso al muro proprio per ricordargli "che cosa sia realmente il blues".
Anch’io lo tengo in mente, insieme a frasi del tipo "Hitler non invaderà mai
l'Europa" e "voi cadrete giù dal bordo della terra". "La musica" è qualcosa di
molto più scintillante di quanto è riconosciuto, qualcosa di più ampiamente complesso del mero "suono". D’altronde, se "il suono" fosse realmente
tutto, esso vivrebbe per se stesso. Nessuno andrebbe alle performance live, ai
concerti o nei club. I fan del rock non guarderebbero MTV (l’ascolterebbero
solamente). I musicisti non presterebbero attenzione ai costumi, alle luci, alla
presenza scenica, ecc. Si preferirebbe solamente pensare che "la musica sia
tutto quello che conta".
ampiamente complesso del mero "suono". D’altronde, se "il suono" fosse realmente
tutto, esso vivrebbe per se stesso. Nessuno andrebbe alle performance live, ai
concerti o nei club. I fan del rock non guarderebbero MTV (l’ascolterebbero
solamente). I musicisti non presterebbero attenzione ai costumi, alle luci, alla
presenza scenica, ecc. Si preferirebbe solamente pensare che "la musica sia
tutto quello che conta".
La maggior parte dei lettori di Race Traitor sono consapevoli della scottante
psicodinamica che coinvolge il concetto di razza, rendendo l’argomento
impossibile da ignorare, e anche noi non pretendiamo di ignorarlo. Potete
immaginare di vivere in un mondo:
1) dove una giuria quasi interamente bianca esprima un verdetto razzista contro
gli agenti che colpirono Rodney King;
2) dove il 50% di qualsiasi pubblico blues è pronto a disquisire sui meriti e
demeriti della Telecaster rispetto alla Stratocasters o della Martin D-45
rispetto alla Gibson o quant’altro, come se queste preoccupazioni fossero
fondamentali per "la musica";
3) dove lo stesso pubblico è pronto a confermare che la razza dell'esecutore non
ha alcun ruolo nell’ascolto del blues.
“È la musica, stupido”? Whoooeee. Se cominciassimo a parlare di razza e del modo
in cui sentiamo il blues, scopriremmo che i bianchi preferiscono ascoltare il
blues suonato dai bianchi piuttosto che dai neri. Molti neri preferiscono
notevolmente ascoltare il blues suonato da neri. Moltissime persone mentono
quando affermano che non è importante chi lo suona. Poche sono quelle che dicono
il vero, affermando di non aver interesse in chi suona il blues. (Ma non
preoccupatevi io e voi non facciamo parte del gruppo).
Chi sono dunque queste persone per cui la razza non è importante? Certo non i
mediocri artisti di blues bianco. Infatti, molti di questi musicisti che mettono
tutta la loro "autenticità" nella propria arte, mostrano un desiderio intenso di
approvazione da parte degli ascoltatori e degli artisti neri, (senza citare
quello delle riviste di blues black-oriented come Living Blues). Ogni volta che
s’ingaggia la battaglia (in prima persona o attraverso lettere ed articoli su
Living Blues, Guitar Player o Blues Revue Quarterly) un musicista bianco lancia
un messaggio di pseudo "fratellanza". Ciò accade solo per citare tutti gli
artisti di colore con cui egli ha suonato, con l'evidente intenzione di provare
la propria legittimità. Diversamente, tutti quegli artisti neri - ovviamente
autentici - non avrebbero gradito la sua collaborazione. In se stessa quest’attitudine
incarna l'intera contraddizione del blues bianco. Se il blues bianco fosse
autonomo ed auto certificato, perché dovrebbe aver bisogno dell'approvazione dei
neri? Se non è autonomo ed auto certificato (il desiderio intenso di
approvazione da parte dei neri suggerisce questo), perché non potrebbe avere una
fisionomia più debole ed imitativa come i suoi detrattori reclamano? Questa
domanda rimane aperta.
Una delle mie posizioni nei libri su Memphis Minnie, “Woman with Guitar”, e su
“Blues And The Poetic Spirit”, offriva nuove chiavi di lettura per ascoltare il
blues, tali da rendere le vecchie canzoni e i loro sistemi di valutazione
maggiormente indicativi per l’ascoltatore moderno. Tuttavia esiste una certa
reticenza da parte di molti appassionati e più recenti fan del blues che si
ricollega alla questione razziale. Infatti, una ragione per cui molti
ascoltatori bianchi preferiscono esecutori bianchi della propria età – con cui
si identificano facilmente - è che il loro interesse per i valori incarnati da
blues è pari a zero. Stiamo ascoltando la stessa cosa? Si ha lo stesso effetto
quando il “nero” Chuck Berry canta d’essere andato "across the
 Mississippi
clean", ed il “bianco” Elvis Presley canta le medesime liriche dello stesso
brano? Difficilmente! Analizzando la frase "across the Mississippi clean", essa
ha un’insieme di significati quando è cantata da un nero, significati che non
esistono per un esecutore bianco. Gli ascoltatori di varie razze devono
ascoltarlo e identificarlo in maniera differente, basandosi sulla loro
esperienza... e sulla loro interpretazione dell'esperienza del cantante. Il
punto focale dell’identificazione è molto importante proprio per questa ragione.
Una ragione di cui ”Blues and the Poetic Spirit” ha dimostrato i palesi aspetti
psicologici nel fenomeno dei numerosi bianchi che ripetono a pappagallo
l’atteggiamento dei performer neri. Il risultato di ciò è l’illusoria percezione
di guadagno in termini di machismo e maturità. Troppo spesso questo ha portato
sulla bocca d’adolescenti (bianchi) improbabili parole d’uomini (neri), parole
che appaiono frivole ed occasionalmente offensive senza il loro originale
fondamento. Secondo Rubio, questa tendenza è stata derisa anche da Frank Zappa
in un titolo del 1981, "You Are What You Is”. Mississippi
clean", ed il “bianco” Elvis Presley canta le medesime liriche dello stesso
brano? Difficilmente! Analizzando la frase "across the Mississippi clean", essa
ha un’insieme di significati quando è cantata da un nero, significati che non
esistono per un esecutore bianco. Gli ascoltatori di varie razze devono
ascoltarlo e identificarlo in maniera differente, basandosi sulla loro
esperienza... e sulla loro interpretazione dell'esperienza del cantante. Il
punto focale dell’identificazione è molto importante proprio per questa ragione.
Una ragione di cui ”Blues and the Poetic Spirit” ha dimostrato i palesi aspetti
psicologici nel fenomeno dei numerosi bianchi che ripetono a pappagallo
l’atteggiamento dei performer neri. Il risultato di ciò è l’illusoria percezione
di guadagno in termini di machismo e maturità. Troppo spesso questo ha portato
sulla bocca d’adolescenti (bianchi) improbabili parole d’uomini (neri), parole
che appaiono frivole ed occasionalmente offensive senza il loro originale
fondamento. Secondo Rubio, questa tendenza è stata derisa anche da Frank Zappa
in un titolo del 1981, "You Are What You Is”.
Spesso è dimenticato che una gran parte degli attuali esecutori (bianchi) di
blues (e dei loro sostenitori) è stata ispirata dai popolari comici bianchi Dan
Ackroyd e John Belushi, nella loro interpretazione di Jake ed Elwood Blues, The
Blues Brothers. Il disco ed il film hanno innescato una tendenza – badate,
basata sullo scherzo - che è andata oltre ogni previsione dei protagonisti. Per
molti nuovi esecutori bianchi il concetto di "eredità nera del blues" è,
infatti, un mistero. L'unica "eredità" che essi riconoscono sono gli occhiali da
sole, gli abiti e i cappelli neri, che sono diventati un classico fra le
uniformi dei nuovi bluesman bianchi. Messi assieme, questi elementi formano il
logo di più di un nuovo blues club. La proliferazione d’esecutori bianchi che
suonano in questi club può sembrare ad alcuni un'aberrazione innocua, mentre è
il sintomo di una malattia che può essere abbastanza insidiosa e andare ben
oltre il mero sfruttamento economico.
Mi sono ricordato di una foto apparsa su una rivista di blues. Ritraeva un
esecutore maschio bianco che suonava il blues per un gruppo di scolari, la
maggior parte dei quali sembravano maschi neri molto giovani. Probabilmente
molti hanno pensato che questo fosse uno straordinario momento di comprensione
interrazziale. Io sono stato invece, molto, più colpito dalla tristezza di
un'occasione perduta. Quello era un gruppo di ragazzi per i quali la presenza di
un modello artistico di colore avrebbe avuto un maggiore impulso nello sviluppo
della propria autocoscienza. Invece stavano ricevendo una lezione di falso multi
culturalismo blues attraverso un musicista bianco. "Eredità", nessuna? I
difensori di questi eventi sono spesso i propiziatori della "color-blindness"
come ultima arma dell’antirazzismo, ma molti di questi bianchi color-blinded
ignorano realmente l’importanza della consapevolezza di razza e delle questioni
razziali, con tutte le conseguenti sollecitazioni che il razzismo ancora
contiene. Essi credono di rappresentare gli ultimi antirazzisti che, rifiutando
di impiegare la razza come criterio discriminante per qualsiasi cosa, in realtà
stanno accecando se stessi alla vista della complessità degli argomenti
razziali. Torniamo ai vincitori dei Grammy. E’ o non è chiaro che quello che
potrebbe sembrare color-blindness è semplicemente un evento che permette al
razzismo di tornare in auge? I bianchi non hanno vinto nella categoria blues
perché era aperta a tutti e - di conseguenza – i migliori hanno vinto. Essi
hanno vinto perché sono l’ampia maggioranza di un paese dove il razzismo
distorce quasi ogni cosa. I Grammy Awards rappresentano semplicemente maggiore
razzismo, non l'esercizio di color-blindness che molti pretendono. La
color-blindness, in troppi casi, rappresenta semplicemente il trasferimento del
controllo ai bianchi.
E’ paradossale il fatto che gli esecutori bianchi di blues, così presumibilmente
rispettosi dei loro mentori neri, siano solo un altro strumento di sviluppo e
incoraggiamento del dominio della razza bianca.
Dadà
(di Martino Palmisano)
 Questo è un
articolo triste, ma la partenza di quello che può essere considerato uno
dei maggiori armonicisti blues italiani, non può e non deve passare inosservata.
Personalmente non ho mai conosciuto Dadà, ma molte cose mi univano
spiritualmente a lui. Amava il blues come me, suonava l’armonica molto meglio di
me, era autodidatta come me, vestiva solitamente di nero come me quando si
esibiva in pubblico, aveva i capelli corti e brizzolati come i miei, una
corporatura abbastanza somigliante alla mia (nelle foto che ho potuto vedere), e
viveva a Ferrara, una città che porto nel cuore perché ci ho vissuto la mia
infanzia e parte della mia adolescenza. Il destino ha voluto che Dadà non
leggerà mai questo articolo. E probabilmente neanche le persone a lui più
vicine. Mai lo sentirò, neanche al telefono. Ma ci ritroveremo un giorno, con le
nostre armoniche, da qualche parte, forse all’inferno, e mi farò dare qualche
dritta sullo strumento. Magari gratis. Questo è un
articolo triste, ma la partenza di quello che può essere considerato uno
dei maggiori armonicisti blues italiani, non può e non deve passare inosservata.
Personalmente non ho mai conosciuto Dadà, ma molte cose mi univano
spiritualmente a lui. Amava il blues come me, suonava l’armonica molto meglio di
me, era autodidatta come me, vestiva solitamente di nero come me quando si
esibiva in pubblico, aveva i capelli corti e brizzolati come i miei, una
corporatura abbastanza somigliante alla mia (nelle foto che ho potuto vedere), e
viveva a Ferrara, una città che porto nel cuore perché ci ho vissuto la mia
infanzia e parte della mia adolescenza. Il destino ha voluto che Dadà non
leggerà mai questo articolo. E probabilmente neanche le persone a lui più
vicine. Mai lo sentirò, neanche al telefono. Ma ci ritroveremo un giorno, con le
nostre armoniche, da qualche parte, forse all’inferno, e mi farò dare qualche
dritta sullo strumento. Magari gratis.
Nei primi anni ottanta, insieme all’inseparabile compagno di vita artistica
Roberto Formignani (eccellente chitarrista), fonda la Mannish Blues
Band, e già il titolo scelto la dice lunga sui loro gusti musicali. Si
esibiscono in importanti festival, tra cui il Pistoia blues, e partecipano al
programma culto degli anni ottanta, condotto da Renzo Arbore, “Quelli
della notte”. Niente male in quegli anni. Nel 1993, invece, nasce il progetto
The Bluesmen con cui rivisitano in modo personale i classici del blues in
veste acustica. Nel 1996 producono per l’etichetta Musicando il loro primo CD
“Intrepido Blues”: un disco davvero molto bello.
Nel ’97 o ’98, non ricordo bene l’anno, ero a Ferrara in veste di turista.
Quando in una città ci passi buona parte della tua vita hai bisogno, a volte, di
ritornare in alcuni posti dove riemergono a galla sensazioni difficili da
spiegare. Tramite alcuni amici e appassionati di blues riuscii ad avere il loro
disco d’esordio. Un CD di blues-swing acustico in cui fui conquistato dal suono
dell’armonica di Dadà che ha lasciato il segno su gran parte dell’album. La
versione di “Summertime” è marchiata a fuoco dalla sua “harp”: ritengo questa
versione una delle più belle che mi sia capitato di ascoltare, così come la
ritmica battente dell’armonica in classici senza tempo come “Got My Mojo
Working” o “Mistery Train”. Contattai il loro bassista Bruno Corticelli, perché
li volevo in Puglia per una serata di grande blues, ma la cosa non andò in porto
per i soliti motivi che spesso attanagliano le blues band nostrane. Lontananza e
distanza chilometrica “in primis”. Sfumò così l’occasione di conoscere Dadà e
magari di jammare insieme a lui.
Nel 2002 The Bluesmen incidono il loro secondo cd e partecipano a festival
importanti come il Delta blues di Rovigo nel 2001, Liri Blues Winter e Ravenna
Blues nel 2004, condividendo il palco con i Nine Below Zero, Jorma Kaukonen,
Robben Ford, e via dicendo. Qualche mese fa si è tenuta in Emilia la seconda
convention di armonicisti e tra i tanti c’era ovviamente Dadà. Col Nicchio
avevamo deciso di partecipare alla manifestazione dando il nostro modesto
contributo, ma le pessime condizioni atmosferiche ci hanno impedito di partire
in auto. Ho perso l’ultima occasione di conoscere Antonio D’Adamo,
musicista sensibile e creativo che ci ha lasciato domenica 30 gennaio, dopo aver
lottato contro un tumore che non lasciava speranza. Aveva 45 anni. Tutti in
piedi.
Armoniche a
noleggio (di Martino Palmisano)
 Per
circa tre mesi ho provato a completare questo articolo. A forza di rimandarlo
avevo quasi deciso di lasciar perdere. Troppo impegnativo. Pensate, mi ero messo
in testa di documentarvi come uno strumento piccolo di dimensioni non
appartenesse solo al blues e dintorni ma che molteplici sono stati i musicisti
di musica pop e altro a noleggiare "soffiatori" di armonica come ospiti nei loro
dischi. Contro ogni previsione, mi sono addentrato nell’argomento, e… mi sono
perso. Mi ritroverò? Bo’!!! Ho effettuato una ricerca su quali siano stati i
soffiatori pallidi a prestare l’armonica diatonica o cromatica dal 1970 al 2004
o, comunque, chi abbia dato spazio a questo strumento nelle proprie incisioni:
le sorprese non mancano! Per
circa tre mesi ho provato a completare questo articolo. A forza di rimandarlo
avevo quasi deciso di lasciar perdere. Troppo impegnativo. Pensate, mi ero messo
in testa di documentarvi come uno strumento piccolo di dimensioni non
appartenesse solo al blues e dintorni ma che molteplici sono stati i musicisti
di musica pop e altro a noleggiare "soffiatori" di armonica come ospiti nei loro
dischi. Contro ogni previsione, mi sono addentrato nell’argomento, e… mi sono
perso. Mi ritroverò? Bo’!!! Ho effettuato una ricerca su quali siano stati i
soffiatori pallidi a prestare l’armonica diatonica o cromatica dal 1970 al 2004
o, comunque, chi abbia dato spazio a questo strumento nelle proprie incisioni:
le sorprese non mancano!
Doverosa premessa: questo articolo non ha alcuna presunzione di esaustività ma
vuole solo dare un piccolo spaccato del variegato mondo in cui spazia l’armonica
a bocca. Due sono gli armonicisti in Italia che (a giusta ragione) vantano
collaborazioni a destra ed a sinistra. Partiamo da Fabio Treves che presta a
noleggio la sua armonica diatonica a Mina nel 1974 nel brano “E poi”; Drupi nel
Lp “Provincia” ('78); Ivan Graziani nel disco “Veleno all’autogrill” ('77);
Riccardo Cocciante, “Cervo a Primavera” (1980); Pierangelo Bertoli sempre nel
1980 per il disco “Certi Momenti”; i Pooh nel LP “Fotografie” (1981); Adriano
Celentano, nel disco “I miei americani” (1986); ancora Bertoli, nei dischi “Tra
me e me” (1988) e “Oracoli” (1980); Eugenio Finardi, in “Millennio” (1991);
Angeli Branduardi, “Si puo’ fare” (1992); Pino Scotto, “Il grido disperato di
mille band” (1992); Marco Ferradini, “ Dolce piccolo mio fiore” (1995);
Francesco Baccini, “Baccini a colori” (1996); Gatto Panceri, “Stellina” (1997);
Angelo Branduardi, “Il dito e la luna” (1988); Giorgio Conte, “Eccomi qua”
(1999); Gianluca Grignani, “Uguali e diversi” (2002); Articolo 31, “Italiano
medio” (2003). Ho tralasciato volutamente le collaborazioni in ambito blues e
con altri artisti meno conosciuti perché, altrimenti, Treves mi avrebbe occupato
tutto l’articolo... Beh, forse ora avete capito perché il Puma di Lambrate è
l’armonicista più conosciuto nella nostra penisola.
Per quanto riguarda l’armonica cromatica (anche chitarra) segue il maestro Bruno
De Filippi con un palmares di tutto rispetto per le sue collaborazioni come
soffiatore a noleggio. Ricordo un suo concerto jazz in quartetto nella piazza di
Castellana Grotte diversi anni addietro. Semplicemente straordinario. Nel 1974
lo chiama Ornella Vanoni per il disco “A un certo punto” e nel 1981 per
“Duemilatrecentouno”; Franco Simone, nel disco omonimo del 1978; il Pino
Daniele degli anni migliori di “Nero a metà” con "I say i’ sto cca’ " (1980),
”je so pazz“, e ancora nel 1993, “Che Dio ti benedica”; Giorgio Gaber lo chiama
per il disco “Pressione bassa” del 1980 (un blues da paura cantato in italiano);
Toto Cotugno “Innamorata-Innamorato-Innamorati” sempre nel 1980 (sic!!!); Teresa
De Sio, nel disco omonimo del 1982; Pino D’Angiò, “Ti regalo della musica”
(1982); Adriano Celentano “Rock’n’Roll” (1982); Rossana Casale, “Peace” (1989);
Gino Paoli “Matto come un gatto” (1991). Da ricordare ancora le lunghe
collaborazioni dal 1964 con Enzo Jannacci e dal 1974 quelle con il menestrello
Branduardi. Compare anche nel video-live degli Articolo 31 “Italiano medio”
(mentre nel cd suona Treves). Grandioso nei suoni ed inimitabile nel suo
classico vestito ”tutto preciso” in compagnia degli sballati Articolo
 31.
Queste accoppiate fanno bene alle coronarie. E non finisce qui. In ordine
sparso, vi ricordo che Fabrizio De Andrè chiamò Andy Forest per inserire
l’armonica nel brano “Quello che non ho” (un pezzo colorato di rock/blues)
contenuto nel disco “Fabrizio De Andre” del 1981. L’armonicista siciliano
Giuseppe Milici che suona la cromatica nella sigla TV “Avvocato Porta” oltre ad
aver reinciso “Il cielo in una stanza” sul cd di Gino Paoli e registrato il
brano “Dormi” nel cd dei Dirotta su Cuba. A proposito, vi ricordate a Sanremo
quando sul brano "E andata cosi’ " comparve il Divino Toots Thielemans? Altro
armonicista cromatico/diatonico di grande spessore è Angelo Adamo. Ha spesso
collaborato ed inciso con Gianni Morandi e diverse volte lo si è visto in
televisione proprio con l’autore di “Fatti mandare dalla mamma a prendere la
gazzosa” (...ho sbagliato bevanda?). 31.
Queste accoppiate fanno bene alle coronarie. E non finisce qui. In ordine
sparso, vi ricordo che Fabrizio De Andrè chiamò Andy Forest per inserire
l’armonica nel brano “Quello che non ho” (un pezzo colorato di rock/blues)
contenuto nel disco “Fabrizio De Andre” del 1981. L’armonicista siciliano
Giuseppe Milici che suona la cromatica nella sigla TV “Avvocato Porta” oltre ad
aver reinciso “Il cielo in una stanza” sul cd di Gino Paoli e registrato il
brano “Dormi” nel cd dei Dirotta su Cuba. A proposito, vi ricordate a Sanremo
quando sul brano "E andata cosi’ " comparve il Divino Toots Thielemans? Altro
armonicista cromatico/diatonico di grande spessore è Angelo Adamo. Ha spesso
collaborato ed inciso con Gianni Morandi e diverse volte lo si è visto in
televisione proprio con l’autore di “Fatti mandare dalla mamma a prendere la
gazzosa” (...ho sbagliato bevanda?).
Francesco Guccini, nei tardi ’50, è stato tra i primi a subire il fascino del
rock’n’Roll che suonava con un gruppo, fra cover di Elvis e Gene Vincent. Forse
non si direbbe ma Guccini ha spesso "tirato di blues" in alcuni dischi, come in
“Via Paolo Fabbri”, ed utilizzato l’armonica a bocca. Quando incise nel 1967 il
disco “Folk Beat n° 1”, cantava "Talkin’ Milano" (improvvisata in studio con
Alan Cooper) parodia dei talkin’ blues alla Woody Guthrie. E che dire del brano
“Statale 17”, un bluesaccio autentico che si collega alla "Route 66" di Kerouac
e alla "Highway 61" di Dylan. Guccini suona l’armonica partendo dai cantori del
folk/ blues e dal vivo il compito di soffiare nelle ance spetta a Roberto
Manuzzi che si cimenta anche al sax ed alla fisarmonica, come nel disco “Guccini
Live Connection” del 1998. Anche Lucio Dalla chiama un soffiatore pallido nel cd
“Lucio” del 2003, ospitando l’armonica del polistrumentista Roberto Costa.
Zucchero Fornaciari, dal vivo e in studio, ha affidato il compito di armonicista
a James Thompson (anche valente sassofonista) da anni trapiantato in Italia e,
quando non ha voluto badare a spese, ha chiamato in sala d’incisione e in tour
addirittura Mark Feltham che vi assicuro non è uno qualsiasi, bensì leader dei
Nine Below Zero nonché collaboratore del compianto Rory Gallagher. Si scherza
poco!
Alcuni cantautori italiani invece di noleggiare armonicisti preferiscono il fai
da te. Eugenio Finardi, grande appassionato di blues, si è sempre cimentato con
l’armonica; alcuni anni fa, dal vivo, mi sorprese con la cover di “Hoochie
Coochie Man”. Anche Francesco De Gregari è stato uno dei primi nel nostro paese
a far conoscere il suono dell’armonica nei suoi dischi e nei concerti dal vivo.
Certo non sarà un virtuoso, ma nel campo folk/cantautoriale bisogna
riconoscergli ampi meriti. Edoardo Bennato ha dato molto al blues ed ha
divulgato il suono dell’armonica sui palchi di tutta Italia nell’ultimo
trentennio. Dal vivo dà ampio spazio all’armonica, spesso aiutato addirittura
dal suo batterista. "Edo - Rinnegato", inciso nel 1990, è un disco da avere
sicuramente. Così come il cd “E’ asciuto pazzo ‘o padrone”, inciso nel 1992 con
lo pseudonimo di Joe Sarnataro e i Blue Stuff. Anche Bennato però ha noleggiato
il virtuoso soffiatore pallido Andy J. Forest in un suo disco. Lo stesso Bennato
ha suonato, a sua volta, l’armonica nel cd degli Stadio “Di volpi, di vizi e di
virtu’” (1995). Tracce di "harp" anche nel brano “Bomba non bomba” di Antonello
Venditti ed in alcuni dischi di Jovanotti, di Ligabue e nell’ultimo lavoro
discografico di Ivano Fossati. Stefano D’Orazio - batterista dei Pooh - si
cimenta dal vivo al flauto traverso ed all’armonica: bontà sua! Infine, anche se
è difficile crederci, Romano Musumarra ha suonato l’armonica con il gruppo “La
Bottega Dell’Arte”.
Bluesin 2005:
interessanti e positivi cambiamenti nel regolamento.
(di Amedeo Zittano)
 Tra le tante novità relative alla “stagione dei festival” di quest’anno, quello
che più mi ha sorpreso e incuriosito è il Pistoia Blues, in particolare come si
è evoluto il progetto BluesIn. La Direzione Artistica ha dato concretezza alla
risposta di chiusura al dibattito dell’anno scorso (collegamento ad archivio)
dove, accettando il costruttivo confronto, si impegnava a tener conto dei nostri
punti di vista nelle edizioni future, e così è stato. Tra le tante novità relative alla “stagione dei festival” di quest’anno, quello
che più mi ha sorpreso e incuriosito è il Pistoia Blues, in particolare come si
è evoluto il progetto BluesIn. La Direzione Artistica ha dato concretezza alla
risposta di chiusura al dibattito dell’anno scorso (collegamento ad archivio)
dove, accettando il costruttivo confronto, si impegnava a tener conto dei nostri
punti di vista nelle edizioni future, e così è stato.
Credo che da questa esperienza tutti abbiano imparato qualcosa; io ad esempio ho
compreso ancor meglio l’incredibile forza del Blues, capace di indurre le
persone di buon senso a prendere la giusta decisione. È andata bene per tutti
anche per gli "anti PBF" che hanno anche pubblicato diffamanti insinuazioni
(rivolte anche a S&B) su Guest Book e Mailing List varie, ed ora si vantano
esprimendo l’ipocrita compiacimento per aver conquistato un ambito posto nel
Festival… Francamente, a noi di Spaghetti & Blues importa solo ed unicamente
che il più noto festival di Blues italiano abbia ufficialmente dedicato un
importante e chiaro spazio proprio al Blues nostrano: ce ne congratuliamo
sinceramente.
Molto gradito il ritorno di B.B. King.
BASSO PROFILO BLUES
di Max Pieri
Il presente articolo è il naturale
seguito di un precedente pezzo apparso, in versione definitiva, su megabass.it
nel giugno 2003 ed intitolato “Elogio delle basse frequenze”. In quella sede era
stata esplorata l’evoluzione dello spettro sonoro sotto i 400 Hertz nel mondo
musicale in senso lato. Questo è invece il tentativo di rappresentare
l’importanza di quelle frequenze nell’ambito ristretto del blues, attraverso la
breve storia di alcuni protagonisti che hanno contribuito a forgiarne il sound.
Il ”basso profilo” e lieve considerazione di cui godono le quattro corde nel
blues ha un’origine in parte naturale ed in parte determinata dai medesimi
bassisti. Per il primo aspetto, basti ricordare che il blues nasce musica
povera, suonata per strada, utilizzando prevalentemente chitarra e armonica ma
anche i più svariati arnesi della vita quotidiana come nelle popolari Jug Band
del sud. Per scelta o necessità sono quindi numerosi coloro che hanno rinunciato
al basso attraverso la storia del blues. Line-up scheletriche hanno avuto
valenti rappresentanti ancora nel blues elettrico del dopoguerra come R.L.
Burnside, T-Model Ford, Hound Dog Taylor, Sonny Boy Williamson e, più
recentemente, la Jon Spencer Blues Explosion. Per quanto concerne le
responsabilità dei bassisti, queste vanno individuate nel tentativo di
sviluppare linguaggi e tecniche “più evolute”, il cui sentiero di ricerca è
stato irrimediabilmente incrociato con quello della chitarra. Spogliando il
basso del suo ruolo tipico, si sono giocate e perse partite su campi non idonei
alle caratteristiche tipiche dello strumento. Il risultato è stata l’erosione
della centralità e determinazione che venivano conferite al basso dal ruolo di
sostegno armonico-ritmico, di propellente nel generare groove, di “gancio” nel
giocare coi riff nonché di catalizzatore dell’arrangiamento in generale. Queste
funzioni sono state ben presenti nell’approccio musicale dei personaggi appresso
rappresentati. Tanto presenti da renderli non solo valenti strumentisti, ma
anche ottimi produttori e arrangiatori e, non di rado, eccellenti autori e
cantanti.
DEWEY CORLEY
 (Halley, Arkansas, 1898 – Memphis, Tennessee, 1974) (Halley, Arkansas, 1898 – Memphis, Tennessee, 1974)
Non esiste miglior rappresentante del conviviale e dialettico filone delle Jug
Band di Dewey Corley. Egli è stato, infatti, non solo il leader della Beale
Street Jug Band dagli anni ‘30 in poi, ma anche un grande musicista su tutti gli
strumenti d’ordinanza di queste tipiche band: il jug, il washtub bass e il kazoo,
del quale era considerato uno dei massimi interpreti.
Corley si avvicina da bambino alla musica, iniziando a suonare l’armonica.
Attorno a 18 anni comincia a vagabondare, vivendo come un hobo fra l’Arkansas ed
il Tennessee, fino al suo incontro con Will Shade, carismatico fondatore della
Memphis Jug Band. Entrò ed uscì dalla band di Shade insieme a molti altri
bluesmen della città come Furry Lewis e Memphis Minnie. Corley fu anche membro
della South Memphis Jug Band di Jack Kelly, suonò con diversi altri bluesmen
memphisiani in duo ed in trio, ma la Beale Street Jug Band rimane, tuttavia, la
sua più importante iniziativa. Divenne un punto di riferimento della città per
circa trent’anni, rimanendo unico superstite di quella stagione e uno dei suoi
artisti più rappresentativi. Durante gli anni '30 e '40, attraverso le
registrazioni della Memphis Jug Band, Corley cercò di sdoganare il suono
d’insetto molesto del Kazoo, i tambureggianti groove del washtub bass ed il
soffio sordo attraverso il foro del jug. Più tardi venne l’era del rock & roll e
sembrò non esserci più storia per le jug band. Tuttavia negli anni ’60,
sull’onda del blues revival, alcuni vecchi bluesmen furono riscoperti dalle
etichette discografiche e dai giovani ascoltatori bianchi. Questo fu un nuovo
biglietto d’ingresso di Dewey Corley per gli studi di registrazione, ove
risplendettero ancora assoli di Kazoo dai toni così cangianti come solo un
Charlie Parker avrebbe potuto riprodurre.
Negli ultimi anni di vita Corley si è rivelato anche un notevole talent scout,
lavorando per compagnie discografiche come l’Adelphi alla scoperta di leggende
perdute del blues come Hacksaw Harney e i superbi chitarristi Willie Morris e
Walter Miller.
WILLIE DIXON
(Vicksburg, Mississippi, 1915 - Burbank, California 1992)
 William James Dixon è stata, senza ombra di dubbio, una delle personalità più
vive nella storia del blues e della musica popolare americana. Cantante dalla
voce grassa e baritonale, bassista eclettico, autore scintillante di songs
seminali, talent scout e produttore di grandi bluesmen dagli anni ‘40 fino a
tutti gli anni ’80. William James Dixon è stata, senza ombra di dubbio, una delle personalità più
vive nella storia del blues e della musica popolare americana. Cantante dalla
voce grassa e baritonale, bassista eclettico, autore scintillante di songs
seminali, talent scout e produttore di grandi bluesmen dagli anni ‘40 fino a
tutti gli anni ’80.
Nel ‘36 si trasferisce a Chicago e, dopo l’esperienza dilettantistica nella boxe
(vince l’Illinois Golden Glove, categoria pesi massimi), si dedica attivamente
alla musica. Suona il contrabbasso nei Five Breezes, nei Four Jumps of Jive e
quindi nel Big Three Trio. Con questa band, fra il 1946 e il ’52, raggiunge una
certa notorietà nel circuito chicagoano, lasciando diverse tracce discografiche.
A metà degli anni ’50 inizia a lavorare stabilmente per la Chess Records
etichetta fondamentale per l’affermazione del blues, del quale fu intraprendente
catalizzatore. Gli incisivi upbeat blues di Willie Dixon basati su ritmi serrati
e su riff ruvidi ma incalzanti hanno contribuito a creare l’archetipico Chicago
Sound di quegli anni e divennero degli standard per le giovani rock band
anglosassoni degli anni ‘60. Il suono del suo contrabbasso, percussivo e
ipnotico, la voce istrionica e drammatica su testi spesso ironici rappresentano
una pietra miliare per tutta la musica moderna.
Fra I suoi brani originali ricordiamo "I'm Your Hoochie Coochie Man", “I Can’t
Quit You Baby”, "Little Red Rooster", "You Shook Me", "Back Door Man", "I Ain't
Superstitious" e "I Just Want to Make Love to You". Gli artisti che hanno
registrato i suoi titoli non sono soltanto affermati bluesmen ma anche stelle
del firmamento rock come Jimi Hendrix, Doors, Allman Brothers Band, Rolling
Stones, Led Zeppelin, Everly Brothers, Eric Clapton, Yardbirds, Aerosmith e
numerosi altri.
Willie Dixon è stato uno degli ideatori dell'American Folk Blues Festival che,
negli anni ‘60 e ’70, ha portato nel Vecchio Continente i più grandi musicisti
di colore. Ha formato anche i Chicago All-Stars con i quali ha viaggiato in
lungo ed in largo attraverso Stati Uniti ed Europa. Negli anni ’80, malgrado una
salute precaria (deve subire l'amputazione di una gamba a seguito del diabete),
é sempre attivissimo. Si occupa della fondazione “Blues Heaven”, organizzazione
no-profit votata all’aiuto di vecchi bluesmen in difficoltà finanziarie ed alla
costituzione di scuole per giovani musicisti. E’ anche autore di una famosa
autobiografia intitolata “I Am the Blues”, pubblicata nel 1989.
DONALD DUNN
(Memphis, Tennessee, Novembre 1941)
 Soprannominato dal padre “Duck” a seguito della sua passione per Paperino,
Donald Dunn è membro della Rock'n'Roll Hall Of Fame con i Booker T. & The MGs.
Questa mitica band, fondata insieme all’amico d’infanzia Steve Cropper, è
titolare di numerosi hits strumentali degli anni ’60 come "Green Onions”, “Hang
'Em High” e “Time Is Tight”. Ma con Booker T. & The MGs Donald Duck ha
contribuito, soprattutto, a definere – insieme ai Memphis Horns – i contorni di
uno dei più caratteristici e duraturi sound nella musica popolare americana: lo
Stax Sound. La leggendaria Soul e Rythm'n'Blues label non sarebbe stata la
stessa senza il bassismo vibrante e carnoso di Dunn. Fra le registrazioni senza
tempo cui egli ha partecipato ricordiamo “Respect”, “Dock Of The Bay” e “I've
Been Loving You Too Long” di Otis Redding, “In The Midnight Hour” di Wilson
Pickett, “Hold On I'm Coming” di Sam and Dave. Tutti brani che hanno lasciato un
segno indelebile nella storia della cultura musicale non solo americana.
Innumerevoli sono state ancora le collaborazioni e le session che egli può
vantare, avendo lavorato per artisti come Isaac Hayes, Jerry Lee Lewis, Muddy
Waters, Albert King, Freddie King, Bill Withers, Rod Stewart, Joan Baez, Richie
Havens, Roy Buchanan, Diana Ross, Manhattan Transfer, Bob Dylan, Tom Petty & The
Heartbreakers, John Fogerty, Neil Young, Eric Clapton, ecc.. Soprannominato dal padre “Duck” a seguito della sua passione per Paperino,
Donald Dunn è membro della Rock'n'Roll Hall Of Fame con i Booker T. & The MGs.
Questa mitica band, fondata insieme all’amico d’infanzia Steve Cropper, è
titolare di numerosi hits strumentali degli anni ’60 come "Green Onions”, “Hang
'Em High” e “Time Is Tight”. Ma con Booker T. & The MGs Donald Duck ha
contribuito, soprattutto, a definere – insieme ai Memphis Horns – i contorni di
uno dei più caratteristici e duraturi sound nella musica popolare americana: lo
Stax Sound. La leggendaria Soul e Rythm'n'Blues label non sarebbe stata la
stessa senza il bassismo vibrante e carnoso di Dunn. Fra le registrazioni senza
tempo cui egli ha partecipato ricordiamo “Respect”, “Dock Of The Bay” e “I've
Been Loving You Too Long” di Otis Redding, “In The Midnight Hour” di Wilson
Pickett, “Hold On I'm Coming” di Sam and Dave. Tutti brani che hanno lasciato un
segno indelebile nella storia della cultura musicale non solo americana.
Innumerevoli sono state ancora le collaborazioni e le session che egli può
vantare, avendo lavorato per artisti come Isaac Hayes, Jerry Lee Lewis, Muddy
Waters, Albert King, Freddie King, Bill Withers, Rod Stewart, Joan Baez, Richie
Havens, Roy Buchanan, Diana Ross, Manhattan Transfer, Bob Dylan, Tom Petty & The
Heartbreakers, John Fogerty, Neil Young, Eric Clapton, ecc..
Ancora oggi Donald “Duck” Dunn rimane un musicista, un autore e un produttore
particolarmente rispettato nello star system musicale, anche al di fuori del
ristretto circuito blues. Egli ha continuato e continua a tenere vivo e
palpitante il classico Stax Sound. Suona nella Blues Brothers Band, sin dalla
sua costituzione, avvenuta all’inizio degli anni ’80 ad opera di John Belushi e
Dan Aykroid. Porta tuttora in giro il glorioso marchio Booker T. & the MGs con
il vecchio compagno d’avventure Steve Cropper (anch’egli attivo nella Blues
Brothers Band).
JAMES JAMERSON
(Charleston, South Carolina, 1936 – Los Angeles, California, 1983)
 James Jamerson ha contribuito a modificare in maniera irrimediabile il suono
della musica contemporanea. Stabilitosi a Detroit nel 1954, nonostante
un‘infanzia piuttosto travagliata, ha potuto godere della levità della musica
per la quale nutrì, da subito, una grande passione. Inizia a suonare molto
giovane il contrabbasso, esibendosi subito in ambito jazzistico. Tuttavia, alla
prima visita presso gli studi Motown, imbraccia il basso elettrico senza
lasciarlo più. Nei primi ’60, si unisce a Earl Van Dyke, Robert White, Benny
Benjamin e Joe Messina nel famigerato team dello Studio A, i Funk Brothers.
Questo quintetto leggendario ha costituito l’ossatura portante del Motown Sound.
Ascoltando successi come "Dancing in the street”, "What's Going On", “My Girl”,
“I Was Made To Love Her” o "Boogie Fever" si è involontariamente spinti al
movimento dai vibranti grooves suonati da James Jamerson. Egli è stato il primo
virtuoso del basso elettrico, dando voce allo strumento e introducendo la
sincope musicale o, in termini più laici, il funk. James Jamerson ha contribuito a modificare in maniera irrimediabile il suono
della musica contemporanea. Stabilitosi a Detroit nel 1954, nonostante
un‘infanzia piuttosto travagliata, ha potuto godere della levità della musica
per la quale nutrì, da subito, una grande passione. Inizia a suonare molto
giovane il contrabbasso, esibendosi subito in ambito jazzistico. Tuttavia, alla
prima visita presso gli studi Motown, imbraccia il basso elettrico senza
lasciarlo più. Nei primi ’60, si unisce a Earl Van Dyke, Robert White, Benny
Benjamin e Joe Messina nel famigerato team dello Studio A, i Funk Brothers.
Questo quintetto leggendario ha costituito l’ossatura portante del Motown Sound.
Ascoltando successi come "Dancing in the street”, "What's Going On", “My Girl”,
“I Was Made To Love Her” o "Boogie Fever" si è involontariamente spinti al
movimento dai vibranti grooves suonati da James Jamerson. Egli è stato il primo
virtuoso del basso elettrico, dando voce allo strumento e introducendo la
sincope musicale o, in termini più laici, il funk.
All’inizio degli anni ’70, dopo un forzoso trasferimento a Los Angeles (al
seguito della Motown), Jamerson divenne bassista free lance, ottenendo
numerosissimi ingaggi per tour e session di registrazione. A causa di una
personalità controversa e di un’attività musicale frenetica, rimase vittima di
alcool e droghe che erosero, progressivamente, salute e reputazione
professionale. Il mondo musicale lo relegò sempre più ai margini e la condizione
di tossicodipendenza peggiorò fino al tragico epilogo di una morte prematura.
Hanno potuto usufruire delle sue scintillanti linee di basso artisti come Martha
and The Vandellas, The Temptations, Marvin Gaye, Diana Ross, Lionel Richie,
Smokey Robinson, Stevie Wonder, ecc.. James Jamerson è anche il personaggio
principale di un libro (Allan Slutsky, "Standing in the Shadows of Motown" Hal
Leonard, 1989) da cui è stato tratto un’omonimo film biografico. Nel 2000, a 17
anni dalla morte, è stato inserito nella Rock'n'Roll Hall Of Fame, categoria
sidemen.
MARK SANDMAN
(Newton, Massachusetts, 1952 - Palestrina, Italia, 1999)
 L’avventura musicale di Mark Sandman si sviluppa lontano dal blues in senso
stretto. Egli è stato, infatti, un musicista che, partendo come chitarrista dal
natio Massachusetts, ha attraversato la stagione rock americana degli anni ’80
in diverse formazioni minori: Treat Her Right, Hipnosonics, Pale Bros., Super
Group, Candy Bar, Treat Her Orange. Tutte band che hanno lasciato tracce
discografiche con il suo contributo di luminoso songster. L’avventura musicale di Mark Sandman si sviluppa lontano dal blues in senso
stretto. Egli è stato, infatti, un musicista che, partendo come chitarrista dal
natio Massachusetts, ha attraversato la stagione rock americana degli anni ’80
in diverse formazioni minori: Treat Her Right, Hipnosonics, Pale Bros., Super
Group, Candy Bar, Treat Her Orange. Tutte band che hanno lasciato tracce
discografiche con il suo contributo di luminoso songster.
Con la costituzione dei Morphine – del quale era cantante, bassista ed
indiscusso leader – si affina uno stile sempre più immerso nelle crepuscolari
atmosfere blues e jazz. Scarnificando all’inverosimile la scrittura musicale,
egli ha lasciato tracce indelebili anche nella storia del bassismo blues. Basti
ricordare che, in controtendenza con la presunta evoluzione dello strumento
(arrivato nel frattempo a sei corde ed oltre), egli si costruì un basso
baritono, a due sole corde, suonato con tecnica prevalentemente slide. L’aspetto
che lo rende uno fra i più importanti innovatori nell’asfittico bassismo moderno
è il recupero totale dei ruoli base dello strumento. Nonostante una parziale
“regressione” verso il washtube bass d’inizio secolo, egli è stato autore di
prorompenti grooves ed esplosivi sostegni armonico-ritmici su cui si articolano
quasi tutti gli arrangiamenti delle composizioni. Culmine e cifra estetica della
sua opera sono ben rappresentati nell’album “Cure For Pain” del 1993. Tutto ciò
è stato reso possibile grazie anche alla particolare line-up della band - priva
di chitarra - con Dana Colley al sax baritono e Billy Conway alla batteria.
Una morte prematura ha privato il mondo delle basse frequenze di un musicista di
culto, di un vivace catalizzatore e d’inimmaginabili sviluppi stilistici per il
basso.
TOMMY SHANNON
(Tucson, Texas 1946)
 Tommy Shannon ha attraversato l’intera storia del rock blues dagli anni ’60 fino
ad oggi. Dopo il suo trasferimento da Tucson a Dallas suona nei New Breed, soul
band in cui milita Uncle John Turner, brillante batterista e amico d’infanzia di
Johnny Winter. Quando nel ’68 Uncle John lasciò i New Breed per unirsi a Winter
chiamò con sè anche Shannon, costituendo l’ossatura del seminale trio
Progressive Blues Experiment. Il management Columbia liquidò, tuttavia, la
sezione ritmica della band dopo un paio d’anni e Shannon andò incontro a una
drammatica crisi personale. L’abuso di droghe e la frequenza di ambienti
criminosi lo trascinarono in carcere e in diversi centri per tossicodipendenti.
Il mondo musicale si dimenticò a lungo di lui prima che potesse ritornare al
seguito di Rocky Hill (fratello di Dusty degli ZZ Top). Tommy Shannon ha attraversato l’intera storia del rock blues dagli anni ’60 fino
ad oggi. Dopo il suo trasferimento da Tucson a Dallas suona nei New Breed, soul
band in cui milita Uncle John Turner, brillante batterista e amico d’infanzia di
Johnny Winter. Quando nel ’68 Uncle John lasciò i New Breed per unirsi a Winter
chiamò con sè anche Shannon, costituendo l’ossatura del seminale trio
Progressive Blues Experiment. Il management Columbia liquidò, tuttavia, la
sezione ritmica della band dopo un paio d’anni e Shannon andò incontro a una
drammatica crisi personale. L’abuso di droghe e la frequenza di ambienti
criminosi lo trascinarono in carcere e in diversi centri per tossicodipendenti.
Il mondo musicale si dimenticò a lungo di lui prima che potesse ritornare al
seguito di Rocky Hill (fratello di Dusty degli ZZ Top).
Nel 1980 Shannon incrociò definitivamente la strada di Stevie Ray Vaughan,
andando a costituire i Double Trouble con il batterista Chris Layton. Con
Vaughan condivise oltre 9 anni di tours, incisioni discografiche e successi.
Insieme a Layton costituì una terrificante partnership ritmica, sopravvissuta
anche alla morte dello stesso SRV. Infatti, oltre alla collaborazione con gli
Arc Angels di Doyle Bramhall II e Charlie Sexton, i Double Trouble hanno inciso
dischi con numerosi giovani guitar herpes e nel 2001 hanno persino realizzato un
titolo a proprio nome con la partecipazione di diversi axe-men, onorati di
suonare con una sezione ritmica tanto gloriosa.
Nonostante le travagliate vicissitudini personali, Tommy Shannon ha potuto
suonare con alcuni dei più importanti artisti della storia del rock e del blues:
Canned Heat, Quicksilver Messenger Service, Eric Clapton, Jeff Beck, Little
Richard (persino i Rolling Stones lo interpellarono per la sostituzione di Bill
Wyman). Anche l’attività discografica gli ha riservato diverse soddisfazioni.
Oltre alle incisioni con Johnny Winter e Stevie Ray Vaughan ricordiamo quelle
con Albert Cummings, Buddy Miles, Nuno Mindelis, Kenny Wayne Shepherd, Debbie
Davies, W.C. Clark, Alan Haynes, Little Jimmy King, Storyville, Buddy Guy, Arc
Angels, Edgar Winter.
BOB STROGER
(Haiti, Missouri, 1940)
 Robert Stroger è uno tra i più leggendari bassisti ancora oggi attivi.
Trasferitosi nel West Side di Chicago nel 1955, vivendo in un appartamento alle
spalle di un club ove le basse frequenze delle band di Howling Wolf e Muddy
Waters facevano tremare le pareti, egli comprese cosa sarebbe voluto diventare
nella vita: un bassista di blues. Robert Stroger è uno tra i più leggendari bassisti ancora oggi attivi.
Trasferitosi nel West Side di Chicago nel 1955, vivendo in un appartamento alle
spalle di un club ove le basse frequenze delle band di Howling Wolf e Muddy
Waters facevano tremare le pareti, egli comprese cosa sarebbe voluto diventare
nella vita: un bassista di blues.
La carriera musicale di Stroger cominciò con una band propria, formata insieme
al fratello John. Suonò insieme a Willie Kent e quindi nella jazz band di Rufus
Forman. Successivamente divenne asse portante del combo Eddie King and the King
Men, la cui collaborazione si protrasse per oltre 15 anni. Con essi incise nel
‘65 il suo primo 45 giri dal titolo “Love You Baby”. L’incontro con Otis Rush,
alla ricerca di un bassista per un tour europeo, gli schiuse le porte della
scena blues che conta. Le sue collaborazioni annoverano artisti del calibro di
Sunnyland Slim, Louis Meyers, Jimmy Rogers, Odie Payne, Eddie Taylor, Willie
Mabon, Hubert Sumlin, Jimmy Walker, Luther Tucker, Bo Didley, James Cotton, Kim
Wilson, Pinetop Perkins, Fenton Robinson, Zora Young, Big Time Sarah, Dietra
Farr e molte altre personalità del blues.
Bob Stroger è stato un maestro nella definizione del “walking”, tipico stile
bassistico di accompagnamento nel Chicago Sound. Il suo relax ed understatment
lo rendono ancora richiesto in studio di registrazione. Egli ha, infatti,
partecipato alle produzioni discografiche di una trentina di artisti diversi:
Eddie Taylor, Otis Rush, Jimmy Rogers, Lousiana Red, Buster Benton, Mad Dog
Luster, Homesick James, Larry Burton, Eddie King, Big Bill Morganfield,
Mississippi Heat, Big Bill Hickey, Big Four, Snooky Pryor ecc..
Sebbene abbia suonato anche Jazz e R&B, lo stile musicale con cui Bob Stroger
meglio s’identifica è decisamente il Blues. Nei suoi quasi 50 anni di carriera,
ha costituito sezioni ritmiche di prim’ordine insieme a batteristi del calibro
di Odie Payne Jr., Fred Below, Robert Covington, S.P. Leary, Ted Harvey, K.C.
Jones, Sam Lay, Jessie Green, Willie "Big Eyes" Smith, Billy Davenport,
praticamente il top del batterismo blues mondiale.
LARRY TAYLOR
(Brooklyn, New York, giugno 1942)
 Larry “The Mole” Taylor è cresciuto in una famiglia ove la musica non mancava
mai d’accompagnare le giornate. Il padre, il nonno e gli zii suonavano tutti la
chitarra o il banjo. Il fratello maggiore Mel - batterista nei mitici Ventures -
era già un professionista quando il giovane Larry cominciò a considerare la
musica parte integrante della sua vita. Diffusamente conosciuto come il bassista
della seminale band dei Canned Heat, Larry Taylor ha avuto, in realtà, una lunga
e variegata carriera. Dopo un’esperienza in tour con Jerry Lee Lewis, appena
diciottenne, diventò musicista residente in molte sessioni di studio dei Monkees.
La parentesi Canned Heat lo vede attivo nel periodo migliore (1967-70), quando
la band della West Coast era considerata pioniera di certo blues bianco, non
rigidamente aderente agli stilemi del blues classico. Successivamente, Larry
Taylor entrò nella prima backing band tutta statunitense di John Mayall,
partecipando alle registrazioni di “USA Union” e di altri album “americani” del
bluesman britannico. Larry “The Mole” Taylor è cresciuto in una famiglia ove la musica non mancava
mai d’accompagnare le giornate. Il padre, il nonno e gli zii suonavano tutti la
chitarra o il banjo. Il fratello maggiore Mel - batterista nei mitici Ventures -
era già un professionista quando il giovane Larry cominciò a considerare la
musica parte integrante della sua vita. Diffusamente conosciuto come il bassista
della seminale band dei Canned Heat, Larry Taylor ha avuto, in realtà, una lunga
e variegata carriera. Dopo un’esperienza in tour con Jerry Lee Lewis, appena
diciottenne, diventò musicista residente in molte sessioni di studio dei Monkees.
La parentesi Canned Heat lo vede attivo nel periodo migliore (1967-70), quando
la band della West Coast era considerata pioniera di certo blues bianco, non
rigidamente aderente agli stilemi del blues classico. Successivamente, Larry
Taylor entrò nella prima backing band tutta statunitense di John Mayall,
partecipando alle registrazioni di “USA Union” e di altri album “americani” del
bluesman britannico.
Durante un’ultra trentennale carriera, Taylor ha suonato nei lavori discografici
di numerosi artisti di blues: Big Al Blake, Hollywood Fats, John Hammond, John
Lee Hooker, Albert King, Little Milton, Kelly Joe Phelps, Tad Robinson, Alex
Schultz, Lynwood Slim, Phillip Walker, Smokey Wilson, Kim Wilson ecc.. Ha anche
partecipato a incisioni per artisti diversi - meno ortodossi - come Leo Kottke,
Harvey Mandel, Fernando Ortega, Freddie Roulette ed Andy Summer.
Dedicatosi anche allo studio del contrabbasso, Taylor è rimasto musicista
essenziale ma dotato di notevole feeling, sulla scia dei grandi interpreti dello
strumento. Quasi a voler comunicare la partecipazione fisica ai brani, le sue
performance sono caratterizzate da un tipico ondeggiamento della testa, che
sembra impartire maggiore dinamismo alle linee di basso. Da molti anni suona
stabilmente negli album e nei live set di un certo Tom Waits.
Numerosi sono ancora i fantastici bassisti che hanno contribuito alla causa
blues. Vanno quantomeno menzionati Roscoe Beck, Jack Bruce, Bryan "Chas"
Chandler, Michel Duster, Russel Jackson, Calvin Jones, Noel Neal, Tyler Pedersen,
Rick Reed, Bill Stuve e chissà quanti altri. L’elenco non è certamente esaustivo
e non ha la presunzione d’esserlo, essendo peraltro condizionato dal gusto
personale. Si tratta solo di un tentativo di riposizionare il ruolo di
musicisti, fondamentali nell’evoluzione della musica nera, ma spesso considerati
poco più che sparring partners per cantanti, chitarristi, armonicisti e
pianisti. Una rivendicazione solo in apparenza superflua visto il contributo che
le basse frequenze hanno fornito all’estensione dell’influenza del blues su
tutta la musica moderna.
IL BLUES: RURALE,
JAZZISTICO, URBANO
di Giuliano Iezzi
Non sono un musicista di professione,
ma nel corso di 35 anni di attività ho “investito” parte dei miei guadagni in
strumenti musicali e dischi (parlo di LP in vinile). Fino a qualche mese fa per
impegni di lavoro non avevo molto tempo per ascoltare musica, ma continuavo a
comprare dischi ed a riporli in un sottotetto ben chiusi in un vecchio armadio.
Ho sempre pensato che alla fine sarebbe arrivato un “momento” di calma e mi
sarei comodamente
 riappropriato del tempo libero, dedicandolo all’ascolto
approfondito della produzione musicale degli ultimi 40/50 anni. riappropriato del tempo libero, dedicandolo all’ascolto
approfondito della produzione musicale degli ultimi 40/50 anni.
Il fatto che i dischi fossero custoditi sottochiave non era a caso. Dovevo
proteggerli dalle manine dei miei due meravigliosi bambini che lasciavano il
“segno” su qualunque oggetto toccassero! L’unica cosa che facevo quando compravo
un disco scrivevo sulla busta interna la data di acquisto. A volte annotavo il
prezzo.
La scorsa estate mi sono accorto che i bambini erano sufficientemente cresciuti
ed ho ritenuto che il “momento” che avevo tanto sognato fosse giunto. Così un
bel week-end ho fatto saltare il vecchio lucchetto ormai ossidato e come uno
scrigno, lentamente, ho spalancato le ante del famoso armadio.
Indubbiamente ero molto emozionato quando ho cominciato a rivedere cose che
avevo dimenticato nel tempo. La copertina “provvisoria” di Aladdin Sane di David
Bowie, la copertina damascata di Living in the Past dei Jetro Tull, le copertine
imposte dalla censura italiana ad Electric Ladyland nn.1 e 2 di Jimi Hendrix, le
copertine apribili a libro con all’interno i testi surreali dei primi dischi del
King Crimson, le copertine della collana Jazz History distribuita negli anni ’70
dalla Polydor con la bandiera americana riprodotta su vari oggetti e così via.
Mentre sfogliavo questi LP ed i ricordi cominciavano a riaffiorare ed a scorrere
come veloci flashback, in mezzo ad album ed etichette storiche suonati da band
leggendarie, ho trovato una raccolta di cui avevo completamente perso la
memoria. Era una scatola delle dimensioni di un LP, alta un paio di centimetri,
che conteneva tre dischi con etichetta “Albatros” ed un opuscolo esplicativo di
28 pagine il tutto curato da Alessandro ROFFENI. Sulla copertina di carta di un
disco era annotato: “dicembre 1980 Selezione £.5.000”. Era un’offerta natalizia
di Selezione del Reader’s Digest che acquistai più che altro per la
documentazione storica, spinto sopratutto dal fatto che l’intero cofanetto
costava grossomodo molto meno di un singolo LP dell’epoca. Ricordo che ricevuto
il pacchetto sfogliai appena l’opuscolo, per vedere le foto all’interno ed ascoltai tre o quattro brani tanto per avere un’idea di cosa avevo acquistato.
Il cofanetto in questione è una raccolta di 48 canzoni che vanno dal 1926 al
1939 con l’unica eccezione un brano datato 1956 cantato da Furry LEWIS. Questi
dischi sono divisi per Blues Rurale, Urbano e Jazzistico e sono eseguiti da
artisti a me cominciavano a riaffiorare ed a scorrere
come veloci flashback, in mezzo ad album ed etichette storiche suonati da band
leggendarie, ho trovato una raccolta di cui avevo completamente perso la
memoria. Era una scatola delle dimensioni di un LP, alta un paio di centimetri,
che conteneva tre dischi con etichetta “Albatros” ed un opuscolo esplicativo di
28 pagine il tutto curato da Alessandro ROFFENI. Sulla copertina di carta di un
disco era annotato: “dicembre 1980 Selezione £.5.000”. Era un’offerta natalizia
di Selezione del Reader’s Digest che acquistai più che altro per la
documentazione storica, spinto sopratutto dal fatto che l’intero cofanetto
costava grossomodo molto meno di un singolo LP dell’epoca. Ricordo che ricevuto
il pacchetto sfogliai appena l’opuscolo, per vedere le foto all’interno ed ascoltai tre o quattro brani tanto per avere un’idea di cosa avevo acquistato.
Il cofanetto in questione è una raccolta di 48 canzoni che vanno dal 1926 al
1939 con l’unica eccezione un brano datato 1956 cantato da Furry LEWIS. Questi
dischi sono divisi per Blues Rurale, Urbano e Jazzistico e sono eseguiti da
artisti a me
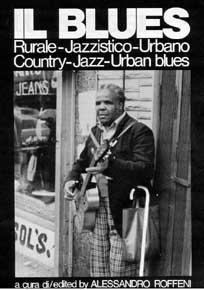 sconosciuti ad eccezione di Robert Johnson. sconosciuti ad eccezione di Robert Johnson.
Sembrerà strano, ma in mezzo a tutti quei dischi che avevo sognato di ascoltare
per anni, ho messo sul piatto un LP a caso dei tre ed ho cominciato a sfogliare
l’opuscolo. Mentre la musica cominciava a diffondersi nel sottotetto con le voci
ed i suoni stridenti tipici di registrazioni di circa 70/80 anni fa mi sono
sentito proiettato indietro nel tempo in una barrel-house. E’ impressionante la
sensazione che ho provato ascoltando quella musica. Nonostante siano brani
registrati con apparecchiature di quasi un secolo fa, riescono a comunicare il
feeling con il quale sono stati eseguiti. Si sentono le voci roche e la quasi
onnipresente chitarra suonata in maniera essenziale così come agli altri
strumenti. Si distinguono il piano, il banjo, il contrabbasso, l’armonica, i
piedi battuti sul tavolato per dare il tempo. In un brano, il bottleneck è usato
fino all’esasperazione diventando il principale interprete della canzone. Si
percepisce che tutti i brani sono sanguigni ed il protagonista è sempre lui: il
“Signor Blues”, uno spirito a volte angelo a volte demone che si impadronisce
della mente nutrendosi delle sofferenze celate nelle pieghe più intime
dell’anima. Ma il “Signor Blues” sa anche capire i propri figli ed insegna loro
a dimenticare, anche se per il solo tempo di una canzone, queste povere storie
di tutti i giorni raccontandole nelle strade, nelle periferie, nelle
barrel-house, nei bordelli, nelle fabbriche, nei campi, nelle prigioni.
E’ notevole l’opera di ricerca storica che è stata fatta per confezionare questa
raccolta. Un documento che prova che il blues è parte integrante della storia
americana. I testi delle canzoni narrano di sofferenze, partenze o ritorni a
casa, lavoro perso, amori appena cominciati o finiti. Nei viaggi il protagonista
è il treno che simbolicamente strappa l’individuo dalla terra natia e dagli
affetti e lo porta lontano a cercare lavoro o lo riporta a casa sfinito.
Il libretto allegato a cura di Alessandro ROFFENI è diviso in due parti. Nelle
prima parte l’autore traccia un profilo storico dell’America dei primi anni del
‘900 ponendo il blues in questo contesto e spiegandone le motivazioni sociali e
la successiva evoluzione del blues dal country al jazz all’urban. Nella seconda
parte, per me la più importante, sono riportati i testi delle canzoni sia in
lingua originale sia in italiano con note tecniche sugli strumenti usati e
notizie storiche sui musicisti.
Da buon estimatore e studioso di cultura americana e di blues A.R. apre con una
premessa disapprovando i suoi colleghi giornalisti o presunti tali che si sono
improvvisati esperti di blues appena questo è venuto di moda e che ne parlano e
soprattutto ne scrivono senza averne la conoscenza adeguata. D’altronde A.R. non
è la prima persona che anticipa un “qualcosa” ed è ignorato fino a quando quel
“qualcosa”, diventato di moda, viene dottamente trattato da proprio da coloro i
quali lo avevano precedentemente snobbato. si sono
improvvisati esperti di blues appena questo è venuto di moda e che ne parlano e
soprattutto ne scrivono senza averne la conoscenza adeguata. D’altronde A.R. non
è la prima persona che anticipa un “qualcosa” ed è ignorato fino a quando quel
“qualcosa”, diventato di moda, viene dottamente trattato da proprio da coloro i
quali lo avevano precedentemente snobbato.
I tre dischi di blues sono divisi in: rurale, jazzistico e urbano ma non sono
dischi a “compartimenti stagni” si arricchisce solo il sound. Dal semplice stile
rurale al raffinato jazz al graffiante urbano hanno sempre il filo conduttore
che li unisce: la storia americana dei primi anni del secolo scorso. Le canzoni
narrano storie comuni di una parte dell’America e della società americana da
quando sono possibili datarle e sopratutto da quando si hanno documentazioni
scritte o sonore.
Di seguito cito testualmente il concetto base di A.R. che inquadra perfettamente
il blues nel contesto sociale americano: “……possiamo asserire che con ogni
probabilità il blues rappresenta e uno strumento per eccellenza che gli ex
africani trasportati con la violenza in America si sono scelti dopo la
cessazione della schiavitù, per affrontare psicologicamente e culturalmente la
loro condizione umano-sociale sconvolta e disgregata.”
Condivido ciò pienamente, conosciamo tutti la storia delle deportazioni in massa
di popolazioni di interi villaggi africani nel nuovo mondo tra la fine de
 1700
ed il 1800. Esseri umani strappati con violenza dalla loro terra, trattati
peggio degli animali e venduti al mercato degli schiavi come bestie, torturati,
seviziati, malnutriti, fatti morire di stenti. Per fortuna che alla fine arriva
la guerra di secessione per cancellare forzatamente questa vergogna e liberare
questa popolo dalla schiavitù. Però……! Che “fortuna” che hanno avuto questi
negri! Sono stati maltrattati e sfruttati per decenni ma alla fine qualcuno ha
fatto una guerra appositamente per loro per liberarli dalla schiavitù dei vecchi
padroni! Non ha importanza che alla fine della guerra l’ex schiavo si è sentito
dire dai liberatori: “Ti ho tolto dalla schiavitù negro! La tua libertà la devi
all’uomo bianco! Cos’altro vuoi? Adesso arrangiati a cercare un lavoro, sei
libero di trovartelo liberamente!”. E 1700
ed il 1800. Esseri umani strappati con violenza dalla loro terra, trattati
peggio degli animali e venduti al mercato degli schiavi come bestie, torturati,
seviziati, malnutriti, fatti morire di stenti. Per fortuna che alla fine arriva
la guerra di secessione per cancellare forzatamente questa vergogna e liberare
questa popolo dalla schiavitù. Però……! Che “fortuna” che hanno avuto questi
negri! Sono stati maltrattati e sfruttati per decenni ma alla fine qualcuno ha
fatto una guerra appositamente per loro per liberarli dalla schiavitù dei vecchi
padroni! Non ha importanza che alla fine della guerra l’ex schiavo si è sentito
dire dai liberatori: “Ti ho tolto dalla schiavitù negro! La tua libertà la devi
all’uomo bianco! Cos’altro vuoi? Adesso arrangiati a cercare un lavoro, sei
libero di trovartelo liberamente!”. E cosa potevano fare adesso questi poveri
disgraziati per vivere? Certo che in Africa non potevano tornare, visto che
l’America è un “Grande Paese” non rimaneva altro che la possibilità di emigrare.
Questa volta però non c’erano i mercanti di schiavi a trasportali su veloci
imbarcazioni; potevano viaggiare liberamente all’interno del “Grande Paese” nei
vagoni dei treni merci. cosa potevano fare adesso questi poveri
disgraziati per vivere? Certo che in Africa non potevano tornare, visto che
l’America è un “Grande Paese” non rimaneva altro che la possibilità di emigrare.
Questa volta però non c’erano i mercanti di schiavi a trasportali su veloci
imbarcazioni; potevano viaggiare liberamente all’interno del “Grande Paese” nei
vagoni dei treni merci.
Così grandi masse di sbandati senza casa, senza lavoro e senza futuro hanno
cominciato a spostarsi da una parte all’altra del “Grande Paese” il quale aveva
dato a loro la libertà di farsi schiavizzare dove meglio credevano e soprattutto
da chi credevano. E così dove c’erano agglomerati industriali bisognosi di mano
d’opera (a salari da fame), dentro le barrel-house, nei bordelli, i campi, le
fabbriche e le prigioni i negri erano finalmente “liberi” di esprimere il loro
tormento con il blues.
Non voglio dilungarmi oltre sul contenuto musicale di quest’opera poiché
potrebbe risultare noioso, però mi sembrava opportuno segnalarlo ad un sito come
“Spaghetti & Blues”. Il cofanetto è praticamente introvabile nei negozi di
dischi, però con un po’ di fortuna e pazienza se ne possono ancora trovare delle
copie nei tipici mercatini di oggetti e cianfrusaglie varie che si tengono in
molte città italiane una volta al mese. Forse qualche copia potrebbe averla a
casa Alessandro ROFFENI al quale
dedico queste mie riflessioni.
God bless Leo FENDER and the TELECASTER guitar!
Cosa Resterà del Blues italiano?
parte II
di Amedeo Zittano
… continuando a “camminare sulla
strada”, sono passati quasi quattro anni.
 Ricordo
come fosse ieri l’ottobre del 2002 quando, con "Gocce Di Blues", aprimmo allo
Sly di Napoli il concerto dei messinesi “King Biscuit Time”, band in cui suonava
Michele Lotta. Prima del concerto parlammo a lungo del blues, in particolare di
quello Italiano. Le argomentazioni su cui il confronto si concentrò maggiormente
furono le problematiche relative alle attività bluesistiche italiane,
penalizzate più che mai sotto il profilo culturale; in particolare si parlò di
un articolo pubblicato su "Musica" allegato di "La Repubblica" intitolato
"Spaghetti Blues" dal quale si evinceva una palese critica nei confronti dei
musicisti italiani accusati di scimmiottare
gli stili americani e inglesi tranne, ovviamente, qualche rara eccezione
riferita ai più noti bluesman italiani. Evidentemente il giornalista che
scriveva non aveva allora l’esatta percezione del movimento bluesistico
italiano, tuttavia quelle poche righe stimolarono un salutare dibattito che si
concluse con la nascita di un nuovo movimento anche se quella sera ancora non lo
sapevamo. Insomma quella provocazione editoriale mosse ulteriormente le acque. Ricordo
come fosse ieri l’ottobre del 2002 quando, con "Gocce Di Blues", aprimmo allo
Sly di Napoli il concerto dei messinesi “King Biscuit Time”, band in cui suonava
Michele Lotta. Prima del concerto parlammo a lungo del blues, in particolare di
quello Italiano. Le argomentazioni su cui il confronto si concentrò maggiormente
furono le problematiche relative alle attività bluesistiche italiane,
penalizzate più che mai sotto il profilo culturale; in particolare si parlò di
un articolo pubblicato su "Musica" allegato di "La Repubblica" intitolato
"Spaghetti Blues" dal quale si evinceva una palese critica nei confronti dei
musicisti italiani accusati di scimmiottare
gli stili americani e inglesi tranne, ovviamente, qualche rara eccezione
riferita ai più noti bluesman italiani. Evidentemente il giornalista che
scriveva non aveva allora l’esatta percezione del movimento bluesistico
italiano, tuttavia quelle poche righe stimolarono un salutare dibattito che si
concluse con la nascita di un nuovo movimento anche se quella sera ancora non lo
sapevamo. Insomma quella provocazione editoriale mosse ulteriormente le acque.
Nel gennaio 2003 proposi a Michele un progetto, per l’appunto Spaghetti & Blues
(sia perché è il termine con cui gli americani identificano il blues italiano,
sia in risposta al su citato articolo), la "&" fu aggiunta in senso ironico, un
po' come dire “pasta & cozze” (ricetta culinaria), ma nel contempo
l’amalgamazione dell’Italia al blues.
Avevamo bisogno di un canale comune che esprimesse la nostra cultura e
coordinasse le nostre azioni, decidemmo così di acquistare un dominio web ed il
30 ottobre del 2003 (centenario del Blues) nacque il sito spaghettiblues.it un
grande Movimento Culturale, autogestito dagli stessi bluesofili, con
l’obbiettivo di "far girare" il blues.
Così, pian pianino, siamo arrivati ad essere uno dei riferimenti più seguiti
d’Italia.
Alla vigilia del primo incontro nazionale, in occasione del CrossRoadBlues
Matera 2006 (che avrà luogo nei giorni 6-7-8-9 luglio 2006), ritengo sia
opportuno lanciare un altro "messaggio nella bottiglia" (o, se preferite,
"servire un’altra portata") a tutti coloro che amano il blues come noi e che
vorrebbero fare qualcosa per la sua divulgazione: spaghettari e non, uniamoci in
un grande coro, divulghiamo il verbo di Spaghetti & Blues, affinchè un fenomeno
considerato sino ad oggi "di nicchia" si apra ad un pubblico sempre più numeroso
e competente! Sono fermamente convinto che sia giunta l’ora di uscire dalle
tenebre delle sale prova per "prenderci" gli spazi che abbiamo sempre desiderato
e che ci competono.
Se un pugno di ostinati è riuscito a creare, in pochi anni, un punto di
riferimento, pensate cosa potremmo ottenere domani tutti assieme.
Che il Blues sia con noi e con il nostro strumento… qualunque esso sia.
“BLUES” - Edoardo Fassio
di Amedeo Zittano
Prefazione di Massimo Carlotto -
Editori Laterza, collana Contromano
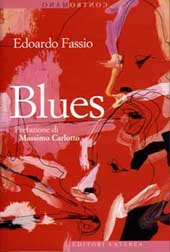 “Catfish,
il vostro Blue-Jay preferito!”, questa è la frase di rito con cui Edoardo, dal
1984, si presenta al pubblico radiofonico proponendo programmazioni di blues e
musica “nera” più in generale. La dialettica, lo spirito sempre giovane e la
profonda conoscenza del genere, sono da sempre l’anima del suo successo. Hanno
goduto della sua voce un gran numero di emittenti radio di tutta Europa, in
particolare la Rai, Radio Flash e Radio Torino Popolare ma anche emittenti
U.S.A. come la KDHX di St. Louis e la WROX di Clarksdale, Delta del Mississippi.
Scrive di blues, folk e jazz per i quotidiani: “La Stampa”, “TorinoSette” e “Il
Blues”, oltre che per un numero imprecisato di riviste europee. “Catfish,
il vostro Blue-Jay preferito!”, questa è la frase di rito con cui Edoardo, dal
1984, si presenta al pubblico radiofonico proponendo programmazioni di blues e
musica “nera” più in generale. La dialettica, lo spirito sempre giovane e la
profonda conoscenza del genere, sono da sempre l’anima del suo successo. Hanno
goduto della sua voce un gran numero di emittenti radio di tutta Europa, in
particolare la Rai, Radio Flash e Radio Torino Popolare ma anche emittenti
U.S.A. come la KDHX di St. Louis e la WROX di Clarksdale, Delta del Mississippi.
Scrive di blues, folk e jazz per i quotidiani: “La Stampa”, “TorinoSette” e “Il
Blues”, oltre che per un numero imprecisato di riviste europee.
Nel 2002 ha ottenuto il celeberrimo “Sweet Soul Music Award" per l'impegno
profuso nella diffusione della musica soul e rhythm & blues, riconoscimento già
attribuito a personalità del calibro di Solomon Burke, Renzo Arbore e Peter
Guralnick. Così, dopo ventidue anni di attività, Edoardo decide di pubblicare -
finalmente - il suo primo libro, intitolandolo semplicemente “Blues”. È risaputo
che il blues è pieno di “contraddittorie sicurezze” per via delle
caratteristiche relative ai luoghi, ai tempi e alle condizioni individuali in
cui è nato. È difficile quindi spiegare l’essenza Blues e contemporaneamente
essere fedeli alle informazioni documentate (strettamente storiche), intrinse di
nomi, date e avvenimenti, senza essere troppo pignoli o troppo vaghi. Edoardo
propone una forma discorsiva e un’organizzazione testuale originali che
incuriosiscono il lettore immergendolo in un clima gradevole, quasi “romanzesco”
(passatemi il termine), del tipo: “una pagina tira l’altra...”. Il libro è
diviso in 18 capitoli. Alla fine di ognuno compare un campionario di oggetti che
lo integrano, come: libri, dischi e video a tema.
In buona sostanza, “Blues” è un fantastico viaggio che ripercorre le vie della
Musica del Diavolo dalle origini ad oggi, organizzato con dati storici alternati
ad aneddoti di varia natura, per svelare al lettore il vero significato del
Blues e di come, pur “vecchio e solito”, sia contemporaneo, universale ed intimo
più di quanto si possa immaginare.
Un grazie dunque a “Catfish” Fassio per aver ulteriormente contribuito, con la
sua iniziativa editoriale, all’accrescimento della cultura blues made in Italy.
Concludo con un pensiero di Edoardo: “È ancora un segreto che vale più di un
milione, eppure conviene rivelarlo.” Buona lettura.
Metti un Blues a cena
di Michele Lotta
“Summertime Blues festival” - Alcamo (TP),
sabato 29 luglio 2006.
 Conoscere
Big Bill Morganfield è stata un’occasione unica per avvicinarsi al Blues per il
tramite di una nobile discendenza. Un felice ed interessante
momento di digressione musical-culinaria che ha portato i commensali a
pasteggiare allegramente valutando, tra un boccone ed un sorso di birra, certi
aspetti del Blues contemporaneo. Conoscere
Big Bill Morganfield è stata un’occasione unica per avvicinarsi al Blues per il
tramite di una nobile discendenza. Un felice ed interessante
momento di digressione musical-culinaria che ha portato i commensali a
pasteggiare allegramente valutando, tra un boccone ed un sorso di birra, certi
aspetti del Blues contemporaneo.
 Big Bill, classe 1956, non ama parlare molto del padre che ha conosciuto
soltanto all’età di 18 anni. Nato da una relazione tra Mary Austin, una ragazza
della Florida all’epoca diciannovenne, e Muddy, BB è cresciuto con la madre che,
incinta ed al culmine di una relazione burrascosa, fuggì letteralmente da
Chicago portandolo con se. Big Bill, classe 1956, non ama parlare molto del padre che ha conosciuto
soltanto all’età di 18 anni. Nato da una relazione tra Mary Austin, una ragazza
della Florida all’epoca diciannovenne, e Muddy, BB è cresciuto con la madre che,
incinta ed al culmine di una relazione burrascosa, fuggì letteralmente da
Chicago portandolo con se.
La prima volta che Big Bill incontrò il padre fu quando, appreso dalla radio che Muddy Waters avrebbe tenuto un concerto ad Atlanta (città nella quale vive ancor
oggi), decise di andarlo a trovare. In quell’occasione si presentò nei camerini
e gli disse di essere il figlio di Mary. Allora Muddy lo abbraccio dicendo: “Se
sei il figlio di Mary, allora sei anche mio figlio!” (la somiglianza tra i due
non lasciava alcun dubbio).
Il rapporto tra padre e figlio si è quindi concretizzato attraverso l’ascolto
dei numerosi dischi di Muddy. BB dice di averli studiati tutti per carpirne i segreti.
Non è certo un caso che anche lui, oggi, imbracci una Telecaster rossa.
ML: In Italia ti abbiamo conosciuto qualche anno fa con il tuo primo album
“Rising Son”. Quando è iniziata, in realtà, la tua carriera?
BBM: ... professionalmente, più o meno, nel 1998. Il primo album è del 1999
(un tempo breve ma sufficiente per fargli guadagnare il premio W.C. Handy Award nel 2000 come miglior
nuovo talento. ndr)
ML: Il tuo cognome è molto “ingombrante”, che effetto ha avuto nella tua
carriera?
BBM: Un duplice effetto. C’è, ovviamente, l’aspetto positivo ma quando faccio le
canzoni di Muddy Waters la gente si aspetta che io le suoni come l’originale.
Ogni comparazione però non soddisfa appieno perché Muddy è stato un grandissimo
e nessuno riesce ad interpretare le canzoni come lui faceva. Questo è duro
per me.
ML: Hai dei ricordi particolari di tuo padre e quale messaggio ti ha lasciato? BBM:
Lui non mi ha dato un messaggio particolare… la sua memoria ha preferito tenerla
per se. La prima volta che lo vidi dal vivo, avevo 18 anni, ha avuto su di me un
effetto molto forte, non avevo mai sentito Blues come quello. Quando ascoltai il
suo primo disco con particolare attenzione ero all’Università, più o meno nello
stesso periodo.
|

Brian Bisesi e BB Morganfield
|
ML: Quali chitarristi ti hanno ispirato?
BBM: Muddy Waters, totalmente!
ML: Quali altri bluesmen sono stati importanti per te? BBM: Robert Johnson, uhmm, tanti… B.B. King, Albert King, Lithning Hopkins, Son
House, “all the cats” (tutti i gatti: frase iodiomatica che identifica
l’appartenenza allo stesso ambiente. ndr), T-Bone Walker, Robert Nigthawk, Jimmy
Reed.
ML: Dove risiedei attualmente?
BBM: vivo ad Atlanta, Georgia.
ML: Qual’è, attualmente, l’interesse per il Blues in America?
BBM: Difficile, negli Stati Uniti è di anno in anno più dura, c’è sempre meno
interesse per la tradizione e la musica Blues in generale, c’è più interesse e
rispetto in Europa per la tradizione Blues e per ogni cosa, specialmente in
Italia, Francia, ecc. E’ dura, è dura, ma qualcosa sta cambiando, piano, piano,
anche in America.
ML: Secondo te, in quale misura ed in che modo il Blues si può evolvere?
BBM: Il Blues cambia abbastanza, però troppi giovani copiano nota per nota,
parola per parola, i vecchi musicisti. Forse per questo motivo il Blues è meno
popolare in questo periodo, è visto come una pietanza che si ripropone da tanti
anni sempre uguale. La comunità nera oggi non è unita come era ai tempi di mio
padre. Il R’n’B, il Blues, il Jazz, il Rock, il Southern Rock e anche l’Hip Hop,
vivono una transizione tremenda, spesso mischiandosi tra loro. Il Blues molto meno perché tanti musicisti
mantengono la tradizione dei vecchi, ma questo –purtroppo- indebolisce la
fruizione del
Blues.
C’è molto entusiasmo per le cose nuove, come accade per una nuova donna. Quando
stai insieme ad una donna per 5 o 10 anni diventa abitudine, quando arriva una
nuova donna nella tua vita si accende l’entusiasmo… uhmm…. Tu lo sai!
E’ difficile dire quale sarà il futuro, è davvero difficile. Bisogna sempre
creare nuove canzoni e rendere i dischi diversi tra loro. Quando ho riascoltato il mio primo disco ho notato questa transizione con l’ultimo
“Blues in The Blood” (2003). Per questo disco ho scritto molte nuove
canzoni ed è andato bene.
ML: .. e, circa i tuoi programmi, cosa puoi dirmi?
BBM: Amico: io voglio essere come un prete, sempre disponibile e corretto con il
prossimo, senza dire parolacce né davanti agli altri, né in chiesa…
I feel good. Thank you.
Una birra con Chris Cain
di Filippo Tronca
 Esiste un prodotto tipico poco conosciuto
nell’Abruzzo dei Parchi, dello zafferano e della pecora alla còttora. Non è Esiste un prodotto tipico poco conosciuto
nell’Abruzzo dei Parchi, dello zafferano e della pecora alla còttora. Non è
 tutelato da marchi DOC e consorzi, non si organizzano per esso convegni e
seminari, non è compreso nelle guide alle sagre spesse come elenchi telefonici.
Parliamo del blues e ne è testimonianza il gran numero di band giovanili, di
appassionati e di festival. Sarà perché l’Abruzzo è anche una terra di emigranti
e “blues” è stata la loro storia (con la esse maiuscola) fatta di sofferenza e
sudore. Anche loro, come chi inventò il blues nelle piantagioni di cotone del Mississipi, impararono a sbarcare il lunario con il pane dell’autoironia e con
l’arte di trasformare il dolore in poesia, la rabbia in canto. Tra i vari
festival particolarmente interessante è Abruzzo nel blues, che quest’estate ha
fatto tappa a Pescara, Lanciano e Campli, portando gratuitamente grandi
musicisti come Billy Branch, Sharon Lewis, Thornetta Davis, Phil Guy, Enrico
Crivellaro. Ma chi ha lasciato il segno, soprattutto nel cuore della gente
semplice, è stato forse Chris Cain. Per la prima volta in Italia è considerato
da molti una delle più grandi chitarre blues in circolazione, addirittura
l’erede di Albert King, suo amico e maestro. Lo abbiamo incontrato a Campli, in
un caldo pomeriggio, intento a bere l’ennesima birra della giornata e a
chiacchierare divertito con gli anziani del paese, senza capire poi molto del
colorito slang locale. La globalizazione che ci piace. tutelato da marchi DOC e consorzi, non si organizzano per esso convegni e
seminari, non è compreso nelle guide alle sagre spesse come elenchi telefonici.
Parliamo del blues e ne è testimonianza il gran numero di band giovanili, di
appassionati e di festival. Sarà perché l’Abruzzo è anche una terra di emigranti
e “blues” è stata la loro storia (con la esse maiuscola) fatta di sofferenza e
sudore. Anche loro, come chi inventò il blues nelle piantagioni di cotone del Mississipi, impararono a sbarcare il lunario con il pane dell’autoironia e con
l’arte di trasformare il dolore in poesia, la rabbia in canto. Tra i vari
festival particolarmente interessante è Abruzzo nel blues, che quest’estate ha
fatto tappa a Pescara, Lanciano e Campli, portando gratuitamente grandi
musicisti come Billy Branch, Sharon Lewis, Thornetta Davis, Phil Guy, Enrico
Crivellaro. Ma chi ha lasciato il segno, soprattutto nel cuore della gente
semplice, è stato forse Chris Cain. Per la prima volta in Italia è considerato
da molti una delle più grandi chitarre blues in circolazione, addirittura
l’erede di Albert King, suo amico e maestro. Lo abbiamo incontrato a Campli, in
un caldo pomeriggio, intento a bere l’ennesima birra della giornata e a
chiacchierare divertito con gli anziani del paese, senza capire poi molto del
colorito slang locale. La globalizazione che ci piace.
FT: Chris cominciamo dall’inizio: quando hai conosciuto il blues?
CC: Molto presto, a quattro anni. I miei genitori mi portarono a vedere un
concerto di BB King, è stato il loro regalo di compleanno. Allora non capivo
molto, ma certe cose ti restano dentro.
FT: Nella tua voce calda e fangosa ad esempio… che a molti ricorda quella di
B.B. King
CC: La voce, quella, è uscita da sola, ma il fatto che a casa mia consumavamo
dischi di King e altre grandi voci nere deve aver avuto il suo effetto.
FT: Quando hai iniziato a suonare la chitarra?
CC: Ho cominciato a suonare dall’età di otto anni. A diciotto già guadagnavo
qualcosa suonando nei locali di Memphis. Ma il momento in cui mi sono detto: “Ok
io nella vita farò il musicista e basta” è stato quando ho finito le scuole e ho
cominciato a viaggiare da solo, in altre città, in altre situazioni.
FT: Un musicista può essere anche un maestro di vita?
CC: Nella società dello spettacolo accade spesso. Ma io credo che un musicista
che sul palco si atteggia a sacerdote sbaglia di grosso. Vale molto di più la
sua esperienza di vita. Un libro che amo molto è "Brother Ray" di David Ritz. E’
la biografia di Ray Charles. E’ incredibile come quest’uomo, benchè cieco, abbia
girato tante città, scritto musica, addirittura guidato una moto e fatto
qualsiasi cosa con facilità. Ogni volta che mi sono trovato in difficoltà ho
pensato a lui, e non perché è un grande musicista.
FT: Ciò che rende unico il tuo blues sono le influenze jazz
CC: Sembra strano, ma i più grandi progressi tecnici che ho fatto con la
chitarra li devo al fatto che suono anche il sax, i pezzi di Charly Parker in
particolare. I confini tra i generi musicali e gli strumenti non sono così
definiti.
FT: Parliamo di confini: cosa ne pensi della guerra? Da americano cosa pensi
della politica di George Bush?
CC: Bush semplicemente è un uomo che non capisce, che non ha idea della
complessità del mondo. La violenza e la guerra nascono da questa ignoranza. Ma
il popolo americano sta finalmente aprendo gli occhi.
FT: Una via per la pace?
CC: Sono pessimista e non saprei dire come uscire da questo vicolo cieco.
Qualcosa può però insegnare una jam session. Per fare una buona jam servono
ottimi batteristi e bassisti che creano un spazio ritmico condiviso entro cui
dialogare. E poi ci servono ottimi solisti che con grande umiltà sono capaci di
ascoltarsi, anzi di ascoltare con le orecchie di chi suona con te e di sentire
la musica che si crea con il cuore dell’altro. Penso che i popoli che si
combattono da secoli e i soldati che si ammazzano senza sapere bene il perchè,
dovrebbero posare il fucile e provare a suonare insieme…
FT: Che consiglio dai ad un giovane musicista che vuole fare blues e diventare
famoso senza farsi male?
CC: Intorno alla musica, come intorno a tante altre cose belle, girano persone
che con la musica non hanno nulla a che fare e che vogliono usarti per appagare
la loro avidità e realizzare i loro obiettivi. E poi bisogna stare in guardia
dall’incredibile gelosia che intercorre tra i musicisti.
FT: Io ho scaricato gratuitamente un tuo cd da internet. Ti senti derubato?
CC: Se tu non avessi scaricato la mia musica probabilmente non saresti qui a
parlare con me. Io poi sono felice quando qualcuno sente la mia musica. Se
proprio vuoi saperlo l’altra settimana anche io ho scaricato un film coperto da
copyright, ma non dirlo a nessuno...
FT: Cantava il grande Sam Kooke: “E’ stato troppo difficile vivere/ma ho paura
di morire/ perché non so cosa c’è al di là del cielo”. Qual è il tuo rapporto
con la religione?
CC: Neanche io so cosa c’è al di là del cielo, ma è giusto che molti credano in
un paradiso, in un dio che riscatti le ingiustizie proprie e degli altri. Come
si può vivere senza illusioni?
FT: Canta invece Sharon Lewis: “il blues non fa prigionieri, dice semplicemente
quello che è”. Chris, mi racconti una storia “blues”?
CC: Ok ti racconto una storia “blues” molto triste. Andavo ad un concerto in
Arizona, avevamo preso a noleggio un furgone. L’autista aveva le orecchie
tappate per via di un’influenza e non sentiva gli strani rumori del motore. Così
siamo rimasti a piedi, abbiamo portato il furgone al meccanico e abbiamo preso
un taxi. Quando siamo tornati a riprendere il furgone non avevamo i soldi per
pagare il meccanico. Il furgone è ancora lì che aspetta in un’autorimessa in
mezzo al deserto. Una storia molto blues… mi vengono quasi le lacrime agli
occhi”.
Viaggio di nozze in Blues
(di Vito Trullo)
Mi chiamo Vito Trullo, per gli amici Vito
Situation, sono uno spaghettaro di Ginosa un paesino in provincia di Taranto, mi
diletto a cantare e suonare l’armonica in un gruppo di Taranto che fa Chicago
blues (old style), almeno ci proviamo!, la No Situation blues band. La mia
passione per il blues è nata un po’ di anni fa, quando mi sono avvicinato a
questa realtà ascoltando per caso un vecchio disco di Jimmy Reed, compratomi da
mia zia Nietta al ritorno da Chicago (la sua famiglia vive lì). Non so se questo
possa interessare a qualcuno ma … ho avvertito qualcosa e oggi, credetemi,
provare delle emozioni per così poco non è da tutti! Infatti, come dice mia
moglie, sono io che non sono tanto “a norma”!!!
Dopo questa breve presentazione, tra mille peripezie, lo scorso 30 ottobre ho
deciso di sposarmi (lo so cosa state pensando … ma non lo dite per solidarietà
di chi lo è già!) e naturalmente di farmi un bel “viaggetto” di nozze. La meta …
(fate una pausa), sembrerà strano ma io e mia moglie, di comune accordo, abbiamo
deciso che fosse la East Coast (poiché per un breve periodo facevo parte dei
“Carruba Coast Blues Band”!) degli Stati Uniti con l’aggiunta di una piccola
deviazione molto voluta dal sottoscritto: lo stato dell’Illinois o meglio la
mitica (soprannominata Second City e Windy City) città del vento: CHICAGO.
Purtroppo sono rimasto solo 3 giorni (sigh!) perché dovevo ricongiungermi con
altre persone a New York per un tour organizzato nell’est. Però ce l’ho fatta.
 Ho pensato che forse era il caso di raccontarvi un po’ di cose su questa bella
avventura, non si sa mai che qualcuno si trovi a passare da quelle parti.
Infatti, non a caso, nel mio racconto, come noterete, se non vi siete già
annoiati, ho specificato orari, voli, date, indicazioni stradali, ecc.. Ho pensato che forse era il caso di raccontarvi un po’ di cose su questa bella
avventura, non si sa mai che qualcuno si trovi a passare da quelle parti.
Infatti, non a caso, nel mio racconto, come noterete, se non vi siete già
annoiati, ho specificato orari, voli, date, indicazioni stradali, ecc..
Sono partito da Milano Malpensa il 7/11/06 alle 10:35 am e, dopo dieci ore di
volo, diretto per fortuna (AZ 626), facendo un giretto sull’Atlantico,
finalmente, siamo arrivati a Chicago; lì erano le 13:50 pm.
Appena scesi all’aeroporto O’hare International, dopo mille controlli, impronte
digitali e fotografie, sarà stato l’effetto del fuso orario o forse perché ero
fuso io, mi è sembrato di essere stato catapultato in un film, ma il bello
doveva ancora arrivare. Sembrava che fossi già stato in quel posto, forse in
un’altra vita chissà, comunque abbiamo preso un bus navetta all’uscita
dell’aeroporto con direzione albergo. Saliti sullo “Shuttle from/to airport”,
loro li chiamano così, ho capito finalmente di essere arrivato a Chicago quando
l’autista ha acceso la radio… ho avuto una lieve impressione che stesse
ascoltando qualcosa di familiare, blues, blues e solo blues. Diciamo che ho
iniziato a sintonizzarmi con il mondo circostante!
A proposito, doverosa informazione per gli spaghettari e non, che si sono appena
sintonizzati, l’albergo dove ho alloggiato si chiama “Essex Inn”, 800 South
Michigan Avenue (posizione strategica per un amante del blues); non male, nel
centro città, downtown o loop (il laccio), a downsouth (che fortuna! si narra
che il blues elettrico lo “suonavano” proprio lì!).
Infatti, non a caso dalla South Michingan Avenue si entra in una delle zone più
belle del luogo, quella del Grant Park, dove ogni anno a giugno, come tutti
sanno, penso, si svolge il Chicago Blues Festival, proprio sul Lago Michingan.
Ogni anno il festival è visto da circa 750.000 persone, quasi come le serate che
si fanno nei locali di Taranto e provincia!
L’impatto con la città è stato molto “Chicago Blues”, che v’o dico a fa! Cielo
cupo, imponenti grattacieli, giusto per citarne qualcuno che arriva ad
un'altezza di 442m, la Sears Tower, il grattacielo più alto d'America; ponti di
ferro, mi hanno detto che è la città con il maggior numero di ponti mobili al
mondo, non a caso a Taranto abbiamo il ponte girevole!(vuoi mettere?), un numero
spropositato di persone (nove milioni di individui), insomma, di tutto di più.
L’impatto si è “impattato” ancora di più quando, appena imbottigliati nel
traffico della downtown, ho avuto una visione, il gigantesco dipinto di una
donna di colore degli anni 50 (by John Carrol Doyle) che cantava su un pavimento
in legno, attaccato ad una parete di un edificio, fatto di mattoni rossi con
sotto la scritta: “Sweet home blue Chicago”, sì, era proprio il mitico locale
“Blue Chicago on Clark” (536, North Clark street, at Ohio), il fratello più
piccolo del “Blue Chicago” (736, North Clark street, at superior), un locale
dove si ascolta blues di qualità tutti giorni tranne il lunedì, dove la gente
balla davanti al palco, ai manifesti dei dipinti dei “blues musicians” di John
Carrol Doyle, alle foto storiche in bianco e nero e alla targa di via “Muddy
Waters Drive”.
Attaccato al predetto locale, c’è il “Blue Chicago Store” dove, oltre a suonare,
si possono acquistare molti oggetti carini per amanti del genere. ovete sapere
che a Chicago, per quello che ho visto e che mi hanno spiegato i chicagoans,
tutti i grandi “blues clubs” sono organizzati più o meno così, sono delle vere e
proprie mete turistiche, dove oltre ad ascoltare sicuramente del buon blues, hai
la “sana” alternativa di poter mangiare, sia pranzo che a cena, farti una buona
birra e, alla fine, di acquistare blues gadgets di ogni tipo (t-shirt, poster,
cd, portachiavi, ecc.). Anche se l’impressione che ho avuto è quella che si
siano inventati un modo legittimo per “fregarti” i dollari, mi riferisco in modo
particolare ai prezzi dei gadgets o a quello che ti danno da mangiare, vi posso
garantire che il tutto è salvato dal fatto che in questi Clubs anche l’aria che
respiri è blues, si fuma tranquillamente, giusto per fare un esempio! La cosa
strana che mi ha colpito è che costa meno il biglietto per vederti John Primer o
Lurrie Bell (da 10 a 15 dollari al massimo) che una maglietta ricordo!
I blues clubs (in una guida che ho trovato sul posto, ne ho contati almeno una
settantina) che vanno per la maggiore, oltre ai predetti, sono il Rosa’s Lounge
(3420, W. Armitage), il Buddy Guys’ Legend (754, S. Wabash), Koko Taylor’s
Celebrity (1233, S. Wabash), il B.L.U.E.S. (2519, N. Halsted) e moltissimi
altri, tutti organizzati allo stesso modo.
Io non sono riuscito a vederli tutti, ma vi posso garantire che in qualche posto
meno famoso, in particolare all’uscita di musei o dei centri commerciali e per
strada, dove mi fermavo per fare una sosta, visto che mia moglie mi ha fatto
fare in tre giorni, trecento km a piedi, ho visto il blues!
 Sono rimasto incantato, non tanto dalla tecnica e il virtuosismo che questi
“maestri di strada” possedevano, uniche qualità che noi italiani, purtroppo per
cattiva abitudine qualche volta riusciamo a notare, ma dal groove che a questa
gente gli sprizza dalla pelle, poche note ma di effetto (come dice il mio amico
Mc Carp); il loro è un continuo narrare storie, fare battute che, anche se non
riesci a capire per motivi linguistici, ne intuisci comunque il senso,
coinvolgendoti emotivamente. Sono rimasto incantato, non tanto dalla tecnica e il virtuosismo che questi
“maestri di strada” possedevano, uniche qualità che noi italiani, purtroppo per
cattiva abitudine qualche volta riusciamo a notare, ma dal groove che a questa
gente gli sprizza dalla pelle, poche note ma di effetto (come dice il mio amico
Mc Carp); il loro è un continuo narrare storie, fare battute che, anche se non
riesci a capire per motivi linguistici, ne intuisci comunque il senso,
coinvolgendoti emotivamente.
Per farvi un esempio banale, il tipo che per strada è blues e ti chiede i soldi,
usa le rime e te le canta con le famose 12 battute. Forse da noi questa è
l’unica soluzione rimasta per poter suonare fuori dai pubs visto che dentro non
ci e’ più dato farlo!
A proposito, dove eravamo rimasti? Ero appena arrivato in albergo, il tempo di
lasciare i bagagli e via sulla South Michigan Avenue.
Questa strada piena di negozi e locali, è la strada dove la maggior parte degli
abitanti va a fare shopping o si raduna nei bar (naturalmente sto parlando di
chi se lo può permettere). La zona dove alloggiavamo, downtown, è una zona
calma, per fortuna; se ci si sposta a est o ad ovest bisogna fare molta
attenzione, si rischia un po’ a causa della povertà che ancora vige in molti
quartieri.
Sulla Michigan Avenue si trova il Museum of Contemporary Photography e l’Art
Institute of Chicago che, di per sé, è sufficiente a giustificare una visita
alla città, una delle principali gallerie del mondo sull'impressionismo. Tra gli
autori più famosi si trovano opere di Amedeo “Zittano”, pardon!, Amedeo
Modigliani, Pablo Picasso, Andy Warhol ed altri artisti che io, almeno fino a
quel momento, pensavo fossero solo nomi scritti sui libri di scuola; proseguendo
verso nord c’è il Cloud Gate (che i chicagoans chiamano the Bean), vicino
all’entrata del Millenium Park, una struttura a forma di fagiolo, a specchio
deformante e l’Harris Music and Dance Theater, una struttura immensa preceduta
da un gabbia tutta in ferro ad archi che si intersecano tra loro, il Pritzker
Music Pavilion, dove in estate fanno numerosi concerti, insomma … sono capitato
in un bel punto della città dove fare il turista!
L’indomani mattina, ci siamo armati di scarpe da ginnastica, di tanta buona
volontà e abbiamo iniziato il tour degli sposini! Abbiamo fatto una salto, si fa
per dire, al The Field Museum, di fronte al grande stadio Soldier Field (dove
pochi giorni fa si è svolto il super bowl), un museo di storia naturale immenso
che per vederlo in parte ci sono volute appena quattro ore. Poi ci siamo sorbiti
la mostra su Tutankamon (King Tut) e, infine, il grandissimo acquario di John G.
Sheed.
Finito il tour turistico, ci siamo incamminati finalmente nel cuore del Loop,
dove si iniziava a respirare blues. Bastava guardarsi intorno, i cartelloni
pubblicitari della “Chess Records” con sopra Muddy Waters. A tal proposito vi
trascrivo, di seguito, qualcosa di interessante sulla Chess che ho letto sulle
guide locali.
La Chess Records occupò un edificio sulla S. Michigan Avenue (dal 1957 al 1967)
diventando un vero e proprio tempio del blues favorendo, altresì, l'affermazione
del rock and roll. Nello studio, gestito da due ebrei polacchi, i fratelli Chess,
hanno registrato Muddy Waters, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Willie Dixon, Chuck
Berry e i Rolling Stones che intitolarono una canzone alla “2120, S Michigan
Ave”. Oggi la struttura è di proprietà della “Willie Dixon's Blues Heaven
Foundation”, un ente senza fini di lucro creato dal musicista per promuovere il
blues e tutelarne l'eredità.
Basta solo guardarsi intorno per capire che c’è qualcosa di “sano” nell’aria,
ebbene sì, i negozi bombardano blues, i bar idem, i ristoranti lo stesso!
A quel punto, ho deciso di andarmi a prendere una birra al mitico blues club
“Blue Chicago” (che avevo già intravisto da dentro la navetta, vi ricordate?)
ma… purtroppo, le indicazioni che avevamo sulla mappa che ci aveva lasciato
l’Agenzia in Italia, erano molto ma molto sbagliate!!! Anche questo è blues. Ci
siamo fatti quasi tre chilometri sulla N. State Street, dovevamo arrivare al 937
partendo da 0, per poi scoprire che l’indirizzo esatto era 536, N. Clark St.,
quattro strade parallele ad ovest da dove eravamo giunti.
Ormai esausti, avevamo i piedi che fumavano, ci siamo incamminati per il ritorno
in albergo, con breve sosta in un ristorante dove ho mangiato bene, almeno il
primo, e ho speso poco, circa 10 dollari per una pietanza: il “Quartino” (ve lo
consiglio vivamente perché se un domani vorrete recarvi da queste parti,
scoprirete che trovare un posto in America dove si possa mangiare qualcosa di
“commestibile”, è come fare un terno al lotto!). almeno il
primo, e ho speso poco, circa 10 dollari per una pietanza: il “Quartino” (ve lo
consiglio vivamente perché se un domani vorrete recarvi da queste parti,
scoprirete che trovare un posto in America dove si possa mangiare qualcosa di
“commestibile”, è come fare un terno al lotto!).
Proseguendo sulla “State St.” ho intravisto, on the right, la mitica “House of
Blues (329, N. Deaborn St.)”. Il locale più “in” della città, pubblicizzato su
tutte le riviste del posto, pensate che di fronte hanno costruito anche un Hotel
di lusso con lo stesso nome. La HoB è una struttura bellissima, due piani, due
palchi, uno al primo, l’altro al secondo piano, rivestimenti in legno, quadri di
blues, uno store, … da museo insomma! Tutto un bluff, secondo me. Infatti, il
tempo di farci una birra ascoltando un artista che suonava un discreto blues
(bravo, ma che nessuno si filava) e siamo andati via, perché gli addetti ai
lavori mi hanno riferito che non potevo fare fotografie e che il concerto
successivo iniziava alle 21.00 con un gruppo che nella “casa del blues” doveva
suonare l’Hip Hop! Che sfiga! Non me ne va bene una oggi! Ho pensato.
Arrivati in albergo, prima di farmi altre maratone, ho chiesto al portiere dove
fosse un “blues club” in zona, giusto per chiudere la serata.
Sarà stato il fato ma dietro l’Essex Inn c’era proprio il mitico “Buddy Guys’
Legend”, sulla S. Wabash, dove ci sono tornato più volte, vista anche la
programmazione dei concerti che era “mostruosa” (vedi foto).
Una doccia e via, ci siamo buttati in quel tempio di “profeti” ancora in vita.
Quella sera ho avuto la fortuna di ascoltare Carl Weathersby, un chitarrista che
non conoscevo, veramente interessante. Il locale era pieno di foto storiche,
quadri blues, chitarre donate a Buddy da artisti che si erano esibiti nel suo
tempio come: John Lee Hooker, Lonnie Brooks, Eric Clapton ed altri. Insomma,
sono riuscito a fare un po’ di foto ricordo (qualcuno mi ha detto: no record,
only two photos, nei locali non è possibile fare foto e registrazioni, almeno in
quelli da me visitati), il tutto in un’atmosfera calda, tendente al blue, come
le pareti del locale.
 Mi sono quindi recato al bar per bere una birra. Al bancone era seduto su uno
sgabello il proprietario del posto! Lì per lì, sono rimasto un po’ sorpreso, sai
non ti capita tutti i giorni di farti una birra e incontrare Buddy Guy! Dopo
aver chiesto conferma al barista che si trattasse proprio di lui, mi sono
avvicinato a Buddy chiedendogli come andasse la vita. Lui, capelli a zero, molto
dimagrito, mi ha guardato (sicuramente pensando: ma chi cavolo è questo! Tipico
modo di porsi nostrano!) e mi ha ricambiato caldamente il saluto; al che, preso
coraggio, ho cercato di intraprendere una piccola conversazione con lui. Gli ho
detto che ero uno spaghettaro, facendogli capire che non facevo lo chef, ma
appartenevo al movimento di cultura blues italiano (Spaghetti & Blues), che
avevo una blues band e che ero andato a Chicago, proprio lì, per vedere uno dei
mostri sacri del blues ancora in vita; lui mi ha dato una pacca sulla spalla
dicendomi: you are very, very, crazy! you like the blues? D’istinto gli ho
risposto: Buddy, I don’t like the blues, I have the blues!. Lui è rimasto
colpito da questa mia risposta e dandomi il “cinque” mi ha detto di gioire
perché il blues mi aveva trovato. Mentre parlavamo c’era parecchia gente che
veniva a farsi autografare t-shirt, cd, ecc.. quindi non è stato molto facile
capire tutto quello che mi diceva. Dopo un po’, visto che ero di ingombro alla
gente che gli si avvicinava, mi sono allontanato. Buddy, con mio sommo stupore,
ha preso un suo cd dicendomi: this is a present for you! E’ stato per me come
ricevere lo Spirito Santo! Mi sono quindi recato al bar per bere una birra. Al bancone era seduto su uno
sgabello il proprietario del posto! Lì per lì, sono rimasto un po’ sorpreso, sai
non ti capita tutti i giorni di farti una birra e incontrare Buddy Guy! Dopo
aver chiesto conferma al barista che si trattasse proprio di lui, mi sono
avvicinato a Buddy chiedendogli come andasse la vita. Lui, capelli a zero, molto
dimagrito, mi ha guardato (sicuramente pensando: ma chi cavolo è questo! Tipico
modo di porsi nostrano!) e mi ha ricambiato caldamente il saluto; al che, preso
coraggio, ho cercato di intraprendere una piccola conversazione con lui. Gli ho
detto che ero uno spaghettaro, facendogli capire che non facevo lo chef, ma
appartenevo al movimento di cultura blues italiano (Spaghetti & Blues), che
avevo una blues band e che ero andato a Chicago, proprio lì, per vedere uno dei
mostri sacri del blues ancora in vita; lui mi ha dato una pacca sulla spalla
dicendomi: you are very, very, crazy! you like the blues? D’istinto gli ho
risposto: Buddy, I don’t like the blues, I have the blues!. Lui è rimasto
colpito da questa mia risposta e dandomi il “cinque” mi ha detto di gioire
perché il blues mi aveva trovato. Mentre parlavamo c’era parecchia gente che
veniva a farsi autografare t-shirt, cd, ecc.. quindi non è stato molto facile
capire tutto quello che mi diceva. Dopo un po’, visto che ero di ingombro alla
gente che gli si avvicinava, mi sono allontanato. Buddy, con mio sommo stupore,
ha preso un suo cd dicendomi: this is a present for you! E’ stato per me come
ricevere lo Spirito Santo!
Prima di congedarci ho fatto una foto ricordo con lui e mi sono fatto
autografare il cd con dedica anche per il mio fedele chitarrista Renato Petrelli.
Nei giorni a seguire con mia moglie abbiamo fatto un giro sul fiume Chicago (Architectural
River Cruise) per vedere tutte le bellezze architettoniche della città ma, il
tempo di scendere dal battello, siamo dovuti partire per New York.
Un viaggio davvero indimenticabile ed istruttivo alla fine del quale ho fatto ho
percepito in prima persona che il blues per i chicagoans è un modo di essere.
Vorrei che fosse lo stesso anche da noi! Fare musica, sia essa blues o altro,
non dovrebbe essere competizione ma solo un modo piacevole di stare tra “friends”,
a prescindere che sul palco o in qualsiasi posto ci sia Buddy o Vito!
Ricordiamoci sempre che “il blues non ha una casa”, ce lo insegna anche un
grande bluesman al quale una volta fu chiesto quale fosse la sua; egli rispose
più o meno così: “dove poggio il cappello, quella è casa mia...”
Buon blues a tutti!
(Dedicato al mio blues: Valeria)
Nel nome del Blues
- Paolo “Catfish” Ganz
(di Amedeo Zittano)
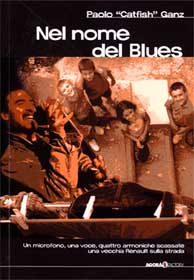 "Nel
nome del Blues" è il nuovo libro di Paolo “Catfish” Ganz edito dalla Agorà
Factory e pubblicato nel dicembre 2006. Paolo, musicista e appassionato di
letteratura (vedi archivio Interviste), dichiarava nel 2003 a S&B: “Scrivere è sempre stata
una mia grandissima passione. Ho iniziato raccogliendo delle storie di Blues,
naturalmente, cose accadute realmente, aneddoti, ricordi, pensieri. Poi, ho
ampliato la visione cominciando a raccontare di personaggi femminili,
conosciuti, romanzati o del tutto inventati. Così questo lavoro (che stando ai
miei tempi uscirà tra dieci anni), sarà una breve raccolta di racconti legati,
appunto, a caratteri di donne…”. Ed ecco, finalmente in veste editoriale,
sedici storie che hanno come sfondo le sue più curiose avventure di musicista
ambientate nella "sua" Venezia e nei dintorni. "Nel
nome del Blues" è il nuovo libro di Paolo “Catfish” Ganz edito dalla Agorà
Factory e pubblicato nel dicembre 2006. Paolo, musicista e appassionato di
letteratura (vedi archivio Interviste), dichiarava nel 2003 a S&B: “Scrivere è sempre stata
una mia grandissima passione. Ho iniziato raccogliendo delle storie di Blues,
naturalmente, cose accadute realmente, aneddoti, ricordi, pensieri. Poi, ho
ampliato la visione cominciando a raccontare di personaggi femminili,
conosciuti, romanzati o del tutto inventati. Così questo lavoro (che stando ai
miei tempi uscirà tra dieci anni), sarà una breve raccolta di racconti legati,
appunto, a caratteri di donne…”. Ed ecco, finalmente in veste editoriale,
sedici storie che hanno come sfondo le sue più curiose avventure di musicista
ambientate nella "sua" Venezia e nei dintorni.
Con grande sorpresa mi accorgo che il libro c
omincia con la stessa definizione
di Blues che Paolo ci diede nella su citata intervista. Non solo, nell’Appendice
dello stesso riporta la testimonianza che ci rilasciò per l’articolo dedicato
alla memoria di Guido Toffoletti (primo articolo pubblicato su spaghettiblues.it).
Con l’entusiasmo del piccolo discepolo di vent’anni prima, comincio la lettura.
Leggo nel poco tempo a mia disposizione e cioè la mattina presto, poco prima
dell’alba (come Paolo suggerisce nel primo volume del metodo per armonica), in
attesa del Pendolino che quotidianamente mi porta al lavoro, e poco dopo il
tramonto durante il viaggio di ritorno.
I racconti sono scritti in prima persona e vanno al di la della solita
narrativa: una sorta di viaggio che, attraverso esperienze di vita dell’autore,
percorre i meandri dell'animo umano mettendoli a nudo senza trascurare i
retrogusti a volte amari ma sicuramente veri.
“Quella con il Blues era una questione tutta mia. Anzi, una questione tra Lui
e me.”, scrive alla fine di un racconto che narra gli inizi del proprio
percorso di bluesman. Il testo è scritto in modo scorrevole ed i contenuti sono
accattivanti; "Catfish" rende ogni racconto custode di un messaggio velato
lasciando al lettore il gusto della libera interpretazione. Tra le righe si
percepisce anche l’estrema umiltà d’animo attraverso una profonda sensibilità
che sembra quasi prendersi burla della propria timidezza, svelandosi e
soprattutto confessandosi con il prossimo (il lettore), proprio come se il
“prossimo” fosse il proprio Dio (o la coscienza, per gli atei) che, con rispetto
“religioso”, ricerca continuamente il proprio Blues. Da qui il titolo “Nel nome
del Blues”.
Il libro ha incuriosito anche mia moglie che, pur non essendo patita di blues
(in verità si definisce una vittima…), lo ha trovato davvero piacevole,
interessante e in alcuni momenti... commovente. Un libro - come si dice - per tutti.
“Il Blues è quell’armonica in Sib lasciata in pegno ad una donna, che da
vent’anni rimandi di andare a riprenderti.” (PG)
Intervista a John Mayall
(realizzata da Romano Mascali - traduzione di Martina
Mascali)
 Pubblichiamo, di seguito, l'intervista a
John Mayall, celebre bluesman e polistrumentista meglio conosciuto come il
padre spirituale del "brithish blues". Pubblichiamo, di seguito, l'intervista a
John Mayall, celebre bluesman e polistrumentista meglio conosciuto come il
padre spirituale del "brithish blues".
Nonostante gli anni siano passati anche per lui (Mayall è nato nel '33!),
continua a manifestare quella grinta che ha certamente contribuito a farne quel
mito che rivedremo quest'estate su alcuni dei palchi più prestigiosi d'Italia.
Ringraziamo Radio Catania per la gentile concessione.
D. Salve John Mayall e benvenuto su Radio Catania. Lei ha suonato in tanti
posti.. in America, in Europa: qual'è il posto che lei preferisce?
R. Non c'è nessuna differenza... davvero, perchè in ogni posto in cui suoniamo tutti
vengono ad ascoltare e ad apprezzare la nostra musica... è lo stesso ovunque
andiamo.
D. John Mayall, presto lei sarà in tour in Italia e in particolare suonerà in
Sicilia, a Mascalucia in un Festival Blues dedicato ad un vulcano: l'Etna Blues
Festival. Questo le suscita un'emozione particolare?
R. Quando noi andiamo in tour suoniamo in diverse città e qualche volta in
diversi paesi ogni sera e la maggior parte delle volte quindi viaggiamo... sarà
interessante andare in Sicilia perchè non ci sono mai stato!
D. L'ultimo suo album è dedicato a Freddie King: quanto è stato importante per
la sua maturazione musicale?
R. Beh, io penso che dal punto di vista musicale tutti i maggiori musicisti come
Eric Clapton, Ron Wood, hanno sempre amato il suo stile e per me la sua voce è
stata d'ispirazione. Noi abbiamo lo stesso timbro vocale...
D. Sig. John Mayall, lei è convinto che i bluesmen contemporanei possano ancora
influenzare i giovani che si accostano per curiosità al Blues?
R. Sì sono convinto che siano grandi musicisti. Ronnie Brooks è uno dei
migliori... è ancora giovane ma nel Blues c'è sempre posto per le nuove
generazioni.
D. Lei ritiene di avere influito e, in che modo, sulla formazione musicale degli
artisti che hanno collaborato con lei come Eric Clapton, Jeff Beck e con alcuni
musicisti suoi contemporanei come Mick Jagger, Jimmy Page o Peter Green?
R. Beh... penso... noi tutti ci siamo influenzati a vicenda. Noi siamo più o meno
dello stesso periodo musicale: ci possiamo considerare come una grande famiglia
musicale che si aiuta a vicenda.
D. Lei è considerato una leggenda vivente del Blues: ma lei si ritiene una
leggenda?
R. Si... sicuro.. fino a quanto continuerò a suonare e avrò un pubblico!
Grazie John Mayall, l'aspettiamo in Sicilia il 17 luglio 2007 per il Sicilia
Blues Festival.
Chicago Blues Harp: alla
ricerca del suono perduto
(di Amedeo Zittano)
Come armonicista, sin dagli inizi, riprodurre il classico suono del Chicago
Blues è stato per me un obbiettivo tanto difficile quanto affascinante, per una
serie di motivi (non ultimo quello economico). Ho sempre avuto difficoltà ad
acquistare l’ampli valvolare dei miei sogni inoltre, come se non
 bastasse,
con il passare del tempo e l’apprendimento di vari punti di vista degli esperti
del Chicago Style, le idee mi si sono ulteriormente confuse… In passato, ogni volta
che si suonava il Chicago Blues, attaccavo il mio microfono direttamente
all’impianto tramite un vecchio pedale e lasciavo a Renato Petrelli (chitarrista
e fonico), l’onere di regolare livelli e pedale (me ne prestava uno “vintage”
per chitarra) affinché le mie note piegate rendessero al meglio l’idea del
Chicago Style… uno stratagemma sicuramente economico seppur di modesti
risultati, anche se devo ammettere che in più di un’occasione qualche musicista,
dopo il concerto, mi chiedeva dove fosse il “valvolare” e bastasse,
con il passare del tempo e l’apprendimento di vari punti di vista degli esperti
del Chicago Style, le idee mi si sono ulteriormente confuse… In passato, ogni volta
che si suonava il Chicago Blues, attaccavo il mio microfono direttamente
all’impianto tramite un vecchio pedale e lasciavo a Renato Petrelli (chitarrista
e fonico), l’onere di regolare livelli e pedale (me ne prestava uno “vintage”
per chitarra) affinché le mie note piegate rendessero al meglio l’idea del
Chicago Style… uno stratagemma sicuramente economico seppur di modesti
risultati, anche se devo ammettere che in più di un’occasione qualche musicista,
dopo il concerto, mi chiedeva dove fosse il “valvolare” e
 come riuscissi a
modulare quei suoni così “Chicago old time”. Ovviamente la mia risposta era vaga
e scaricavo a Renato la responsabilità di una risposta più tecnica. Oggi,
ovviamente, se dovessi entrare a far parte di una Chicago Blues Band non potrei
non avere un ampli valvolare anche se il mio amico Renato insiste con il volermi
prestare a tutti i costi il suo vecchio pedale per chitarra affermando la
raffinata teoria che “Pè fà ù Chicago Bluss c’è vole a sustanze no le pugnett!”,
(traduzione dal tarantino: “Per eseguire brani in stile Chicago Blues, è più
importante possedere il giusto groove, senza pensare troppo a particolari che
potrebbero rivelarsi poco importanti!”). come riuscissi a
modulare quei suoni così “Chicago old time”. Ovviamente la mia risposta era vaga
e scaricavo a Renato la responsabilità di una risposta più tecnica. Oggi,
ovviamente, se dovessi entrare a far parte di una Chicago Blues Band non potrei
non avere un ampli valvolare anche se il mio amico Renato insiste con il volermi
prestare a tutti i costi il suo vecchio pedale per chitarra affermando la
raffinata teoria che “Pè fà ù Chicago Bluss c’è vole a sustanze no le pugnett!”,
(traduzione dal tarantino: “Per eseguire brani in stile Chicago Blues, è più
importante possedere il giusto groove, senza pensare troppo a particolari che
potrebbero rivelarsi poco importanti!”).
Ad oggi sono ancora alla ricerca di un ampli come “diavolo comanda”… vintage,
moderno, customizzato o artigianale? Quesito fondamentale per chi, povero
diavolo come me, non ha molte cartucce da sparare e non può permettersi di
avventarsi in un acquisto che potrebbe risultare il meno idoneo alle proprie
esigenze. A questo proposito, ho rivolto la “classica domanda” ad alcuni noti
personaggi del mondo dell’armonica, ricchi dell’esperienza d’aver avuto
l’opportunità di provare in prima persona amplificatori e microfoni di ogni
genere, qualità e misura.
S&B: "Quali suggerimenti dareste ad un armonicista che volesse
suonare nel Chicago Blues Style utilizzando un ampli valvolare?"
Paolo Ganz (armonicista, cantante, chitarrista e scrittore):
E' una domanda complessa che richiederebbe una risposta molto articolata!
Troppo semplice elencare marche e modelli di amplificatori e microfoni: è un
campo in cui le variabili sono tante e interagiscono tra loro in maniera a volte
scoraggiante. Ci sono amplificatori valvolari nuovi di fabbrica e vintage,
alcuni nati appositamente per l'armonica e altri del tutto impossibili da
pilotare con un microfono. Anche per i microfoni vale lo stesso discorso, e in
più possono essere validi anche i semplici microfoni vocali... Il segreto
potrebbe essere - forse - quello di sperimentare, andare al negozio con la
propria armonica e provare, provare, provare. E tener conto che i Maestri non si
sono mai formalizzati troppo sulla loro attrezzatura.
Buona ricerca!
Fabio Treves (armonicista e cantante):
Rispetto a tanti anni fa adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta, ma bisogna
tener presente dove e con chi si suona. Difficile trovare il volume accoppiato
al suono giusto, soprattutto se si usano microfoni che presentano il problema
del "fischio": vero e proprio tormentone. Solitamente per l'armonica elettrica
vanno bene dei vecchi Fender: DeVille, Bassmann, Vibrolux Reverb, Super Reverb
(4 Coni), Bassmann con amplificatore per chitarra… Insomma davvero è difficile,
adesso esistono ampli di piccole dimensioni che sono anche belli tosti, ma non
sono valvolari... ognuno ha le proprie esigenze, ma ricordiamoci che il sound di
Chicago è vario, c'era little Walter, ma anche Snooky Pryior, Junior Wells e
Paul Butterfield, ed ognuno era diverso dagli altri... Sono il cuore ed il
feeling che fanno la vera differenza.... Buon Blues a te e a tutti gli amici di
Spaghetti & Blues!
Sugar Blue (armonicista e cantante):
Hi guys! My favourite amp is the Mesa Boogie Mark 1, I have used it since I
recorded "Miss You"; it has a powerful a bright sound, before that I was using
Peavey amplifiers which give a warmer sound. My advice is to try a number of
amps and choose the one the turns you on! Ciao for now, keep swingin!
Traduzione: Ciao Ragazzi! Il mio amplificatore favorito è il Mesa Boogie Mark 1,
lo uso da quando registrai “Miss You”; ha molta potenza e un suono brillante,
prima usavo amplificatori Peavey che mi davano un suono più caldo. A mio avviso
bisognerebbe provare più amplificatori per scegliere quello che fa al caso tuo!
Ciao per ora, Keep swingin!
Francesco Palombino (appassionato e collezionista di ampli e microfoni vintage
per armonica):
Vorrei innanzitutto sottolineare un aspetto che molti che cominciano a suonare
l'armonica sottovalutano. Il suono che possiamo ottenere amplificando l'armonica
dipende in gran parte dal nostro suono acustico; conosco infatti diversi bravi
armonicisti che si ritengono abbastanza soddisfatti del loro suono usando dei
comuni amplificatori Fender valvolari da 15 watt. C'è però un grande numero di
armonicisti insoddisfatti alla vana ricerca di un amplificatore ideale. Ciò che
quasi tutti cercano è quella bella saturazione che si sente nei vecchi dischi di
Little Walter o Walter Horton, così come nei dischi di armonicisti più recenti
quali Kim Wilson e Mark Hummel che hanno attinto dai grandi Maestri; è proprio
la saturazione che aumenta le possibilità espressive dell'armonica e crea quel
timbro corposo e aggressivo, tanto amato. Inoltre c'è sempre lo spinoso problema
del larsen, che non ti permette di alzare più di tanto il volume
dell'amplificatore senza che si sentano fastidiosi fischi. Per me la ricerca è
durata tanti anni, con tanti soldi buttati comprando i più svariati
amplificatori e senza ottenere nessun buon risultato; quando ormai avevo perso
ogni speranza ho scoperto il fantastico mondo di e-bay, ovvero delle aste online;
sono quindi riuscito pian piano a possedere fantastici amplificatori americani
anni 50' e 60', gli stessi che usavano i grandi Maestri del Chicago blues. Ho
finalmente trovato il suono che cercavo. Per non dilungarmi più di tanto provo a
sintetizzare: gli amplificatori per chitarra moderni non sono adatti per
l'armonica amplificata stile Chicago Blues: vanno troppo facilmente in larsen e
non permettono quindi di ottenere la saturazione. Per gli armonicisti più
esigenti ci sono quindi due possibilità:
1) Prendere un amplificatore vintage: in questo caso l'importante è che venga
revisionato da un tecnico molto esperto in moda da funzionare a dovere ed essere
sufficientemente affidabile. Spesso gli amplificatori vintage di soli 5 watt
sono quelli con il suono più bello; per esempio il famoso e piccolissimo Fender
Champ (soprattutto il vecchio modello in tweed) ha un volume tale da essere
utilizzabile anche in piccoli locali con una band al completo; quando invece si
va su amplificatori sui 15 o più watt non sempre si hanno ottimi risultati in
termini di saturazione e bisogna quindi sperimentare.
2) Prendere un amplificatore artigianale (moderno) appositamente studiato per
armonica: sono solitamente molto costosi e non rivendibili come un vintage;
offrono però un'affidabilità maggiore rispetto ai vintage grazie ai componenti
di nuova produzione.
Concludo dicendo che per il risultato finale è molto importante anche
l'abbinamento con il microfono. Sicuramente i vecchi microfoni Green Bullet ed i
vecchi Astatic hanno un suono più bello; con un buon amplificatore si possono
comunque avere buoni risultati anche con il nuovo Shure 520DX.
Federico Di Mambro (armonicista e costruttore di amplificatori per armonica):
 Io personalmente non ho trovato soddisfacente nessuno degli amplificatori
valvolari moderni che si possono trovare qui in Italia; per questo ho deciso
tanti anni fa di costruirmi da solo un amplificatore specifico per armonica; il
mio scopo era quello di ottenere il suono che si sente in alcuni dischi di
Little Walter; dopo tanti anni di sperimentazione, prendendo ispirazione da
famosi amplificatori vintage, sono riuscito ad ottenere il suono che volevo.
Pian piano anche alcuni miei amici armonicisti hanno voluto che gli costruissi
io l'ampli e di recente ho cominciato a venderli in tutta Italia. Voglio
sottolineare che i miei amplificatori sono completamente artigianali; perfino i
trasformatori sono avvolti da me. Io personalmente non ho trovato soddisfacente nessuno degli amplificatori
valvolari moderni che si possono trovare qui in Italia; per questo ho deciso
tanti anni fa di costruirmi da solo un amplificatore specifico per armonica; il
mio scopo era quello di ottenere il suono che si sente in alcuni dischi di
Little Walter; dopo tanti anni di sperimentazione, prendendo ispirazione da
famosi amplificatori vintage, sono riuscito ad ottenere il suono che volevo.
Pian piano anche alcuni miei amici armonicisti hanno voluto che gli costruissi
io l'ampli e di recente ho cominciato a venderli in tutta Italia. Voglio
sottolineare che i miei amplificatori sono completamente artigianali; perfino i
trasformatori sono avvolti da me.
Se devo dare un consiglio a chi cerca un valido amplificatore per armonica gli
direi quindi di prenderne uno vintage oppure uno specifico per armonica.
NB: il presente articolo è aperto a tutti coloro che vorranno contribuire con la
loro esperienza scrivendo a: spaghettiblues@virgilio.it
Per approfondimenti vedi anche:
www.amplificatoriperarmonica.blogspot.com
www.doctorharp.it
www.triharp.com
www.plunzspecialharp.com
100 "Grandi" Blues
(di Amedeo Zittano)
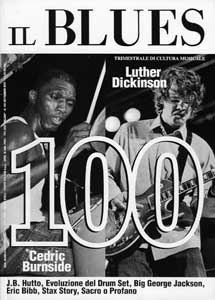 Tanti Auguri a Marino Grandi e a tutto lo Staff
della storica rivista trimestrale italiana "IL BLUES" che ha raggiunto, in
venticinque anni di attività, il fatidico n° 100. Cento numeri che racchiudono la
documentazione, decisamente accurata, di quello che nel Blues è accaduto nell'ultimo
quarto di secolo in America, in Europa e in Italia. In terza pagina Marino
ringrazia tutti, sia i lettori dal n.1 (primo abbonamento) che quelli dal n. 97
(ultimo abbonamento); lo fa a suo modo, sintetico e senza troppe menate autocommemorative puntando tutto, come sempre, sulla sostanza
di cui è
particolarmente densa la centesima pubblicazione. Tanti Auguri a Marino Grandi e a tutto lo Staff
della storica rivista trimestrale italiana "IL BLUES" che ha raggiunto, in
venticinque anni di attività, il fatidico n° 100. Cento numeri che racchiudono la
documentazione, decisamente accurata, di quello che nel Blues è accaduto nell'ultimo
quarto di secolo in America, in Europa e in Italia. In terza pagina Marino
ringrazia tutti, sia i lettori dal n.1 (primo abbonamento) che quelli dal n. 97
(ultimo abbonamento); lo fa a suo modo, sintetico e senza troppe menate autocommemorative puntando tutto, come sempre, sulla sostanza
di cui è
particolarmente densa la centesima pubblicazione.
Il primo numero della rivista nasce nel dicembre del 1982. Marino Grandi - il
Direttore - ha saputo legare in redazione l'entusiasmo e la passione di tutte
quelle persone, amanti del Blues, che hanno visto nel suo progetto l'unica valvola di
sfogo per la loro passione. In 25 anni di pubblicazioni hanno collaborato centinaia di personaggi più
o meno noti contribuendo a scrivere, nero su bianco (ancora oggi la rivista è in
bianco e nero e mantiene lo stesso format), una parte della nostra storia. IL
BLUES e il Blues godono l'uno dell'altro scambiandosi, in simbiotica passione,
Musica e Cultura. Negli anni, sempre più scrittori, musicisti e direttori
artistici, hanno potuto vantare nel loro "curriculum vitae" la prestigiosa
collaborazione con l'unica rivista italiana dedicata esclusivamente alla musica
Blues che, fungendo da laboratorio culturale, ha infettato molte anime con il virus
di
Papa Legba. Marino ha messo a confronto almeno tre generazioni di pensiero. La
linea di redazione è coerente da sempre, la si può immaginare come una
strada che si articola tra New Orleans e Chicago, tra le fangose sponde del fiume
Mississippi e le polveri industriali del lago Michigan. Una filosofia a volte "rigida",
se vogliamo, ma obbiettiva e consapevole del fatto che, se esiste una sorta di
collante del blues, questo è il rispetto dei molteplici punti di vista che solo un'attenta
analisi può svelare: sia i banali "per come" che i meno scontati
"perché".
Insomma, per chi non è ancora abbonato alla rivista, quale migliore occasione
per cominciare? Per informazioni scrivere a
info@ilbluesmagazine.it.
BASS & BLUES -
I bassisti storici del Chicago Blues
(A cura di Gianni Franchi con la collaborazione di Gaetano Moccia)
Parte prima
"My love is the blues. I play other music, but I FEEL blues. It's a spiritual
thing. It's something you get into and you feel the movement."
(Bob Stroger, 2000)
Introduzione
Quando si pensa alla musica blues il primo suono che viene in mente è quello di
un’armonica o, al limite, quello prodotto da una chitarra dobro suonata con il
bottleneck . Difficilmente si pensa al suono di un basso o contrabbasso. Eppure
oggi non esiste una buona band di blues senza un valido bassista a tenerne salde
le fondamenta. Sarà il ruolo un po’ defilato di molti bassisti, sarà la
difficoltà di udirne le frequenze in mezzo a gli altri strumenti, sarà perchè
raramente si ascolta un “solo” di basso in ambito blues, è certo comunque che
questo strumento spesso viene sottovalutato. E, con l’eccezione di Willie Dixon
di cui è stata pubblicata l’autobiografia*, non è infatti facile reperire
informazioni su quei bassisti che, suonando in tantissimi registrazioni di
blues, hanno creato uno stile e dato il loro contributo allo sviluppo di questa
musica.
Ho così pensato, per quello che potevo, di dare alcune indicazioni su alcuni
aspetti del basso e contrabbasso in ambito blues, prendendo in considerazione
alcuni bassisti, con particolare attenzione al Chicago Blues, tralasciandone,
per forza di cose, molti altri non per questo meno validi. A questo lavoro ha
collaborato Gaetano Moccia, anche egli bassista ed appassionato di blues, che ha
redatto in particolare la parte su Calvin Jones e Dave Myers, dandomi inoltre un
valido aiuto su tutto il resto.
Per alcuni artisti mi limiterò a citarne solo alcune caratteristiche, per me più
importanti, senza ripercorrere tutta la loro vita, le incisioni, le
collaborazioni, perché altrimenti occuperei il nostro sito solo per questo.
Rimando poi all’articolo apparso in questo sito “ Basso profilo” a firma di Max
Pieri che tratta anche di altri bassisti molto importanti per il genere.
Il basso, il contrabbasso ed i suoi antenati
 La funzione ritmico armonica del basso nel blues vede probabilmente le sue
origini nelle marching band di New Orleans dove tale parte era affidata al basso
tuba o al sousaphone. Essendo gruppi che si esibivano in movimento per
accompagnare feste , funerali o parate, la parte ritmica doveva essere svolta da
uno strumento a fiato trasportabile insieme alle percussioni come nelle migliori
tradizioni delle grandi marching band militari della fine dell’ottocento. Tra le
bande militari da segnalare quella di John Philip Sousa che fu anche l’inventore
del sousaphone sopra citato, ovvero una tuba da parata, più facile da
trasportare che da lui prese il nome. Tale strumento che tuttora viene
utilizzato nelle band dixie o nelle marching band di New Orleans, svolge la
stessa funzione del “nostro” basso a corde ed alcuni strumentisti di oggi, come
Kirk Joseph della Dirty Dozen Brass Band, riescono a suonarlo con grande
maestria. La funzione ritmico armonica del basso nel blues vede probabilmente le sue
origini nelle marching band di New Orleans dove tale parte era affidata al basso
tuba o al sousaphone. Essendo gruppi che si esibivano in movimento per
accompagnare feste , funerali o parate, la parte ritmica doveva essere svolta da
uno strumento a fiato trasportabile insieme alle percussioni come nelle migliori
tradizioni delle grandi marching band militari della fine dell’ottocento. Tra le
bande militari da segnalare quella di John Philip Sousa che fu anche l’inventore
del sousaphone sopra citato, ovvero una tuba da parata, più facile da
trasportare che da lui prese il nome. Tale strumento che tuttora viene
utilizzato nelle band dixie o nelle marching band di New Orleans, svolge la
stessa funzione del “nostro” basso a corde ed alcuni strumentisti di oggi, come
Kirk Joseph della Dirty Dozen Brass Band, riescono a suonarlo con grande
maestria.
Ma il modo di suonare il basso nel blues viene sicuramente influenzato, oltre
che dalle già citate brass band di New Orleans ed dalle jug band, anche dal modo
pizzicato di suonare il contrabbasso adottato nel jazz . La tecnica dei primi
contrabbassisti jazz è probabilmente derivata dalla tradizione classica infatti
,come si può notare in alcune foto dei primi del ‘900, è prevalentemente suonato
con l’archetto; pian piano però l’evoluzione tecnica di questa musica comincia a
richiedere un diverso portamento del basso. Si sviluppa quindi la tecnica
“walking” accentando ognuno dei 4 beat della misura. Per far si che il basso
potesse “camminare” i contrabbassisti cominciarono ad utilizzare la tecnica del
pizzicato. Tale tecnica, anch’essa di derivazione classica, consiste nel
pizzicare con uno o due dita le corde (generalmente con indice e medio, talvolta
anche con l’anulare). La leggenda narra che uno dei pionieri del contrabbasso
jazz, avendo rotto l’archetto durante un concerto, dovette per forza di cose
cominciare a suonare in questa maniera creando così il nuovo stile .
Tra i grandi di questa tecnica si annoverano Walter Page dell’orchestra di Count
Basie, Jimmy Blanton, Ray Brown e molti altri .
Ma il modo di suonare il basso nel blues è stato sicuramente influenzato anche
dalle parti suonate sui bassi del pianoforte soprattutto nel boogie o nello
stile jump, jive (come ad es. nei timpany Five di Louis Jordan). In tal senso
anche il modo di suonare dei chitarristi blues, con l’uso delle corde basse, ha
avuto la sua importanza. Molte linee di basso del Chicago Blues infatti sono dei
raddoppi della chitarra ritmica, tanto è vero che in molte incisioni dei primi
anni della Chess(Little Walter, Howlin’ Wolf) non c’è un bassista ma spesso due
o più chitarre di cui una che suona delle linee sulle corde basse. Spesso le
chitarre venivano accordate un ottava sotto.
Un altro antenato del nostro basso fu uno strumento molto rozzo che veniva
costruito con una cassa in legno o metallo, un manico di scopa ed una sola
corda. Willie Dixon lo chiamò, durante una intervista con Rob Wasserman, il
tin-can bass. Altre volte veniva denominato wash tub bass . In
 questo strumento
ancestrale bisognava tirare con forza la corda ( meglio usare i guanti per non
distruggersi le mani !) mentre cambiando l’angolazione del manico si cambiava
l’altezza delle note. La tinozza faceva da cassa armonica. Da questo
probabilmente deriva un modo molto ritmico di suonare il contrabbasso che viene
da alcuni chiamato lo slap (che verrà poi ripreso anche sul basso elettrico
funky) . Questa tecnica, molto usata anche nella musica popolare dei bianchi
(country,bluegrass, hillibilly), consisteva nel tirare la corda con forza verso
l’alto mentre la si pizzica creando così un effetto ritmico al suo rimbalzo
contro il manico. Tale utilizzo era molto efficace proprio quando il bassista
doveva accompagnare un solista senza l’ausilio di una batteria. Un grande
esecutore di questa tecnica, è stato Big Ernest Crawford che si può ascoltare
nelle prime incisioni di Muddy Waters per la Chess di fina anni ’40 (I can’t be
satisfied o Rollin’ and Tumblin) . Se vi appassionate a questa tecnica è
essenziale dare una occhiata ai grandi bassisti bluegrass (fanno addirittura un
“ triple slap”) ed ai contrabbassisti rockabilly che ne hanno fatto un vero e
proprio marchio di fabbrica (ne cito uno famoso: Lee Rocker ex Straycats). questo strumento
ancestrale bisognava tirare con forza la corda ( meglio usare i guanti per non
distruggersi le mani !) mentre cambiando l’angolazione del manico si cambiava
l’altezza delle note. La tinozza faceva da cassa armonica. Da questo
probabilmente deriva un modo molto ritmico di suonare il contrabbasso che viene
da alcuni chiamato lo slap (che verrà poi ripreso anche sul basso elettrico
funky) . Questa tecnica, molto usata anche nella musica popolare dei bianchi
(country,bluegrass, hillibilly), consisteva nel tirare la corda con forza verso
l’alto mentre la si pizzica creando così un effetto ritmico al suo rimbalzo
contro il manico. Tale utilizzo era molto efficace proprio quando il bassista
doveva accompagnare un solista senza l’ausilio di una batteria. Un grande
esecutore di questa tecnica, è stato Big Ernest Crawford che si può ascoltare
nelle prime incisioni di Muddy Waters per la Chess di fina anni ’40 (I can’t be
satisfied o Rollin’ and Tumblin) . Se vi appassionate a questa tecnica è
essenziale dare una occhiata ai grandi bassisti bluegrass (fanno addirittura un
“ triple slap”) ed ai contrabbassisti rockabilly che ne hanno fatto un vero e
proprio marchio di fabbrica (ne cito uno famoso: Lee Rocker ex Straycats).
Sicuramente non si può parlare di basso nel blues senza far riferimento a Willie
Dixon.
Anche lui, provenendo dal tin can bass, aveva adottato questa tecnica
adattandola al contrabbasso e perfezionandola a tal punto da crearsi uno stile
personale ed inconfondibile che lui chiamava “double slapping” . Il suo stile
consisteva praticamente nel percuotere il manico del contrabbasso mentre
“strappava” verso l’alto la corda colpendo nuovamente con il palmo della mano
per produrre un effetto ritmico molto efficace. Il primo slap era dato dalla
corda che colpiva il manico, il secondo dal palmo della mano. L’idea era quello
di avere il colpo del rullante senza avere il batterista! Senza scendere nei
dettagli della sua biografia che si può facilmente
 reperire, ricordo solamente
che, oltre ad essere compositore, talent scout, arrangiatore e produttore, il
nostro uomo ha suonato in moltissimi brani della Chess accompagnando artisti
come Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Bo Diddley, Little Walter, Sonny Boy Williamson
e molti altri. Il suo modo di suonare il contrabbasso è quindi per forza di cose
un punto di riferimento per ogni bassista che si voglia cimentare con il blues. reperire, ricordo solamente
che, oltre ad essere compositore, talent scout, arrangiatore e produttore, il
nostro uomo ha suonato in moltissimi brani della Chess accompagnando artisti
come Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Bo Diddley, Little Walter, Sonny Boy Williamson
e molti altri. Il suo modo di suonare il contrabbasso è quindi per forza di cose
un punto di riferimento per ogni bassista che si voglia cimentare con il blues.
Il suo stile, oltre alla tecnica percussiva prima descritta, era stato
sicuramente anche influenzato dal modo di suonare dei contrabbassisti jazz. In
un’intervista a “ Guitar Player”** Dixon ricorda di aver molto ammirato il modo di
suonare di Jimmy Blanton dell’orchestra di Duke Ellington anche se dichiara di
non aver mai provato a suonare come lui. Lo stesso Dixon dice invece di aver
imparato molto da musicisti come il pianista Little Brother Montgomery (suo
idolo) e Baby Doo Caston (pianista e chitarrista ) con lui nei Five Breezes e
poi nel Big Three Trio, rimasto suo amico fino alla morte. Inoltre Willie Dixon
è uno dei pochi contrabbassisti di cui si può ascoltare un assolo nei dischi
blues. Generalmente alterna slapping e grandi “camminate” che partono dalle noti
gravi per arrivare a quelle più acute.
Ultima curiosità: nel suo ultimo meraviglioso disco “Hidden charms” del 1991
Willie, avanti con l’età e con problemi gravi di diabete, non suona il
contrabbasso lasciando tale incarico ad un altro grande musicista Red Callender,
più noto in ambito jazz, che qui suona eccellentemente e in stile molto blues.
Callender, nato nel 1916, è anche un ottimo suonatore di tuba ed ha suonato con
Louis Armstrong, Lester Young, Nat King Cole ed una lista infinita di altrii
artisti.
Un altro grande contrabbassista jazz prestato al blues è Charlie Haden nel disco
“Deep in the blues” di James Cotton . E’ interessante sentire cosa dice Haden
alla rivista Bass Player riguardo questa esperienza: “Io conoscevo molto bene
James Cotton per il lavoro che aveva fatto nella band di Muddy Waters così sono
stato onorato quando il produttore John Snyder mi ha chiamato per suonare con
James e Joe Louis Walker, due maestri da cui ho imparato molto sul come suonare
il blues” (alla faccia dei jazzisti che snobbano il blues! ndr). Ma l’attenzione
dei jazzisti per il blues, anche nella sua versione più elettrificata, non può
stupirci essendo le due musiche figlie della stessa madre. Miles Davis nella sua
biografia ricorda che appena poteva andava a sentire Muddy Waters ammirando
soprattutto il grande suono della sua band.
L’avvento del basso elettrico
 Basso elettrico e contrabbasso sono comunque
gli strumenti più utilizzati
nel blues e, benchè molto simili, hanno caratteristiche “diverse” giacchè diverso
ne è il suono, l'intenzione, l'approccio e la tecnica. Entrambi hanno la stessa
intonazione, infatti il loro suono reale è un'ottava sotto a quello scritto sul
pentagramma, un'ottava sotto alle quattro corde più basse di una normale
chitarra a sei corde. Come alcuni contrabbassi, ci sono bassi elettrici a cinque
corde (alcuni addirittura a sei corde), la più grave delle quali è intonata sul
si o sul do sotto il rigo di basso. La maggior parte dei bassisti e
contrabbassisti usano uno strumento accordato in quarte (mi, la, re, sol per i
bassi a quattro corde). Pochissimi, fra tutti basti citare per il passato il
contrabbassista jazz Red Mitchell, ricorrono all'accordatura per quinte (do,
sol, re, la sempre per i bassi a quattro corde) che produce evidentemente
un'ottava più bassa. Basso elettrico e contrabbasso sono comunque
gli strumenti più utilizzati
nel blues e, benchè molto simili, hanno caratteristiche “diverse” giacchè diverso
ne è il suono, l'intenzione, l'approccio e la tecnica. Entrambi hanno la stessa
intonazione, infatti il loro suono reale è un'ottava sotto a quello scritto sul
pentagramma, un'ottava sotto alle quattro corde più basse di una normale
chitarra a sei corde. Come alcuni contrabbassi, ci sono bassi elettrici a cinque
corde (alcuni addirittura a sei corde), la più grave delle quali è intonata sul
si o sul do sotto il rigo di basso. La maggior parte dei bassisti e
contrabbassisti usano uno strumento accordato in quarte (mi, la, re, sol per i
bassi a quattro corde). Pochissimi, fra tutti basti citare per il passato il
contrabbassista jazz Red Mitchell, ricorrono all'accordatura per quinte (do,
sol, re, la sempre per i bassi a quattro corde) che produce evidentemente
un'ottava più bassa.
Nel 1951 la nascita del basso elettrico, creato da Leo Fender, cambierà anche il
sound ed il modo di suonare. Molti contrabbassisti (e chitarristi) si
convertiranno al nuovo mentre altri rimarrano fedeli al loro vecchio strumento.
Dixon ricorda, in un'intervista a Jas Obrecht su “Guitar Player” di aver
acquistato il suo primo Fender ma, non soddisfatto del suono, di averlo
immediatamente ceduto a Jack Myers. Quest'ultimo nasce nel 1937 a Memphis-
Tennessee e si trasferisce con la sua famiglia a Chicago nel 1941. E’ Earl
Hooker a 'battezzarlo' ed a chiamarlo nel 1959 per il suo primo 45 giri 'Do The Chickin'/Yea Yea' . Di lui ho pochissime altre notizie ma si può ascoltare in
molti dischi della Vanguard con Junior Wells, Earl Hooker, Buddy Guy, Walter
Horton. Il suo stile è particolarissimo perché molto diverso dagli altri bassisti, infatti le sue linee di basso sono molto elaborate con un grande uso
di  passaggi cromatici. Di lui, segnalo fra
tutti un disco: “Hoodoo man blues“ di Junior Wells. Potete vederne alcune
immagini nell’American Folk Blues Festival del 1966 dove sostituisce Willie
Dixon nella house band. passaggi cromatici. Di lui, segnalo fra
tutti un disco: “Hoodoo man blues“ di Junior Wells. Potete vederne alcune
immagini nell’American Folk Blues Festival del 1966 dove sostituisce Willie
Dixon nella house band.
Un altro bassista di grande importanza nel blues, ancora oggi in attività,
è Bob Stroger. Nato nel Sud, si trasferisce negli anni ’50 al seguito del padre
a Chicago. Proprio Stroger ricorda in una intervista pubblicata su “ Il Blues”
n. 51 che molti chitarristi che suonavano “run down”, ovvero accordati un
ottava sotto, in quegli anni passarono al basso elettrico. I vantaggi del basso
elettrico si presentarono subito evidenti: più leggero, più facilmente
suonabile soprattutto
 da
un chitarrista e con l’amplificazione adeguata aveva un suono molto più potente. Robert Stroger
ha suonato con Eddie King, Otis
Rush, col pianista Sunnyland Slim (per circa 15anni), con Jimmy Rogers, con i
Mississippi Heat, partecipando ad un'infinità di registrazioni. da
un chitarrista e con l’amplificazione adeguata aveva un suono molto più potente. Robert Stroger
ha suonato con Eddie King, Otis
Rush, col pianista Sunnyland Slim (per circa 15anni), con Jimmy Rogers, con i
Mississippi Heat, partecipando ad un'infinità di registrazioni.
Un altro tra i primi ad utilizzare a Chicago il basso elettrico fu Robert “ Big
Mojo” Elem. Anche lui nato al sud (22 gennaio 1928 ad Itta Bena, Mississippi) si
trasferisce a Chicago negli anni ’50 e forma una band in cui milita un giovane Freddie King. Per anni Elem sarà il bassista di King e di altri grandi bluesmen
come Magic Sam, Junior Wells, Shakey Jake Harris e nei ’60 con Luther Allison e Jimmy Dawkins. La sua prima esibizione, anche come cantante, si
trova nell’antologia
del 1967 per la Delmark “ Sweet home Chicago”. Il suo primo album da leader
risale al 1994 “Mojo boogie”. Grande appassionato di blues, Robert Elem deve il
suo soprannome proprio al brano “Mojo Boogie” di JB Lenoir che fu uno dei suoi
cavalli di battaglia. Continuò ad esibirsi per tutti gli anni 80 e 90 nei clubs
di Chicago, in Festival ed in qualche raro tour in Europa. Nel 1996 si esibisce
con Eddie Shaw al Chicago Blues festival. Muore il 5 febbraio 1997 a Chicago.
Calvin ‘Fuzz’ Jones
Calvin Jones nasce vicino a Greenwood, nello Stato del Mississippi, il 9 giugno
1926. Sebbene inizi a suonare l’armonica all’età di 10 o 11 anni, subito passa
alla chitarra perché, come lui stesso dice, “Non avrei potuto combinare niente
di buono con quell’armonica”.
 Appena arrivato a Chicago nel 1947 – dove prese il soprannome di Fuzz – conosce Muddy Waters. Calvin ha ricordato una volta di essere stato un giorno
letteralmente attirato come da una calamita dal suono slide tagliente di Muddy,
che stava suonando una chitarra acustica a cui era stato applicato un pick-up,
accompagnato solo da un armonicista. Dopo poco, Calvin inizia a frequentare anche Little Walter e Jimmy Rogers suonando a volte con loro
nelle varie gare di blues bands nei locali del South Side. Appena arrivato a Chicago nel 1947 – dove prese il soprannome di Fuzz – conosce Muddy Waters. Calvin ha ricordato una volta di essere stato un giorno
letteralmente attirato come da una calamita dal suono slide tagliente di Muddy,
che stava suonando una chitarra acustica a cui era stato applicato un pick-up,
accompagnato solo da un armonicista. Dopo poco, Calvin inizia a frequentare anche Little Walter e Jimmy Rogers suonando a volte con loro
nelle varie gare di blues bands nei locali del South Side.
Ebbe la fortuna di imparare a suonare la chitarra con maestri
come Freddy King, Homesick James e Jimmy Rogers.
Durante gli anni cinquanta suona con Jimmy Rogers, Junior Wells e anche
Harmonica Slim. Come leader di una propria band, Calvin Jones inizia a
concentrarsi prevalentemente sulle linee di basso della sua chitarra e, dopo che
il suo cognato gli regala un basso elettrico, gradualmente opta per suonare
esclusivamente il basso.
Ingaggiato da Howlin’ Wolf tra il 1964 e il 1965, passa un periodo a suonare
anche con Fenton Robinson finché Muddy Waters non lo chiama nel 1971 a far parte
della sua band, nella quale rimarrà come punto fermo al basso fino al maggio del
1980 quando l’intera band si separa da Muddy per motivi di ingaggio.
Verso la metà degli anni sessanta Calvin era già entrato a far parte della
scuderia della Chess Records infatti lo si può ascoltare nei brani
registrati da Muddy Waters il 18 maggio 1965: I Got A Rich Man’s Woman,
My Dog Can’t Bark, Roll Me Over Baby, Come Back Baby e Let’s Talk It Over.
Ottimo è anche il suo lavoro sui dischi Muddy, Brass & The Blues, Live At Mr.
Kelly’s e King Bee. Ma troviamo Calvin anche in brani di
Howlin’ Wolf, come Mary Sue, Hard Luck, The Big House e Tired Of Crying,
registrati il 14 luglio 1969.
Dopo l’addio dell’intera band a Muddy Waters nel maggio 1980, Calvin Jones e
Willie ‘Big Eyes’ Smith (se non la migliore, una delle migliori ed insuperabili
sezioni ritmiche della storia del Chicago blues) fondano la Legendary Blues
Band, nome che Muddy Waters dava alla sua band degli anni settanta. Infatti il
gruppo è costituito anche da altri membri della band di Muddy: Jerry Portnoy
all’armonica e Pinetop Perkins al piano. Ottimi i loro lavori: Life Of Ease (con
Louis Myers alla chitarra) e Red Hot ’n’ Blue. In questi dischi si alternano al
canto Perkins, Smith e Calvin Jones, che dimostra ottime doti anche alla voce.
Oggi Calvin Jones, alla veneranda età di 81 anni, vive a Senatobia, nel
Mississippi, e di tanto in tanto suona il basso e canta in importanti Blues
Festival nella Muddy Waters Band Veterans.
Calvin Jones è stato, ed è, uno dei migliori bassisti del classico Chicago
Blues, un maestro il cui stile asciutto, preciso e carico di groove, si adattava
alla perfezione al blues compassato, potente e profondo di gente come Howlin’
Wolf e soprattutto Muddy Waters.
Dave Myers
Dave Myers nasce il 30 ottobre 1926 a Byhalia, nello stato del Mississippi, da
Mary ed Amos Myers. Entrambi i genitori suonavano la chitarra, in particolare il
padre che si esibiva anche in feste private. Dave ha tre fratelli, tutti
musicisti: Louis (che più tardi fonderà la mitica band degli Aces), suona la
chitarra e l’armonica, Curtis il pianoforte e Bob, anche lui, l’armonica.
Dave, che con il fratello Louis canta anche nel coro della chiesa battista
della sua città, cresce ascoltando soprattutto la musica di Lonnie
 Johnson, un
pioniere della chitarra jazz e blues ed anche banjoista che viveva nel
seminterrato della casa dei Myers. Johnson, un
pioniere della chitarra jazz e blues ed anche banjoista che viveva nel
seminterrato della casa dei Myers.
Nel 1942 i due Myers si stabiliscono a Chicago e vengono subito in contatto con i
suoni più moderni della musica allora più popolare, quella delle big bands di
swing che essi ascoltavano alla radio e nei juke-boxes della città e che
cercavano di imitare con le loro chitarre. Dopo poco i due Myers conoscono
Junior Wells.
Così l'incontro con Junior Wells: una sera Louis e Dave erano a un party a
Chicago vicino alla 22a^ e Praire. Arthur 'Big Boy' Spires era lì a suonare con
Louis. Alcune ragazze li presentarono ad un armonicista, ''era molto piccolo,
dallo sguardo un pò torvo, si vedeva che se la cavava male'', diceva Dave Myers,
''Si è messo a suonare con noi, conosceva tutti i pezzi di Muddy Waters e Sonny Boy
Williamson e ci trovammo subito alla grande. La gente cominciò ad
accorrere al party, il proprietario del C & T Lounge mandò su la sua
barista a dirci che voleva ingaggiarci: fu il nostro primo lavoro in un locale,
ci chiamavamo all'inizio Three Deuces''. Poco dopo si aggiunse il batterista
Fred Below.
Tra il 1948 e il 1952 l'orchestra si esibisce in vari clubs di Chicago, fino a
quando Little Walter entrerà nella formazione di Louis Myers diventandone in
breve il vero leader. Chiamata inizialmente Little Walter & His Night Cats o His
Jukes (nome questo scelto per capitalizzare il più possibile il successo dello
strumentale Juke, inciso da Walter mentre era ancora nella band di Muddy Waters),
la band farà numerose tournee e confezionerà molti dischi all'inizio degli anni
cinquanta. Nello stesso periodo, quando mancava l'armonicista, l'orchestra
prendeva a chiamarsi solo Aces.
Secondo una tesi molto accreditata pare che sia stato proprio Dave Myers ad
introdurre letteralmente per primo il basso elettrico nella Chicago dei primi
anni cinquanta: infatti sembra che fu la stessa Fender ad ingaggiarlo per
promuovere il nuovo strumento in città.
Dopo aver lasciato il tumultuoso Little Walter, i Myers riformeranno gli Aces e
suoneranno con il batterista Odie Payne, Jr per un periodo con il grande Otis
Rush e poi con il cantante Bobby Jones e il sassofonista John Cameron.
Dal 1969 gli Aces avranno l’opportunità di accompagnare anche importanti artisti
della scena rock ‘n’ roll mondiale come Chuck Berry e Bo Diddley: storica le
loro performance al Festival di Montreux del 1972.
Dave Myers ha praticamente suonato e registrato album con centinaia di musicisti
della scena blues di Chicago. Appare in tantissimi dischi, tra cui quelli di
Jimmy Rogers, J.B. Hutto, Roosevelt Sykes, Earl Hooker, Buddy Guy; Otis Spann,
Robert Lockwood Jr. e molti altri.
Stranamente, Dave ha registrato a suo nome solo un ottimo disco, con Rusty Zinn
e Kim Wilson, nel 2000, “You Can’t Do That” per la casa discografica Black Top.
Dave Myers muore il 3 settembre 2001 all’età di 75 anni dopo una lunga malattia.
Anche ottimo cantante ed eccezionale chitarrista Dave Myers è stato senza ombra
di dubbio uno degli architetti del basso blues di Chicago; con il suo stile
versatile ben si adattava a qualunque tipo di blues, sia classico alla Muddy
Waters, sia più veloce con venature swing e jazz, e questo grazie alla sua
sensibilità musicale e al suo feeling inimitabile. L’ascolto del suo stile è un
passaggio obbligato per tutti gli aspiranti bassisti di blues.
* - Willie Dixon with Don Snowden “I am
the blues” Quartet Books Limited 1989
** - "Blues Guitar” Jas Obrecht - Miller Freman Pubblications, 1990 (raccolta di
articoli apparsi su “Guitar Player”)
Per altre informazioni sul basso blues vedi
l’articolo “Questioni di groove” su “Il Blues“ n.78 marzo 2002 di Lillo Rogati
Intervista a Robert Stroger sul n. de “Il Blues” a cura di Deitra Farr
Citazione di Charlie Haden tratta da “Bass Player” August 1996. Per maggiori
informazioni su Charlie Haden: www.charliehadenmusic,com
Ringraziamenti: Bob Margolin per la splendida foto di Calvin Jones (settembre
2007)
Altri bassisti blues fondamentali
Johnny Gayden (Albert Collins, Johnny Winter, Lucky Peterson, Junior Wells….)
Larry Fulcher (Taj Mahal, Antone’s house band)
Aaron Burton (James Cotton, Albert Collins)
Willie Kent, Joe Harper, Sylvester Boines,
Tommy Shannon (Johnny Winter, Stevie Ray Vaughan)
Preston Hubbard (Fabulous Thunderbirds, Roomful of Blues, Los Carnales) aka El
Chingòn Prez
Keith Ferguson (Fabulous Thunderbirds)
Charles Calmese (James Cotton band, Muddy Waters)
Andrew Stephens aka Stephenson (Muddy Waters anni ‘50)
Larry Taylor, Bill Stuve ,
Michael “ Mudcat” Ward
Gerald Jemmott (B. B. King)
Charles Calmese (Muddy Waters, James Cotton Band)
Bill Willis, Nick Holt, ecc. ecc.
E tutti gli altri che abbiamo dimenticato o il cui nome non è conosciuto.
Chi Siamo |
In Primo Piano |
Link |
Le Bands |
Contatti
|
Iniziative Culturali
|
Testi Blues
|
Mailing List
|
Interviste |
Concerti
|
Articoli |
Bacheca Annunci |
 sapendo
già che non sarebbe stato facile reperire i fondi necessari, ci siamo buttati a
capofitto in questa splendida avventura. Naturalmente non è stato facile far
partire l’iniziativa, circondati come eravamo da tanti dubbi e perplessità,
però…
sapendo
già che non sarebbe stato facile reperire i fondi necessari, ci siamo buttati a
capofitto in questa splendida avventura. Naturalmente non è stato facile far
partire l’iniziativa, circondati come eravamo da tanti dubbi e perplessità,
però…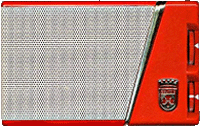 La
mia generazione è cresciuta bella e tosta, sostenuta da psichedeliche visioni e
magico entusiasmo, ma stenta a sopravvivere nel terzo millennio (un po’ come
accade per la foca monaca…). Quelli che hanno anteposto i sogni alla
concretezza, spendendo gli anni migliori senza mezze misure (ricevendo sovente
in cambio niente di più di un sano appagamento spirituale), si schiantano
inesorabilmente contro un solido muro costruito da materiali tanto resistenti
quanto poco nobili come: denaro, fama, potere. Filosofando si potrebbe dire che
per ogni muro abbattuto altre decine ne vengano eretti, ma se fino a ieri era
sufficiente assestare delle robuste picconate per demolirli, oggi non si
saprebbe che strumenti usare. Anche i pilastri portanti della società
contemporanea sembrano affondare definitivamente le speranze di una felicità
scevra da subdole convenzioni. Si, le "convenzioni" ovvero tutte quelle regole
che costruiscono il linguaggio per comunicare in un mondo sempre più omologato
ed appiattito su di esse. E’ ormai appurato che i mass media siano gli strumenti
di diffusione del “verbo universale”. Televisioni, radio e giornali, arrivano
ovunque informando e, al tempo stesso, condizionando.
La
mia generazione è cresciuta bella e tosta, sostenuta da psichedeliche visioni e
magico entusiasmo, ma stenta a sopravvivere nel terzo millennio (un po’ come
accade per la foca monaca…). Quelli che hanno anteposto i sogni alla
concretezza, spendendo gli anni migliori senza mezze misure (ricevendo sovente
in cambio niente di più di un sano appagamento spirituale), si schiantano
inesorabilmente contro un solido muro costruito da materiali tanto resistenti
quanto poco nobili come: denaro, fama, potere. Filosofando si potrebbe dire che
per ogni muro abbattuto altre decine ne vengano eretti, ma se fino a ieri era
sufficiente assestare delle robuste picconate per demolirli, oggi non si
saprebbe che strumenti usare. Anche i pilastri portanti della società
contemporanea sembrano affondare definitivamente le speranze di una felicità
scevra da subdole convenzioni. Si, le "convenzioni" ovvero tutte quelle regole
che costruiscono il linguaggio per comunicare in un mondo sempre più omologato
ed appiattito su di esse. E’ ormai appurato che i mass media siano gli strumenti
di diffusione del “verbo universale”. Televisioni, radio e giornali, arrivano
ovunque informando e, al tempo stesso, condizionando.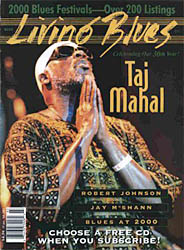 anni ’70, quando Living Blues (una rivista che aiutai a fondare insieme a Jim O’Neal,
Amy Van Singel, Bruce Inglauer, Diane Allmen, André Souffront e Tim Zorn) fu
accusata di politiche razziste per il fatto di ignorare i musicisti bianchi. La
cronista jazz Harriet Choice contestò le nostre posizioni sul Chicago Tribune ed
io fui quello che articolò la replica. La nostra posizione fu chiarita tanto in
due editoriali di Living Blues, quanto nell’introduzione alla sezione speciale
“Surrealism & Blues” (Living Blues n° 25, 1976).
anni ’70, quando Living Blues (una rivista che aiutai a fondare insieme a Jim O’Neal,
Amy Van Singel, Bruce Inglauer, Diane Allmen, André Souffront e Tim Zorn) fu
accusata di politiche razziste per il fatto di ignorare i musicisti bianchi. La
cronista jazz Harriet Choice contestò le nostre posizioni sul Chicago Tribune ed
io fui quello che articolò la replica. La nostra posizione fu chiarita tanto in
due editoriali di Living Blues, quanto nell’introduzione alla sezione speciale
“Surrealism & Blues” (Living Blues n° 25, 1976). Poiché
non si poteva ulteriormente reggere la controversia senza repliche, nel 1993
Living Blues mi chiese di riarticolare la posizione della rivista in uno
speciale editoriale inaugurato nel numero di Maggio/Giugno. In quell’articolo
resi evidente che la politica della rivista era semplicemente la manifestazione
dei suoi propositi: analizzare, registrare, recensire e celebrare la cultura
musicale Afro-Amercana negli Stati Uniti. Da questa prospettiva, rilevai che la
copertura operata dalla rivista a favore d’artisti R&B come Ruth Brown o LaVern
Baker era molto più naturale che non quella verso artisti “blues” come Stevie
Ray Vaughan. Mentre ritenevo ciò sommamente chiaro e naturale, una gran parte
dei lettori non la pensava così. Ancora una volta seguirono valanghe di lettere,
molte delle quali contro la politica editoriale ed il mio articolo. Numerosi
abbonamenti furono cancellati. “E’ la musica, stupido” scrisse un lettore di
vecchia data. Torneremo su questa frase più avanti, fatemi provare, ancora una
volta, ad analizzare la questione che ha innescato la controversia.
Poiché
non si poteva ulteriormente reggere la controversia senza repliche, nel 1993
Living Blues mi chiese di riarticolare la posizione della rivista in uno
speciale editoriale inaugurato nel numero di Maggio/Giugno. In quell’articolo
resi evidente che la politica della rivista era semplicemente la manifestazione
dei suoi propositi: analizzare, registrare, recensire e celebrare la cultura
musicale Afro-Amercana negli Stati Uniti. Da questa prospettiva, rilevai che la
copertura operata dalla rivista a favore d’artisti R&B come Ruth Brown o LaVern
Baker era molto più naturale che non quella verso artisti “blues” come Stevie
Ray Vaughan. Mentre ritenevo ciò sommamente chiaro e naturale, una gran parte
dei lettori non la pensava così. Ancora una volta seguirono valanghe di lettere,
molte delle quali contro la politica editoriale ed il mio articolo. Numerosi
abbonamenti furono cancellati. “E’ la musica, stupido” scrisse un lettore di
vecchia data. Torneremo su questa frase più avanti, fatemi provare, ancora una
volta, ad analizzare la questione che ha innescato la controversia.  punto di vista strettamente tecnico. Né il patrimonio genetico né le differenti
esperienze di razza sembrano incidere sulla capacità di formare certi accordi,
suonare certe melodie o progressioni (tenete conto che ammettere per i bianchi
la possibilità di suonare, fisicamente, il blues significa anche inserire la
"sofferenza" come sua parte integrante o lasciarla in una dimensione
metafisica).
punto di vista strettamente tecnico. Né il patrimonio genetico né le differenti
esperienze di razza sembrano incidere sulla capacità di formare certi accordi,
suonare certe melodie o progressioni (tenete conto che ammettere per i bianchi
la possibilità di suonare, fisicamente, il blues significa anche inserire la
"sofferenza" come sua parte integrante o lasciarla in una dimensione
metafisica). L’intera
questione è spostata sul feeling con cui si canta o s’interpreta la musica.
Prendiamo in considerazione l’opinione di J. B. Lenoir secondo cui non si
potrebbe cantare il blues a meno che uno non sia “blued”. Mentre l’idea in sè
sembra condivisa dalla maggior parte dei commentatori, resta un fatto complesso
accordarsi su come quantificare o misurare il livello in cui un musicista sia “blued”.
L’assioma secondo il quale "se dovete domandare, non saprete mai", non consente
scappatoie, poiché ognuno è disposto a concedere le qualità “soulful” e
“feeling” solo a quegli interpreti
L’intera
questione è spostata sul feeling con cui si canta o s’interpreta la musica.
Prendiamo in considerazione l’opinione di J. B. Lenoir secondo cui non si
potrebbe cantare il blues a meno che uno non sia “blued”. Mentre l’idea in sè
sembra condivisa dalla maggior parte dei commentatori, resta un fatto complesso
accordarsi su come quantificare o misurare il livello in cui un musicista sia “blued”.
L’assioma secondo il quale "se dovete domandare, non saprete mai", non consente
scappatoie, poiché ognuno è disposto a concedere le qualità “soulful” e
“feeling” solo a quegli interpreti che più apprezza, indipendentemente dalla razza, dall’esperienza e – pur
acquisita la verità - indipendentemente dal feeling (qualunque cosa si comunichi
all'ascoltatore).
che più apprezza, indipendentemente dalla razza, dall’esperienza e – pur
acquisita la verità - indipendentemente dal feeling (qualunque cosa si comunichi
all'ascoltatore). con
i Grammy Awards e decide dei loro destini (per quanto sia possibile fare ciò).
In definitiva questo è un problema dell'establishment critico-musicale ed il
fatto che esso sia costituito da bianchi è molto importante. I critici musicali
di colore hanno altra carne da cuocere, preferendo concentrarsi sul rap e su
artisti maggiormente popolari. Tuttavia varrebbe la pena sapere le loro
posizioni su questi argomenti, non possiamo dare per scontato il fatto che
critici e musicisti blues neri abbiano le stesse opinioni. Infatti, i motivi per
cui gli artisti blues di colore non obiettano agli esecutori bianchi è questione
lontana dalla tolleranza. Per gli artisti blues neri, l'esistenza d’esecutori
bianchi li conduce spesso a più cospicui successi di vendite. Come Phil Rubio
stesso ha notato, Aretha Franklin deve alla partecipazione al film “The Blues
Brothers” la rivitalizzazione della sua carriera. Con effetti anche da un punto
di vista commerciale. Contestiamo le condizioni razziste che hanno reso
possibile ciò, ma non il suo verificarsi. Altrettanto sintomatico è il caso di
Bonnie Raitt, che ha reso John Lee Hooker un fantastico fenomeno da hit parade,
e non vice versa (sebbene al tempo della loro joint venture, Hooker fosse già
incredibilmente popolare per un artista blues).
con
i Grammy Awards e decide dei loro destini (per quanto sia possibile fare ciò).
In definitiva questo è un problema dell'establishment critico-musicale ed il
fatto che esso sia costituito da bianchi è molto importante. I critici musicali
di colore hanno altra carne da cuocere, preferendo concentrarsi sul rap e su
artisti maggiormente popolari. Tuttavia varrebbe la pena sapere le loro
posizioni su questi argomenti, non possiamo dare per scontato il fatto che
critici e musicisti blues neri abbiano le stesse opinioni. Infatti, i motivi per
cui gli artisti blues di colore non obiettano agli esecutori bianchi è questione
lontana dalla tolleranza. Per gli artisti blues neri, l'esistenza d’esecutori
bianchi li conduce spesso a più cospicui successi di vendite. Come Phil Rubio
stesso ha notato, Aretha Franklin deve alla partecipazione al film “The Blues
Brothers” la rivitalizzazione della sua carriera. Con effetti anche da un punto
di vista commerciale. Contestiamo le condizioni razziste che hanno reso
possibile ciò, ma non il suo verificarsi. Altrettanto sintomatico è il caso di
Bonnie Raitt, che ha reso John Lee Hooker un fantastico fenomeno da hit parade,
e non vice versa (sebbene al tempo della loro joint venture, Hooker fosse già
incredibilmente popolare per un artista blues). ampiamente complesso del mero "suono". D’altronde, se "il suono" fosse realmente
tutto, esso vivrebbe per se stesso. Nessuno andrebbe alle performance live, ai
concerti o nei club. I fan del rock non guarderebbero MTV (l’ascolterebbero
solamente). I musicisti non presterebbero attenzione ai costumi, alle luci, alla
presenza scenica, ecc. Si preferirebbe solamente pensare che "la musica sia
tutto quello che conta".
ampiamente complesso del mero "suono". D’altronde, se "il suono" fosse realmente
tutto, esso vivrebbe per se stesso. Nessuno andrebbe alle performance live, ai
concerti o nei club. I fan del rock non guarderebbero MTV (l’ascolterebbero
solamente). I musicisti non presterebbero attenzione ai costumi, alle luci, alla
presenza scenica, ecc. Si preferirebbe solamente pensare che "la musica sia
tutto quello che conta". Mississippi
clean", ed il “bianco” Elvis Presley canta le medesime liriche dello stesso
brano? Difficilmente! Analizzando la frase "across the Mississippi clean", essa
ha un’insieme di significati quando è cantata da un nero, significati che non
esistono per un esecutore bianco. Gli ascoltatori di varie razze devono
ascoltarlo e identificarlo in maniera differente, basandosi sulla loro
esperienza... e sulla loro interpretazione dell'esperienza del cantante. Il
punto focale dell’identificazione è molto importante proprio per questa ragione.
Una ragione di cui ”Blues and the Poetic Spirit” ha dimostrato i palesi aspetti
psicologici nel fenomeno dei numerosi bianchi che ripetono a pappagallo
l’atteggiamento dei performer neri. Il risultato di ciò è l’illusoria percezione
di guadagno in termini di machismo e maturità. Troppo spesso questo ha portato
sulla bocca d’adolescenti (bianchi) improbabili parole d’uomini (neri), parole
che appaiono frivole ed occasionalmente offensive senza il loro originale
fondamento. Secondo Rubio, questa tendenza è stata derisa anche da Frank Zappa
in un titolo del 1981, "You Are What You Is”.
Mississippi
clean", ed il “bianco” Elvis Presley canta le medesime liriche dello stesso
brano? Difficilmente! Analizzando la frase "across the Mississippi clean", essa
ha un’insieme di significati quando è cantata da un nero, significati che non
esistono per un esecutore bianco. Gli ascoltatori di varie razze devono
ascoltarlo e identificarlo in maniera differente, basandosi sulla loro
esperienza... e sulla loro interpretazione dell'esperienza del cantante. Il
punto focale dell’identificazione è molto importante proprio per questa ragione.
Una ragione di cui ”Blues and the Poetic Spirit” ha dimostrato i palesi aspetti
psicologici nel fenomeno dei numerosi bianchi che ripetono a pappagallo
l’atteggiamento dei performer neri. Il risultato di ciò è l’illusoria percezione
di guadagno in termini di machismo e maturità. Troppo spesso questo ha portato
sulla bocca d’adolescenti (bianchi) improbabili parole d’uomini (neri), parole
che appaiono frivole ed occasionalmente offensive senza il loro originale
fondamento. Secondo Rubio, questa tendenza è stata derisa anche da Frank Zappa
in un titolo del 1981, "You Are What You Is”. Questo è un
articolo triste, ma la partenza di quello che può essere considerato uno
dei maggiori armonicisti blues italiani, non può e non deve passare inosservata.
Personalmente non ho mai conosciuto Dadà, ma molte cose mi univano
spiritualmente a lui. Amava il blues come me, suonava l’armonica molto meglio di
me, era autodidatta come me, vestiva solitamente di nero come me quando si
esibiva in pubblico, aveva i capelli corti e brizzolati come i miei, una
corporatura abbastanza somigliante alla mia (nelle foto che ho potuto vedere), e
viveva a Ferrara, una città che porto nel cuore perché ci ho vissuto la mia
infanzia e parte della mia adolescenza. Il destino ha voluto che Dadà non
leggerà mai questo articolo. E probabilmente neanche le persone a lui più
vicine. Mai lo sentirò, neanche al telefono. Ma ci ritroveremo un giorno, con le
nostre armoniche, da qualche parte, forse all’inferno, e mi farò dare qualche
dritta sullo strumento. Magari gratis.
Questo è un
articolo triste, ma la partenza di quello che può essere considerato uno
dei maggiori armonicisti blues italiani, non può e non deve passare inosservata.
Personalmente non ho mai conosciuto Dadà, ma molte cose mi univano
spiritualmente a lui. Amava il blues come me, suonava l’armonica molto meglio di
me, era autodidatta come me, vestiva solitamente di nero come me quando si
esibiva in pubblico, aveva i capelli corti e brizzolati come i miei, una
corporatura abbastanza somigliante alla mia (nelle foto che ho potuto vedere), e
viveva a Ferrara, una città che porto nel cuore perché ci ho vissuto la mia
infanzia e parte della mia adolescenza. Il destino ha voluto che Dadà non
leggerà mai questo articolo. E probabilmente neanche le persone a lui più
vicine. Mai lo sentirò, neanche al telefono. Ma ci ritroveremo un giorno, con le
nostre armoniche, da qualche parte, forse all’inferno, e mi farò dare qualche
dritta sullo strumento. Magari gratis. Per
circa tre mesi ho provato a completare questo articolo. A forza di rimandarlo
avevo quasi deciso di lasciar perdere. Troppo impegnativo. Pensate, mi ero messo
in testa di documentarvi come uno strumento piccolo di dimensioni non
appartenesse solo al blues e dintorni ma che molteplici sono stati i musicisti
di musica pop e altro a noleggiare "soffiatori" di armonica come ospiti nei loro
dischi. Contro ogni previsione, mi sono addentrato nell’argomento, e… mi sono
perso. Mi ritroverò? Bo’!!! Ho effettuato una ricerca su quali siano stati i
soffiatori pallidi a prestare l’armonica diatonica o cromatica dal 1970 al 2004
o, comunque, chi abbia dato spazio a questo strumento nelle proprie incisioni:
le sorprese non mancano!
Per
circa tre mesi ho provato a completare questo articolo. A forza di rimandarlo
avevo quasi deciso di lasciar perdere. Troppo impegnativo. Pensate, mi ero messo
in testa di documentarvi come uno strumento piccolo di dimensioni non
appartenesse solo al blues e dintorni ma che molteplici sono stati i musicisti
di musica pop e altro a noleggiare "soffiatori" di armonica come ospiti nei loro
dischi. Contro ogni previsione, mi sono addentrato nell’argomento, e… mi sono
perso. Mi ritroverò? Bo’!!! Ho effettuato una ricerca su quali siano stati i
soffiatori pallidi a prestare l’armonica diatonica o cromatica dal 1970 al 2004
o, comunque, chi abbia dato spazio a questo strumento nelle proprie incisioni:
le sorprese non mancano!  31.
Queste accoppiate fanno bene alle coronarie. E non finisce qui. In ordine
sparso, vi ricordo che Fabrizio De Andrè chiamò Andy Forest per inserire
l’armonica nel brano “Quello che non ho” (un pezzo colorato di rock/blues)
contenuto nel disco “Fabrizio De Andre” del 1981. L’armonicista siciliano
Giuseppe Milici che suona la cromatica nella sigla TV “Avvocato Porta” oltre ad
aver reinciso “Il cielo in una stanza” sul cd di Gino Paoli e registrato il
brano “Dormi” nel cd dei Dirotta su Cuba. A proposito, vi ricordate a Sanremo
quando sul brano "E andata cosi’ " comparve il Divino Toots Thielemans? Altro
armonicista cromatico/diatonico di grande spessore è Angelo Adamo. Ha spesso
collaborato ed inciso con Gianni Morandi e diverse volte lo si è visto in
televisione proprio con l’autore di “Fatti mandare dalla mamma a prendere la
gazzosa” (...ho sbagliato bevanda?).
31.
Queste accoppiate fanno bene alle coronarie. E non finisce qui. In ordine
sparso, vi ricordo che Fabrizio De Andrè chiamò Andy Forest per inserire
l’armonica nel brano “Quello che non ho” (un pezzo colorato di rock/blues)
contenuto nel disco “Fabrizio De Andre” del 1981. L’armonicista siciliano
Giuseppe Milici che suona la cromatica nella sigla TV “Avvocato Porta” oltre ad
aver reinciso “Il cielo in una stanza” sul cd di Gino Paoli e registrato il
brano “Dormi” nel cd dei Dirotta su Cuba. A proposito, vi ricordate a Sanremo
quando sul brano "E andata cosi’ " comparve il Divino Toots Thielemans? Altro
armonicista cromatico/diatonico di grande spessore è Angelo Adamo. Ha spesso
collaborato ed inciso con Gianni Morandi e diverse volte lo si è visto in
televisione proprio con l’autore di “Fatti mandare dalla mamma a prendere la
gazzosa” (...ho sbagliato bevanda?).  Tra le tante novità relative alla “stagione dei festival” di quest’anno, quello
che più mi ha sorpreso e incuriosito è il Pistoia Blues, in particolare come si
è evoluto il progetto BluesIn. La Direzione Artistica ha dato concretezza alla
risposta di chiusura al dibattito dell’anno scorso (collegamento ad archivio)
dove, accettando il costruttivo confronto, si impegnava a tener conto dei nostri
punti di vista nelle edizioni future, e così è stato.
Tra le tante novità relative alla “stagione dei festival” di quest’anno, quello
che più mi ha sorpreso e incuriosito è il Pistoia Blues, in particolare come si
è evoluto il progetto BluesIn. La Direzione Artistica ha dato concretezza alla
risposta di chiusura al dibattito dell’anno scorso (collegamento ad archivio)
dove, accettando il costruttivo confronto, si impegnava a tener conto dei nostri
punti di vista nelle edizioni future, e così è stato.  (Halley, Arkansas, 1898 – Memphis, Tennessee, 1974)
(Halley, Arkansas, 1898 – Memphis, Tennessee, 1974) William James Dixon è stata, senza ombra di dubbio, una delle personalità più
vive nella storia del blues e della musica popolare americana. Cantante dalla
voce grassa e baritonale, bassista eclettico, autore scintillante di songs
seminali, talent scout e produttore di grandi bluesmen dagli anni ‘40 fino a
tutti gli anni ’80.
William James Dixon è stata, senza ombra di dubbio, una delle personalità più
vive nella storia del blues e della musica popolare americana. Cantante dalla
voce grassa e baritonale, bassista eclettico, autore scintillante di songs
seminali, talent scout e produttore di grandi bluesmen dagli anni ‘40 fino a
tutti gli anni ’80. Soprannominato dal padre “Duck” a seguito della sua passione per Paperino,
Donald Dunn è membro della Rock'n'Roll Hall Of Fame con i Booker T. & The MGs.
Questa mitica band, fondata insieme all’amico d’infanzia Steve Cropper, è
titolare di numerosi hits strumentali degli anni ’60 come "Green Onions”, “Hang
'Em High” e “Time Is Tight”. Ma con Booker T. & The MGs Donald Duck ha
contribuito, soprattutto, a definere – insieme ai Memphis Horns – i contorni di
uno dei più caratteristici e duraturi sound nella musica popolare americana: lo
Stax Sound. La leggendaria Soul e Rythm'n'Blues label non sarebbe stata la
stessa senza il bassismo vibrante e carnoso di Dunn. Fra le registrazioni senza
tempo cui egli ha partecipato ricordiamo “Respect”, “Dock Of The Bay” e “I've
Been Loving You Too Long” di Otis Redding, “In The Midnight Hour” di Wilson
Pickett, “Hold On I'm Coming” di Sam and Dave. Tutti brani che hanno lasciato un
segno indelebile nella storia della cultura musicale non solo americana.
Innumerevoli sono state ancora le collaborazioni e le session che egli può
vantare, avendo lavorato per artisti come Isaac Hayes, Jerry Lee Lewis, Muddy
Waters, Albert King, Freddie King, Bill Withers, Rod Stewart, Joan Baez, Richie
Havens, Roy Buchanan, Diana Ross, Manhattan Transfer, Bob Dylan, Tom Petty & The
Heartbreakers, John Fogerty, Neil Young, Eric Clapton, ecc..
Soprannominato dal padre “Duck” a seguito della sua passione per Paperino,
Donald Dunn è membro della Rock'n'Roll Hall Of Fame con i Booker T. & The MGs.
Questa mitica band, fondata insieme all’amico d’infanzia Steve Cropper, è
titolare di numerosi hits strumentali degli anni ’60 come "Green Onions”, “Hang
'Em High” e “Time Is Tight”. Ma con Booker T. & The MGs Donald Duck ha
contribuito, soprattutto, a definere – insieme ai Memphis Horns – i contorni di
uno dei più caratteristici e duraturi sound nella musica popolare americana: lo
Stax Sound. La leggendaria Soul e Rythm'n'Blues label non sarebbe stata la
stessa senza il bassismo vibrante e carnoso di Dunn. Fra le registrazioni senza
tempo cui egli ha partecipato ricordiamo “Respect”, “Dock Of The Bay” e “I've
Been Loving You Too Long” di Otis Redding, “In The Midnight Hour” di Wilson
Pickett, “Hold On I'm Coming” di Sam and Dave. Tutti brani che hanno lasciato un
segno indelebile nella storia della cultura musicale non solo americana.
Innumerevoli sono state ancora le collaborazioni e le session che egli può
vantare, avendo lavorato per artisti come Isaac Hayes, Jerry Lee Lewis, Muddy
Waters, Albert King, Freddie King, Bill Withers, Rod Stewart, Joan Baez, Richie
Havens, Roy Buchanan, Diana Ross, Manhattan Transfer, Bob Dylan, Tom Petty & The
Heartbreakers, John Fogerty, Neil Young, Eric Clapton, ecc.. James Jamerson ha contribuito a modificare in maniera irrimediabile il suono
della musica contemporanea. Stabilitosi a Detroit nel 1954, nonostante
un‘infanzia piuttosto travagliata, ha potuto godere della levità della musica
per la quale nutrì, da subito, una grande passione. Inizia a suonare molto
giovane il contrabbasso, esibendosi subito in ambito jazzistico. Tuttavia, alla
prima visita presso gli studi Motown, imbraccia il basso elettrico senza
lasciarlo più. Nei primi ’60, si unisce a Earl Van Dyke, Robert White, Benny
Benjamin e Joe Messina nel famigerato team dello Studio A, i Funk Brothers.
Questo quintetto leggendario ha costituito l’ossatura portante del Motown Sound.
Ascoltando successi come "Dancing in the street”, "What's Going On", “My Girl”,
“I Was Made To Love Her” o "Boogie Fever" si è involontariamente spinti al
movimento dai vibranti grooves suonati da James Jamerson. Egli è stato il primo
virtuoso del basso elettrico, dando voce allo strumento e introducendo la
sincope musicale o, in termini più laici, il funk.
James Jamerson ha contribuito a modificare in maniera irrimediabile il suono
della musica contemporanea. Stabilitosi a Detroit nel 1954, nonostante
un‘infanzia piuttosto travagliata, ha potuto godere della levità della musica
per la quale nutrì, da subito, una grande passione. Inizia a suonare molto
giovane il contrabbasso, esibendosi subito in ambito jazzistico. Tuttavia, alla
prima visita presso gli studi Motown, imbraccia il basso elettrico senza
lasciarlo più. Nei primi ’60, si unisce a Earl Van Dyke, Robert White, Benny
Benjamin e Joe Messina nel famigerato team dello Studio A, i Funk Brothers.
Questo quintetto leggendario ha costituito l’ossatura portante del Motown Sound.
Ascoltando successi come "Dancing in the street”, "What's Going On", “My Girl”,
“I Was Made To Love Her” o "Boogie Fever" si è involontariamente spinti al
movimento dai vibranti grooves suonati da James Jamerson. Egli è stato il primo
virtuoso del basso elettrico, dando voce allo strumento e introducendo la
sincope musicale o, in termini più laici, il funk. L’avventura musicale di Mark Sandman si sviluppa lontano dal blues in senso
stretto. Egli è stato, infatti, un musicista che, partendo come chitarrista dal
natio Massachusetts, ha attraversato la stagione rock americana degli anni ’80
in diverse formazioni minori: Treat Her Right, Hipnosonics, Pale Bros., Super
Group, Candy Bar, Treat Her Orange. Tutte band che hanno lasciato tracce
discografiche con il suo contributo di luminoso songster.
L’avventura musicale di Mark Sandman si sviluppa lontano dal blues in senso
stretto. Egli è stato, infatti, un musicista che, partendo come chitarrista dal
natio Massachusetts, ha attraversato la stagione rock americana degli anni ’80
in diverse formazioni minori: Treat Her Right, Hipnosonics, Pale Bros., Super
Group, Candy Bar, Treat Her Orange. Tutte band che hanno lasciato tracce
discografiche con il suo contributo di luminoso songster. Tommy Shannon ha attraversato l’intera storia del rock blues dagli anni ’60 fino
ad oggi. Dopo il suo trasferimento da Tucson a Dallas suona nei New Breed, soul
band in cui milita Uncle John Turner, brillante batterista e amico d’infanzia di
Johnny Winter. Quando nel ’68 Uncle John lasciò i New Breed per unirsi a Winter
chiamò con sè anche Shannon, costituendo l’ossatura del seminale trio
Progressive Blues Experiment. Il management Columbia liquidò, tuttavia, la
sezione ritmica della band dopo un paio d’anni e Shannon andò incontro a una
drammatica crisi personale. L’abuso di droghe e la frequenza di ambienti
criminosi lo trascinarono in carcere e in diversi centri per tossicodipendenti.
Il mondo musicale si dimenticò a lungo di lui prima che potesse ritornare al
seguito di Rocky Hill (fratello di Dusty degli ZZ Top).
Tommy Shannon ha attraversato l’intera storia del rock blues dagli anni ’60 fino
ad oggi. Dopo il suo trasferimento da Tucson a Dallas suona nei New Breed, soul
band in cui milita Uncle John Turner, brillante batterista e amico d’infanzia di
Johnny Winter. Quando nel ’68 Uncle John lasciò i New Breed per unirsi a Winter
chiamò con sè anche Shannon, costituendo l’ossatura del seminale trio
Progressive Blues Experiment. Il management Columbia liquidò, tuttavia, la
sezione ritmica della band dopo un paio d’anni e Shannon andò incontro a una
drammatica crisi personale. L’abuso di droghe e la frequenza di ambienti
criminosi lo trascinarono in carcere e in diversi centri per tossicodipendenti.
Il mondo musicale si dimenticò a lungo di lui prima che potesse ritornare al
seguito di Rocky Hill (fratello di Dusty degli ZZ Top). Robert Stroger è uno tra i più leggendari bassisti ancora oggi attivi.
Trasferitosi nel West Side di Chicago nel 1955, vivendo in un appartamento alle
spalle di un club ove le basse frequenze delle band di Howling Wolf e Muddy
Waters facevano tremare le pareti, egli comprese cosa sarebbe voluto diventare
nella vita: un bassista di blues.
Robert Stroger è uno tra i più leggendari bassisti ancora oggi attivi.
Trasferitosi nel West Side di Chicago nel 1955, vivendo in un appartamento alle
spalle di un club ove le basse frequenze delle band di Howling Wolf e Muddy
Waters facevano tremare le pareti, egli comprese cosa sarebbe voluto diventare
nella vita: un bassista di blues. Larry “The Mole” Taylor è cresciuto in una famiglia ove la musica non mancava
mai d’accompagnare le giornate. Il padre, il nonno e gli zii suonavano tutti la
chitarra o il banjo. Il fratello maggiore Mel - batterista nei mitici Ventures -
era già un professionista quando il giovane Larry cominciò a considerare la
musica parte integrante della sua vita. Diffusamente conosciuto come il bassista
della seminale band dei Canned Heat, Larry Taylor ha avuto, in realtà, una lunga
e variegata carriera. Dopo un’esperienza in tour con Jerry Lee Lewis, appena
diciottenne, diventò musicista residente in molte sessioni di studio dei Monkees.
La parentesi Canned Heat lo vede attivo nel periodo migliore (1967-70), quando
la band della West Coast era considerata pioniera di certo blues bianco, non
rigidamente aderente agli stilemi del blues classico. Successivamente, Larry
Taylor entrò nella prima backing band tutta statunitense di John Mayall,
partecipando alle registrazioni di “USA Union” e di altri album “americani” del
bluesman britannico.
Larry “The Mole” Taylor è cresciuto in una famiglia ove la musica non mancava
mai d’accompagnare le giornate. Il padre, il nonno e gli zii suonavano tutti la
chitarra o il banjo. Il fratello maggiore Mel - batterista nei mitici Ventures -
era già un professionista quando il giovane Larry cominciò a considerare la
musica parte integrante della sua vita. Diffusamente conosciuto come il bassista
della seminale band dei Canned Heat, Larry Taylor ha avuto, in realtà, una lunga
e variegata carriera. Dopo un’esperienza in tour con Jerry Lee Lewis, appena
diciottenne, diventò musicista residente in molte sessioni di studio dei Monkees.
La parentesi Canned Heat lo vede attivo nel periodo migliore (1967-70), quando
la band della West Coast era considerata pioniera di certo blues bianco, non
rigidamente aderente agli stilemi del blues classico. Successivamente, Larry
Taylor entrò nella prima backing band tutta statunitense di John Mayall,
partecipando alle registrazioni di “USA Union” e di altri album “americani” del
bluesman britannico. riappropriato del tempo libero, dedicandolo all’ascolto
approfondito della produzione musicale degli ultimi 40/50 anni.
riappropriato del tempo libero, dedicandolo all’ascolto
approfondito della produzione musicale degli ultimi 40/50 anni. cominciavano a riaffiorare ed a scorrere
come veloci flashback, in mezzo ad album ed etichette storiche suonati da band
leggendarie, ho trovato una raccolta di cui avevo completamente perso la
memoria. Era una scatola delle dimensioni di un LP, alta un paio di centimetri,
che conteneva tre dischi con etichetta “Albatros” ed un opuscolo esplicativo di
28 pagine il tutto curato da Alessandro ROFFENI. Sulla copertina di carta di un
disco era annotato: “dicembre 1980 Selezione £.5.000”. Era un’offerta natalizia
di Selezione del Reader’s Digest che acquistai più che altro per la
documentazione storica, spinto sopratutto dal fatto che l’intero cofanetto
costava grossomodo molto meno di un singolo LP dell’epoca. Ricordo che ricevuto
il pacchetto sfogliai appena l’opuscolo, per vedere le foto all’interno ed ascoltai tre o quattro brani tanto per avere un’idea di cosa avevo acquistato.
Il cofanetto in questione è una raccolta di 48 canzoni che vanno dal 1926 al
1939 con l’unica eccezione un brano datato 1956 cantato da Furry LEWIS. Questi
dischi sono divisi per Blues Rurale, Urbano e Jazzistico e sono eseguiti da
artisti a me
cominciavano a riaffiorare ed a scorrere
come veloci flashback, in mezzo ad album ed etichette storiche suonati da band
leggendarie, ho trovato una raccolta di cui avevo completamente perso la
memoria. Era una scatola delle dimensioni di un LP, alta un paio di centimetri,
che conteneva tre dischi con etichetta “Albatros” ed un opuscolo esplicativo di
28 pagine il tutto curato da Alessandro ROFFENI. Sulla copertina di carta di un
disco era annotato: “dicembre 1980 Selezione £.5.000”. Era un’offerta natalizia
di Selezione del Reader’s Digest che acquistai più che altro per la
documentazione storica, spinto sopratutto dal fatto che l’intero cofanetto
costava grossomodo molto meno di un singolo LP dell’epoca. Ricordo che ricevuto
il pacchetto sfogliai appena l’opuscolo, per vedere le foto all’interno ed ascoltai tre o quattro brani tanto per avere un’idea di cosa avevo acquistato.
Il cofanetto in questione è una raccolta di 48 canzoni che vanno dal 1926 al
1939 con l’unica eccezione un brano datato 1956 cantato da Furry LEWIS. Questi
dischi sono divisi per Blues Rurale, Urbano e Jazzistico e sono eseguiti da
artisti a me
 si sono
improvvisati esperti di blues appena questo è venuto di moda e che ne parlano e
soprattutto ne scrivono senza averne la conoscenza adeguata. D’altronde A.R. non
è la prima persona che anticipa un “qualcosa” ed è ignorato fino a quando quel
“qualcosa”, diventato di moda, viene dottamente trattato da proprio da coloro i
quali lo avevano precedentemente snobbato.
si sono
improvvisati esperti di blues appena questo è venuto di moda e che ne parlano e
soprattutto ne scrivono senza averne la conoscenza adeguata. D’altronde A.R. non
è la prima persona che anticipa un “qualcosa” ed è ignorato fino a quando quel
“qualcosa”, diventato di moda, viene dottamente trattato da proprio da coloro i
quali lo avevano precedentemente snobbato.  cosa potevano fare adesso questi poveri
disgraziati per vivere? Certo che in Africa non potevano tornare, visto che
l’America è un “Grande Paese” non rimaneva altro che la possibilità di emigrare.
Questa volta però non c’erano i mercanti di schiavi a trasportali su veloci
imbarcazioni; potevano viaggiare liberamente all’interno del “Grande Paese” nei
vagoni dei treni merci.
cosa potevano fare adesso questi poveri
disgraziati per vivere? Certo che in Africa non potevano tornare, visto che
l’America è un “Grande Paese” non rimaneva altro che la possibilità di emigrare.
Questa volta però non c’erano i mercanti di schiavi a trasportali su veloci
imbarcazioni; potevano viaggiare liberamente all’interno del “Grande Paese” nei
vagoni dei treni merci. Ricordo
come fosse ieri l’ottobre del 2002 quando, con "Gocce Di Blues", aprimmo allo
Sly di Napoli il concerto dei messinesi “King Biscuit Time”, band in cui suonava
Michele Lotta. Prima del concerto parlammo a lungo del blues, in particolare di
quello Italiano. Le argomentazioni su cui il confronto si concentrò maggiormente
furono le problematiche relative alle attività bluesistiche italiane,
penalizzate più che mai sotto il profilo culturale; in particolare si parlò di
un articolo pubblicato su "Musica" allegato di "La Repubblica" intitolato
"Spaghetti Blues" dal quale si evinceva una palese critica nei confronti dei
musicisti italiani accusati di scimmiottare
gli stili americani e inglesi tranne, ovviamente, qualche rara eccezione
riferita ai più noti bluesman italiani. Evidentemente il giornalista che
scriveva non aveva allora l’esatta percezione del movimento bluesistico
italiano, tuttavia quelle poche righe stimolarono un salutare dibattito che si
concluse con la nascita di un nuovo movimento anche se quella sera ancora non lo
sapevamo. Insomma quella provocazione editoriale mosse ulteriormente le acque.
Ricordo
come fosse ieri l’ottobre del 2002 quando, con "Gocce Di Blues", aprimmo allo
Sly di Napoli il concerto dei messinesi “King Biscuit Time”, band in cui suonava
Michele Lotta. Prima del concerto parlammo a lungo del blues, in particolare di
quello Italiano. Le argomentazioni su cui il confronto si concentrò maggiormente
furono le problematiche relative alle attività bluesistiche italiane,
penalizzate più che mai sotto il profilo culturale; in particolare si parlò di
un articolo pubblicato su "Musica" allegato di "La Repubblica" intitolato
"Spaghetti Blues" dal quale si evinceva una palese critica nei confronti dei
musicisti italiani accusati di scimmiottare
gli stili americani e inglesi tranne, ovviamente, qualche rara eccezione
riferita ai più noti bluesman italiani. Evidentemente il giornalista che
scriveva non aveva allora l’esatta percezione del movimento bluesistico
italiano, tuttavia quelle poche righe stimolarono un salutare dibattito che si
concluse con la nascita di un nuovo movimento anche se quella sera ancora non lo
sapevamo. Insomma quella provocazione editoriale mosse ulteriormente le acque.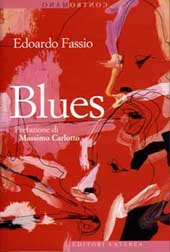 “Catfish,
il vostro Blue-Jay preferito!”, questa è la frase di rito con cui Edoardo, dal
1984, si presenta al pubblico radiofonico proponendo programmazioni di blues e
musica “nera” più in generale. La dialettica, lo spirito sempre giovane e la
profonda conoscenza del genere, sono da sempre l’anima del suo successo. Hanno
goduto della sua voce un gran numero di emittenti radio di tutta Europa, in
particolare la Rai, Radio Flash e Radio Torino Popolare ma anche emittenti
U.S.A. come la KDHX di St. Louis e la WROX di Clarksdale, Delta del Mississippi.
Scrive di blues, folk e jazz per i quotidiani: “La Stampa”, “TorinoSette” e “Il
Blues”, oltre che per un numero imprecisato di riviste europee.
“Catfish,
il vostro Blue-Jay preferito!”, questa è la frase di rito con cui Edoardo, dal
1984, si presenta al pubblico radiofonico proponendo programmazioni di blues e
musica “nera” più in generale. La dialettica, lo spirito sempre giovane e la
profonda conoscenza del genere, sono da sempre l’anima del suo successo. Hanno
goduto della sua voce un gran numero di emittenti radio di tutta Europa, in
particolare la Rai, Radio Flash e Radio Torino Popolare ma anche emittenti
U.S.A. come la KDHX di St. Louis e la WROX di Clarksdale, Delta del Mississippi.
Scrive di blues, folk e jazz per i quotidiani: “La Stampa”, “TorinoSette” e “Il
Blues”, oltre che per un numero imprecisato di riviste europee. Conoscere
Big Bill Morganfield è stata un’occasione unica per avvicinarsi al Blues per il
tramite di una nobile discendenza. Un felice ed interessante
momento di digressione musical-culinaria che ha portato i commensali a
pasteggiare allegramente valutando, tra un boccone ed un sorso di birra, certi
aspetti del Blues contemporaneo.
Conoscere
Big Bill Morganfield è stata un’occasione unica per avvicinarsi al Blues per il
tramite di una nobile discendenza. Un felice ed interessante
momento di digressione musical-culinaria che ha portato i commensali a
pasteggiare allegramente valutando, tra un boccone ed un sorso di birra, certi
aspetti del Blues contemporaneo. Big Bill, classe 1956, non ama parlare molto del padre che ha conosciuto
soltanto all’età di 18 anni. Nato da una relazione tra Mary Austin, una ragazza
della Florida all’epoca diciannovenne, e Muddy, BB è cresciuto con la madre che,
incinta ed al culmine di una relazione burrascosa, fuggì letteralmente da
Chicago portandolo con se.
Big Bill, classe 1956, non ama parlare molto del padre che ha conosciuto
soltanto all’età di 18 anni. Nato da una relazione tra Mary Austin, una ragazza
della Florida all’epoca diciannovenne, e Muddy, BB è cresciuto con la madre che,
incinta ed al culmine di una relazione burrascosa, fuggì letteralmente da
Chicago portandolo con se. 
 Esiste un prodotto tipico poco conosciuto
nell’Abruzzo dei Parchi, dello zafferano e della pecora alla còttora. Non è
Esiste un prodotto tipico poco conosciuto
nell’Abruzzo dei Parchi, dello zafferano e della pecora alla còttora. Non è
 tutelato da marchi DOC e consorzi, non si organizzano per esso convegni e
seminari, non è compreso nelle guide alle sagre spesse come elenchi telefonici.
Parliamo del blues e ne è testimonianza il gran numero di band giovanili, di
appassionati e di festival. Sarà perché l’Abruzzo è anche una terra di emigranti
e “blues” è stata la loro storia (con la esse maiuscola) fatta di sofferenza e
sudore. Anche loro, come chi inventò il blues nelle piantagioni di cotone del Mississipi, impararono a sbarcare il lunario con il pane dell’autoironia e con
l’arte di trasformare il dolore in poesia, la rabbia in canto. Tra i vari
festival particolarmente interessante è Abruzzo nel blues, che quest’estate ha
fatto tappa a Pescara, Lanciano e Campli, portando gratuitamente grandi
musicisti come Billy Branch, Sharon Lewis, Thornetta Davis, Phil Guy, Enrico
Crivellaro. Ma chi ha lasciato il segno, soprattutto nel cuore della gente
semplice, è stato forse Chris Cain. Per la prima volta in Italia è considerato
da molti una delle più grandi chitarre blues in circolazione, addirittura
l’erede di Albert King, suo amico e maestro. Lo abbiamo incontrato a Campli, in
un caldo pomeriggio, intento a bere l’ennesima birra della giornata e a
chiacchierare divertito con gli anziani del paese, senza capire poi molto del
colorito slang locale. La globalizazione che ci piace.
tutelato da marchi DOC e consorzi, non si organizzano per esso convegni e
seminari, non è compreso nelle guide alle sagre spesse come elenchi telefonici.
Parliamo del blues e ne è testimonianza il gran numero di band giovanili, di
appassionati e di festival. Sarà perché l’Abruzzo è anche una terra di emigranti
e “blues” è stata la loro storia (con la esse maiuscola) fatta di sofferenza e
sudore. Anche loro, come chi inventò il blues nelle piantagioni di cotone del Mississipi, impararono a sbarcare il lunario con il pane dell’autoironia e con
l’arte di trasformare il dolore in poesia, la rabbia in canto. Tra i vari
festival particolarmente interessante è Abruzzo nel blues, che quest’estate ha
fatto tappa a Pescara, Lanciano e Campli, portando gratuitamente grandi
musicisti come Billy Branch, Sharon Lewis, Thornetta Davis, Phil Guy, Enrico
Crivellaro. Ma chi ha lasciato il segno, soprattutto nel cuore della gente
semplice, è stato forse Chris Cain. Per la prima volta in Italia è considerato
da molti una delle più grandi chitarre blues in circolazione, addirittura
l’erede di Albert King, suo amico e maestro. Lo abbiamo incontrato a Campli, in
un caldo pomeriggio, intento a bere l’ennesima birra della giornata e a
chiacchierare divertito con gli anziani del paese, senza capire poi molto del
colorito slang locale. La globalizazione che ci piace. Ho pensato che forse era il caso di raccontarvi un po’ di cose su questa bella
avventura, non si sa mai che qualcuno si trovi a passare da quelle parti.
Infatti, non a caso, nel mio racconto, come noterete, se non vi siete già
annoiati, ho specificato orari, voli, date, indicazioni stradali, ecc..
Ho pensato che forse era il caso di raccontarvi un po’ di cose su questa bella
avventura, non si sa mai che qualcuno si trovi a passare da quelle parti.
Infatti, non a caso, nel mio racconto, come noterete, se non vi siete già
annoiati, ho specificato orari, voli, date, indicazioni stradali, ecc.. Sono rimasto incantato, non tanto dalla tecnica e il virtuosismo che questi
“maestri di strada” possedevano, uniche qualità che noi italiani, purtroppo per
cattiva abitudine qualche volta riusciamo a notare, ma dal groove che a questa
gente gli sprizza dalla pelle, poche note ma di effetto (come dice il mio amico
Mc Carp); il loro è un continuo narrare storie, fare battute che, anche se non
riesci a capire per motivi linguistici, ne intuisci comunque il senso,
coinvolgendoti emotivamente.
Sono rimasto incantato, non tanto dalla tecnica e il virtuosismo che questi
“maestri di strada” possedevano, uniche qualità che noi italiani, purtroppo per
cattiva abitudine qualche volta riusciamo a notare, ma dal groove che a questa
gente gli sprizza dalla pelle, poche note ma di effetto (come dice il mio amico
Mc Carp); il loro è un continuo narrare storie, fare battute che, anche se non
riesci a capire per motivi linguistici, ne intuisci comunque il senso,
coinvolgendoti emotivamente. almeno il
primo, e ho speso poco, circa 10 dollari per una pietanza: il “Quartino” (ve lo
consiglio vivamente perché se un domani vorrete recarvi da queste parti,
scoprirete che trovare un posto in America dove si possa mangiare qualcosa di
“commestibile”, è come fare un terno al lotto!).
almeno il
primo, e ho speso poco, circa 10 dollari per una pietanza: il “Quartino” (ve lo
consiglio vivamente perché se un domani vorrete recarvi da queste parti,
scoprirete che trovare un posto in America dove si possa mangiare qualcosa di
“commestibile”, è come fare un terno al lotto!).  Mi sono quindi recato al bar per bere una birra. Al bancone era seduto su uno
sgabello il proprietario del posto! Lì per lì, sono rimasto un po’ sorpreso, sai
non ti capita tutti i giorni di farti una birra e incontrare Buddy Guy! Dopo
aver chiesto conferma al barista che si trattasse proprio di lui, mi sono
avvicinato a Buddy chiedendogli come andasse la vita. Lui, capelli a zero, molto
dimagrito, mi ha guardato (sicuramente pensando: ma chi cavolo è questo! Tipico
modo di porsi nostrano!) e mi ha ricambiato caldamente il saluto; al che, preso
coraggio, ho cercato di intraprendere una piccola conversazione con lui. Gli ho
detto che ero uno spaghettaro, facendogli capire che non facevo lo chef, ma
appartenevo al movimento di cultura blues italiano (Spaghetti & Blues), che
avevo una blues band e che ero andato a Chicago, proprio lì, per vedere uno dei
mostri sacri del blues ancora in vita; lui mi ha dato una pacca sulla spalla
dicendomi: you are very, very, crazy! you like the blues? D’istinto gli ho
risposto: Buddy, I don’t like the blues, I have the blues!. Lui è rimasto
colpito da questa mia risposta e dandomi il “cinque” mi ha detto di gioire
perché il blues mi aveva trovato. Mentre parlavamo c’era parecchia gente che
veniva a farsi autografare t-shirt, cd, ecc.. quindi non è stato molto facile
capire tutto quello che mi diceva. Dopo un po’, visto che ero di ingombro alla
gente che gli si avvicinava, mi sono allontanato. Buddy, con mio sommo stupore,
ha preso un suo cd dicendomi: this is a present for you! E’ stato per me come
ricevere lo Spirito Santo!
Mi sono quindi recato al bar per bere una birra. Al bancone era seduto su uno
sgabello il proprietario del posto! Lì per lì, sono rimasto un po’ sorpreso, sai
non ti capita tutti i giorni di farti una birra e incontrare Buddy Guy! Dopo
aver chiesto conferma al barista che si trattasse proprio di lui, mi sono
avvicinato a Buddy chiedendogli come andasse la vita. Lui, capelli a zero, molto
dimagrito, mi ha guardato (sicuramente pensando: ma chi cavolo è questo! Tipico
modo di porsi nostrano!) e mi ha ricambiato caldamente il saluto; al che, preso
coraggio, ho cercato di intraprendere una piccola conversazione con lui. Gli ho
detto che ero uno spaghettaro, facendogli capire che non facevo lo chef, ma
appartenevo al movimento di cultura blues italiano (Spaghetti & Blues), che
avevo una blues band e che ero andato a Chicago, proprio lì, per vedere uno dei
mostri sacri del blues ancora in vita; lui mi ha dato una pacca sulla spalla
dicendomi: you are very, very, crazy! you like the blues? D’istinto gli ho
risposto: Buddy, I don’t like the blues, I have the blues!. Lui è rimasto
colpito da questa mia risposta e dandomi il “cinque” mi ha detto di gioire
perché il blues mi aveva trovato. Mentre parlavamo c’era parecchia gente che
veniva a farsi autografare t-shirt, cd, ecc.. quindi non è stato molto facile
capire tutto quello che mi diceva. Dopo un po’, visto che ero di ingombro alla
gente che gli si avvicinava, mi sono allontanato. Buddy, con mio sommo stupore,
ha preso un suo cd dicendomi: this is a present for you! E’ stato per me come
ricevere lo Spirito Santo!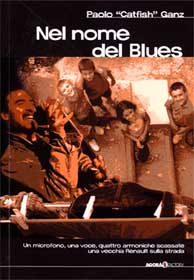 "Nel
nome del Blues" è il nuovo libro di Paolo “Catfish” Ganz edito dalla Agorà
Factory e pubblicato nel dicembre 2006. Paolo, musicista e appassionato di
letteratura (vedi archivio Interviste), dichiarava nel 2003 a S&B: “Scrivere è sempre stata
una mia grandissima passione. Ho iniziato raccogliendo delle storie di Blues,
naturalmente, cose accadute realmente, aneddoti, ricordi, pensieri. Poi, ho
ampliato la visione cominciando a raccontare di personaggi femminili,
conosciuti, romanzati o del tutto inventati. Così questo lavoro (che stando ai
miei tempi uscirà tra dieci anni), sarà una breve raccolta di racconti legati,
appunto, a caratteri di donne…”. Ed ecco, finalmente in veste editoriale,
sedici storie che hanno come sfondo le sue più curiose avventure di musicista
ambientate nella "sua" Venezia e nei dintorni.
"Nel
nome del Blues" è il nuovo libro di Paolo “Catfish” Ganz edito dalla Agorà
Factory e pubblicato nel dicembre 2006. Paolo, musicista e appassionato di
letteratura (vedi archivio Interviste), dichiarava nel 2003 a S&B: “Scrivere è sempre stata
una mia grandissima passione. Ho iniziato raccogliendo delle storie di Blues,
naturalmente, cose accadute realmente, aneddoti, ricordi, pensieri. Poi, ho
ampliato la visione cominciando a raccontare di personaggi femminili,
conosciuti, romanzati o del tutto inventati. Così questo lavoro (che stando ai
miei tempi uscirà tra dieci anni), sarà una breve raccolta di racconti legati,
appunto, a caratteri di donne…”. Ed ecco, finalmente in veste editoriale,
sedici storie che hanno come sfondo le sue più curiose avventure di musicista
ambientate nella "sua" Venezia e nei dintorni. Pubblichiamo, di seguito, l'intervista a
John Mayall, celebre bluesman e polistrumentista meglio conosciuto come il
padre spirituale del "brithish blues".
Pubblichiamo, di seguito, l'intervista a
John Mayall, celebre bluesman e polistrumentista meglio conosciuto come il
padre spirituale del "brithish blues".  bastasse,
con il passare del tempo e l’apprendimento di vari punti di vista degli esperti
del Chicago Style, le idee mi si sono ulteriormente confuse… In passato, ogni volta
che si suonava il Chicago Blues, attaccavo il mio microfono direttamente
all’impianto tramite un vecchio pedale e lasciavo a Renato Petrelli (chitarrista
e fonico), l’onere di regolare livelli e pedale (me ne prestava uno “vintage”
per chitarra) affinché le mie note piegate rendessero al meglio l’idea del
Chicago Style… uno stratagemma sicuramente economico seppur di modesti
risultati, anche se devo ammettere che in più di un’occasione qualche musicista,
dopo il concerto, mi chiedeva dove fosse il “valvolare” e
bastasse,
con il passare del tempo e l’apprendimento di vari punti di vista degli esperti
del Chicago Style, le idee mi si sono ulteriormente confuse… In passato, ogni volta
che si suonava il Chicago Blues, attaccavo il mio microfono direttamente
all’impianto tramite un vecchio pedale e lasciavo a Renato Petrelli (chitarrista
e fonico), l’onere di regolare livelli e pedale (me ne prestava uno “vintage”
per chitarra) affinché le mie note piegate rendessero al meglio l’idea del
Chicago Style… uno stratagemma sicuramente economico seppur di modesti
risultati, anche se devo ammettere che in più di un’occasione qualche musicista,
dopo il concerto, mi chiedeva dove fosse il “valvolare” e
 come riuscissi a
modulare quei suoni così “Chicago old time”. Ovviamente la mia risposta era vaga
e scaricavo a Renato la responsabilità di una risposta più tecnica. Oggi,
ovviamente, se dovessi entrare a far parte di una Chicago Blues Band non potrei
non avere un ampli valvolare anche se il mio amico Renato insiste con il volermi
prestare a tutti i costi il suo vecchio pedale per chitarra affermando la
raffinata teoria che “Pè fà ù Chicago Bluss c’è vole a sustanze no le pugnett!”,
(traduzione dal tarantino: “Per eseguire brani in stile Chicago Blues, è più
importante possedere il giusto groove, senza pensare troppo a particolari che
potrebbero rivelarsi poco importanti!”).
come riuscissi a
modulare quei suoni così “Chicago old time”. Ovviamente la mia risposta era vaga
e scaricavo a Renato la responsabilità di una risposta più tecnica. Oggi,
ovviamente, se dovessi entrare a far parte di una Chicago Blues Band non potrei
non avere un ampli valvolare anche se il mio amico Renato insiste con il volermi
prestare a tutti i costi il suo vecchio pedale per chitarra affermando la
raffinata teoria che “Pè fà ù Chicago Bluss c’è vole a sustanze no le pugnett!”,
(traduzione dal tarantino: “Per eseguire brani in stile Chicago Blues, è più
importante possedere il giusto groove, senza pensare troppo a particolari che
potrebbero rivelarsi poco importanti!”). Io personalmente non ho trovato soddisfacente nessuno degli amplificatori
valvolari moderni che si possono trovare qui in Italia; per questo ho deciso
tanti anni fa di costruirmi da solo un amplificatore specifico per armonica; il
mio scopo era quello di ottenere il suono che si sente in alcuni dischi di
Little Walter; dopo tanti anni di sperimentazione, prendendo ispirazione da
famosi amplificatori vintage, sono riuscito ad ottenere il suono che volevo.
Pian piano anche alcuni miei amici armonicisti hanno voluto che gli costruissi
io l'ampli e di recente ho cominciato a venderli in tutta Italia. Voglio
sottolineare che i miei amplificatori sono completamente artigianali; perfino i
trasformatori sono avvolti da me.
Io personalmente non ho trovato soddisfacente nessuno degli amplificatori
valvolari moderni che si possono trovare qui in Italia; per questo ho deciso
tanti anni fa di costruirmi da solo un amplificatore specifico per armonica; il
mio scopo era quello di ottenere il suono che si sente in alcuni dischi di
Little Walter; dopo tanti anni di sperimentazione, prendendo ispirazione da
famosi amplificatori vintage, sono riuscito ad ottenere il suono che volevo.
Pian piano anche alcuni miei amici armonicisti hanno voluto che gli costruissi
io l'ampli e di recente ho cominciato a venderli in tutta Italia. Voglio
sottolineare che i miei amplificatori sono completamente artigianali; perfino i
trasformatori sono avvolti da me. 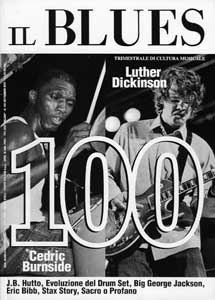 Tanti Auguri a Marino Grandi e a tutto lo Staff
della storica rivista trimestrale italiana "IL BLUES" che ha raggiunto, in
venticinque anni di attività, il fatidico n° 100. Cento numeri che racchiudono la
documentazione, decisamente accurata, di quello che nel Blues è accaduto nell'ultimo
quarto di secolo in America, in Europa e in Italia. In terza pagina Marino
ringrazia tutti, sia i lettori dal n.1 (primo abbonamento) che quelli dal n. 97
(ultimo abbonamento); lo fa a suo modo, sintetico e senza troppe menate autocommemorative puntando tutto, come sempre, sulla sostanza
di cui è
particolarmente densa la centesima pubblicazione.
Tanti Auguri a Marino Grandi e a tutto lo Staff
della storica rivista trimestrale italiana "IL BLUES" che ha raggiunto, in
venticinque anni di attività, il fatidico n° 100. Cento numeri che racchiudono la
documentazione, decisamente accurata, di quello che nel Blues è accaduto nell'ultimo
quarto di secolo in America, in Europa e in Italia. In terza pagina Marino
ringrazia tutti, sia i lettori dal n.1 (primo abbonamento) che quelli dal n. 97
(ultimo abbonamento); lo fa a suo modo, sintetico e senza troppe menate autocommemorative puntando tutto, come sempre, sulla sostanza
di cui è
particolarmente densa la centesima pubblicazione. La funzione ritmico armonica del basso nel blues vede probabilmente le sue
origini nelle marching band di New Orleans dove tale parte era affidata al basso
tuba o al sousaphone. Essendo gruppi che si esibivano in movimento per
accompagnare feste , funerali o parate, la parte ritmica doveva essere svolta da
uno strumento a fiato trasportabile insieme alle percussioni come nelle migliori
tradizioni delle grandi marching band militari della fine dell’ottocento. Tra le
bande militari da segnalare quella di John Philip Sousa che fu anche l’inventore
del sousaphone sopra citato, ovvero una tuba da parata, più facile da
trasportare che da lui prese il nome. Tale strumento che tuttora viene
utilizzato nelle band dixie o nelle marching band di New Orleans, svolge la
stessa funzione del “nostro” basso a corde ed alcuni strumentisti di oggi, come
Kirk Joseph della Dirty Dozen Brass Band, riescono a suonarlo con grande
maestria.
La funzione ritmico armonica del basso nel blues vede probabilmente le sue
origini nelle marching band di New Orleans dove tale parte era affidata al basso
tuba o al sousaphone. Essendo gruppi che si esibivano in movimento per
accompagnare feste , funerali o parate, la parte ritmica doveva essere svolta da
uno strumento a fiato trasportabile insieme alle percussioni come nelle migliori
tradizioni delle grandi marching band militari della fine dell’ottocento. Tra le
bande militari da segnalare quella di John Philip Sousa che fu anche l’inventore
del sousaphone sopra citato, ovvero una tuba da parata, più facile da
trasportare che da lui prese il nome. Tale strumento che tuttora viene
utilizzato nelle band dixie o nelle marching band di New Orleans, svolge la
stessa funzione del “nostro” basso a corde ed alcuni strumentisti di oggi, come
Kirk Joseph della Dirty Dozen Brass Band, riescono a suonarlo con grande
maestria.  questo strumento
ancestrale bisognava tirare con forza la corda ( meglio usare i guanti per non
distruggersi le mani !) mentre cambiando l’angolazione del manico si cambiava
l’altezza delle note. La tinozza faceva da cassa armonica. Da questo
probabilmente deriva un modo molto ritmico di suonare il contrabbasso che viene
da alcuni chiamato lo slap (che verrà poi ripreso anche sul basso elettrico
funky) . Questa tecnica, molto usata anche nella musica popolare dei bianchi
(country,bluegrass, hillibilly), consisteva nel tirare la corda con forza verso
l’alto mentre la si pizzica creando così un effetto ritmico al suo rimbalzo
contro il manico. Tale utilizzo era molto efficace proprio quando il bassista
doveva accompagnare un solista senza l’ausilio di una batteria. Un grande
esecutore di questa tecnica, è stato Big Ernest Crawford che si può ascoltare
nelle prime incisioni di Muddy Waters per la Chess di fina anni ’40 (I can’t be
satisfied o Rollin’ and Tumblin) . Se vi appassionate a questa tecnica è
essenziale dare una occhiata ai grandi bassisti bluegrass (fanno addirittura un
“ triple slap”) ed ai contrabbassisti rockabilly che ne hanno fatto un vero e
proprio marchio di fabbrica (ne cito uno famoso: Lee Rocker ex Straycats).
questo strumento
ancestrale bisognava tirare con forza la corda ( meglio usare i guanti per non
distruggersi le mani !) mentre cambiando l’angolazione del manico si cambiava
l’altezza delle note. La tinozza faceva da cassa armonica. Da questo
probabilmente deriva un modo molto ritmico di suonare il contrabbasso che viene
da alcuni chiamato lo slap (che verrà poi ripreso anche sul basso elettrico
funky) . Questa tecnica, molto usata anche nella musica popolare dei bianchi
(country,bluegrass, hillibilly), consisteva nel tirare la corda con forza verso
l’alto mentre la si pizzica creando così un effetto ritmico al suo rimbalzo
contro il manico. Tale utilizzo era molto efficace proprio quando il bassista
doveva accompagnare un solista senza l’ausilio di una batteria. Un grande
esecutore di questa tecnica, è stato Big Ernest Crawford che si può ascoltare
nelle prime incisioni di Muddy Waters per la Chess di fina anni ’40 (I can’t be
satisfied o Rollin’ and Tumblin) . Se vi appassionate a questa tecnica è
essenziale dare una occhiata ai grandi bassisti bluegrass (fanno addirittura un
“ triple slap”) ed ai contrabbassisti rockabilly che ne hanno fatto un vero e
proprio marchio di fabbrica (ne cito uno famoso: Lee Rocker ex Straycats).  reperire, ricordo solamente
che, oltre ad essere compositore, talent scout, arrangiatore e produttore, il
nostro uomo ha suonato in moltissimi brani della Chess accompagnando artisti
come Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Bo Diddley, Little Walter, Sonny Boy Williamson
e molti altri. Il suo modo di suonare il contrabbasso è quindi per forza di cose
un punto di riferimento per ogni bassista che si voglia cimentare con il blues.
reperire, ricordo solamente
che, oltre ad essere compositore, talent scout, arrangiatore e produttore, il
nostro uomo ha suonato in moltissimi brani della Chess accompagnando artisti
come Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Bo Diddley, Little Walter, Sonny Boy Williamson
e molti altri. Il suo modo di suonare il contrabbasso è quindi per forza di cose
un punto di riferimento per ogni bassista che si voglia cimentare con il blues.
 Basso elettrico e contrabbasso sono comunque
gli strumenti più utilizzati
nel blues e, benchè molto simili, hanno caratteristiche “diverse” giacchè diverso
ne è il suono, l'intenzione, l'approccio e la tecnica. Entrambi hanno la stessa
intonazione, infatti il loro suono reale è un'ottava sotto a quello scritto sul
pentagramma, un'ottava sotto alle quattro corde più basse di una normale
chitarra a sei corde. Come alcuni contrabbassi, ci sono bassi elettrici a cinque
corde (alcuni addirittura a sei corde), la più grave delle quali è intonata sul
si o sul do sotto il rigo di basso. La maggior parte dei bassisti e
contrabbassisti usano uno strumento accordato in quarte (mi, la, re, sol per i
bassi a quattro corde). Pochissimi, fra tutti basti citare per il passato il
contrabbassista jazz Red Mitchell, ricorrono all'accordatura per quinte (do,
sol, re, la sempre per i bassi a quattro corde) che produce evidentemente
un'ottava più bassa.
Basso elettrico e contrabbasso sono comunque
gli strumenti più utilizzati
nel blues e, benchè molto simili, hanno caratteristiche “diverse” giacchè diverso
ne è il suono, l'intenzione, l'approccio e la tecnica. Entrambi hanno la stessa
intonazione, infatti il loro suono reale è un'ottava sotto a quello scritto sul
pentagramma, un'ottava sotto alle quattro corde più basse di una normale
chitarra a sei corde. Come alcuni contrabbassi, ci sono bassi elettrici a cinque
corde (alcuni addirittura a sei corde), la più grave delle quali è intonata sul
si o sul do sotto il rigo di basso. La maggior parte dei bassisti e
contrabbassisti usano uno strumento accordato in quarte (mi, la, re, sol per i
bassi a quattro corde). Pochissimi, fra tutti basti citare per il passato il
contrabbassista jazz Red Mitchell, ricorrono all'accordatura per quinte (do,
sol, re, la sempre per i bassi a quattro corde) che produce evidentemente
un'ottava più bassa.  passaggi cromatici. Di lui, segnalo fra
tutti un disco: “Hoodoo man blues“ di Junior Wells. Potete vederne alcune
immagini nell’American Folk Blues Festival del 1966 dove sostituisce Willie
Dixon nella house band.
passaggi cromatici. Di lui, segnalo fra
tutti un disco: “Hoodoo man blues“ di Junior Wells. Potete vederne alcune
immagini nell’American Folk Blues Festival del 1966 dove sostituisce Willie
Dixon nella house band. da
un chitarrista e con l’amplificazione adeguata aveva un suono molto più potente. Robert Stroger
ha suonato con Eddie King, Otis
Rush, col pianista Sunnyland Slim (per circa 15anni), con Jimmy Rogers, con i
Mississippi Heat, partecipando ad un'infinità di registrazioni.
da
un chitarrista e con l’amplificazione adeguata aveva un suono molto più potente. Robert Stroger
ha suonato con Eddie King, Otis
Rush, col pianista Sunnyland Slim (per circa 15anni), con Jimmy Rogers, con i
Mississippi Heat, partecipando ad un'infinità di registrazioni.  Appena arrivato a Chicago nel 1947 – dove prese il soprannome di Fuzz – conosce Muddy Waters. Calvin ha ricordato una volta di essere stato un giorno
letteralmente attirato come da una calamita dal suono slide tagliente di Muddy,
che stava suonando una chitarra acustica a cui era stato applicato un pick-up,
accompagnato solo da un armonicista. Dopo poco, Calvin inizia a frequentare anche Little Walter e Jimmy Rogers suonando a volte con loro
nelle varie gare di blues bands nei locali del South Side.
Appena arrivato a Chicago nel 1947 – dove prese il soprannome di Fuzz – conosce Muddy Waters. Calvin ha ricordato una volta di essere stato un giorno
letteralmente attirato come da una calamita dal suono slide tagliente di Muddy,
che stava suonando una chitarra acustica a cui era stato applicato un pick-up,
accompagnato solo da un armonicista. Dopo poco, Calvin inizia a frequentare anche Little Walter e Jimmy Rogers suonando a volte con loro
nelle varie gare di blues bands nei locali del South Side. Johnson, un
pioniere della chitarra jazz e blues ed anche banjoista che viveva nel
seminterrato della casa dei Myers.
Johnson, un
pioniere della chitarra jazz e blues ed anche banjoista che viveva nel
seminterrato della casa dei Myers.